Fotografe! in mostra a Firenze
Poter guardare da vicino le stampe vintage degli Archivi Alinari non è cosa da poco, un brivido notevole prendere coscienza, tutto in una volta, dei passi fondamentali della fotografia dall’Ottocento a oggi. Il tema della mostra, che si sviluppa tra Villa Bardini e Forte Belvedere a Firenze per la cura di Emanuela Sesti e Walter Guadagnini, è ravvisabile fin dal semplice titolo, Fotografe!, e cavalca sicuramente attenzioni recenti: la donna nella storia della fotografia ha avuto un ruolo eccezionale, migliaia di negativi conservati soltanto agli Alinari sono un esempio chiaro, ed è forse ora che qualche nome in più venga portato a galla.
Simile all’antologia Donne fotografe edita da Contrasto sempre quest’anno, l’antologia in questa sede è visiva, circoscritta a un archivio solo, ma con uguale ambizione. Come in tutte le antologie, si prepara il terreno nella speranza che possano poi nascere interessi tanto strutturati da poter aprire o riaprire interi studi sull’opera omnia di questo o quell’altro autore. Ora sul tavolo c’è tutto il mazzo, e si inizia a prendere confidenza con nomi e cognomi finora sconosciuti. Questa operazione, di per sé, ha una base perfetta nella sua perfetta innocenza, quella di poter consacrare l’autorialità femminile in una delle arti più giovani, e funziona in ogni caso: il solo fatto di aprire gli occhi su di uno spaccato della fotografia è punto a favore della pura ricerca, al di là di ogni intenzione morale o politica.
Un secondo effetto che una panoramica antologica può generare, è quello di poter cogliere con un rapido sguardo le tendenze stilistiche principali di un certo gruppo di attori di una disciplina, per poterle collegare a quelle immediatamente successive come a quelle contemporanee. L’equazione che appare già dalle prime sale è l’evidente attenzione al volto, al ritratto, al sociale, al familiare.

Il percorso temporale di riferimenti che il visitatore può intraprendere partendo dal punto in cui ci trasporta la mostra è sia all’indietro che in avanti: “Ritratto femminile in abito da lavoro di cameriera” di Adele Perlmutter (1874-76) è preludio diretto ai lavori successivi di August Sander o Irving Penn rivolti alla catalogazione dei mestieri e dei ceti sociali, scia poetica ravvisabile fino al più recente esempio di Augusto Cantamessa (1927-2018); mentre “Dannunziana” di Wanda Wulz (1931 ca.), autrice soggetto a maggiore attenzione in mostra insieme alla sorella Marion e a Edith Arnaldi (in arte Rosa Rosà), rievoca quale fosse l’immaginario di partenza per molti e molte all’epoca, di quanto la letteratura fosse in grado di spingere alla visualizzazione di personaggi e atmosfere, fino al loro pieno manifestarsi nel cinema.

Come nell’antologia di Contrasto, forse per comune intuizione, il primo passo della mostra viene intitolato “Le pioniere”, a indicare i primi esempi di dagherrotipi realizzati da fotografe donne. Una serie di ritratti di piccole dimensioni e dipinti a mano successivamente solleva la semplice intuitività dei primi esperimenti, la piccola dimensione man mano divenuta insufficiente, il bisogno del ricordo reale trasformato in seguito in quello del mito, della trasfigurazione, dell’allegoria.

Diverso, infatti, è l’impatto col “Giovane ragazzo” (1865 ca.) della già nota fotografa di epoca vittoriana Julia Margaret Cameron o con “Newa” (1930 ca.) di Wanda Wulz, in cui il soggetto inizia a subire l’esigenza di un anonimato diverso, di essere rappresentazione astratta di un’idea più che di un volto davvero carnale.
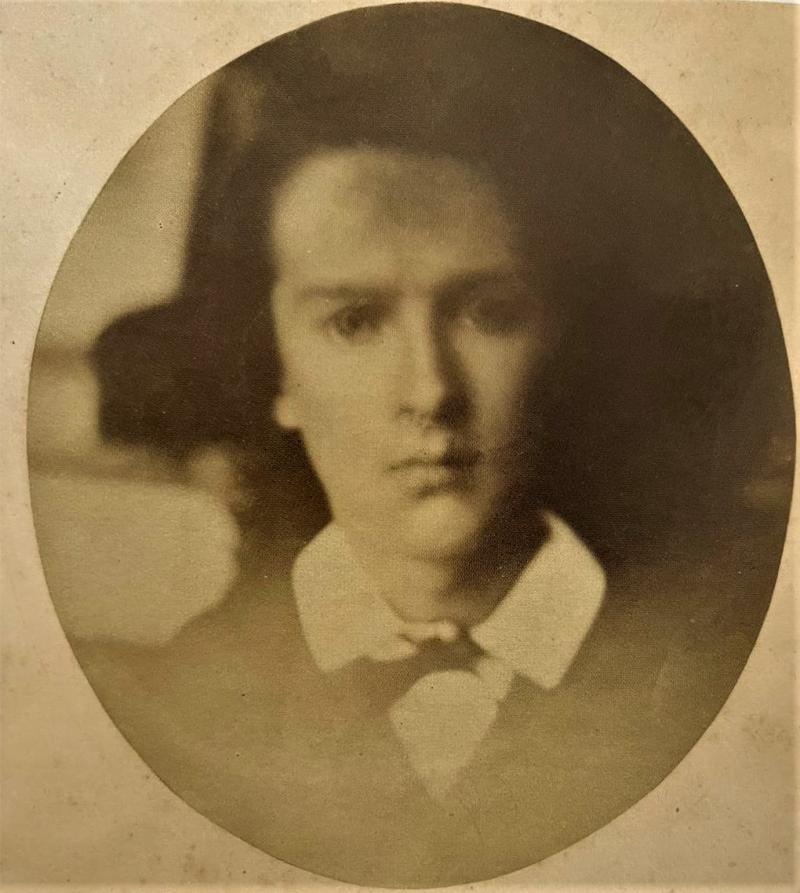

Altrettanto affascinante è poter cogliere come la poetica di alcune autrici venisse sviluppata e su quali espedienti si focalizzasse, scoprendo intuizioni di una raffinatezza che tanto ha da insegnare ancora oggi, come nell’immagine “Solarized Calla Lilies” di Carlotta Corpron (1948), in cui emerge dalla carta bianca una forma più bianca ancora come i petali delle calle, “sporcata” con un accenno d’ombre dato dalla solarizzazione per farne cogliere i contorni e le pieghe. Forse il fine di una mostra così strutturata, che tanto offre ma poco d’ogni opera vuole e può narrare, vuol proprio portare il visitatore a diventare per un momento ricercatore, farlo partire da un dato circoscritto e vedere dove può condurlo. Un esempio per tutti, approfondendo quel poco, della Corpron si scopre essere stata pupilla di Alfred Stieglitz, nonché foriera dello stile astratto in fotografia che condizionò a seguire molti altri autori statunitensi.
Come insieme diversificato di sussulti, ci si trova di fronte alla libertà totale di collegamento e di narrazione, sapendo che ogni strada sarà in qualche modo corretta: si può tradurre l’operazione compiuta dalla mostra come atto dovuto alle autrici dimenticate, come monito per il presente, o come semplice dono di conoscenza scevro di direzioni precise, come atto dovuto più alla fotografia in sé, come arte tanto oggi maneggiata quanto poco ancora davvero sviscerata.
Diverso il discorso per gli esempi contemporanei: dieci fotografe nate dopo gli anni ‘80 dialogano per scelta curatoriale con alcune delle autrici riscoperte, tracciando in maniera netta il percorso che dal punto zero è stato compiuto – pur secondo una scelta arbitraria e limitata – fino ai giorni nostri. La crescita delle dimensioni e della complessità formale è evidente, così come la forte cesura estetica con gli esempi tardo ottocenteschi e primo novecenteschi: la realtà è riassunta in dittici, in cancellazioni, come nell’opera di Alba Zari, messa qui a confronto col lavoro di Marialba Russo.

L’esigenza comunicativa è spostata alla scoperta di sé o a spaccati di realtà insoliti, come nelle opere di Roselena Ramistella, che porta in mostra “Le guaritrici”, le donne che in alcuni angoli della Sicilia ancora si avvalgono di conoscenze e superstizioni antiche per curare gli infermi e cambiare le decisioni della fortuna. La vita e i volti narrati assumono l’incisività dello sguardo rivelatore che non lascia scampo: le mani, le rughe, gli sguardi sono segni scolpiti, inequivocabili.

La manifestazione in immagine è costretta alla terra, alla chiarezza d’intenti che poco spazio lascia alle ombre vere, a un vedere che non contempla pietà: in “Gap” (2020) Giulia Parlato, con un nitido bianco e nero e un’inquadratura che non vuole sollevare dubbi, rappresenta un grosso buco squadrato sul soffitto di quella che sembra una chiesa barocca, o i cocci in visione zenitale disposti con ordine ragionato, come asettico archivio di quello che il tempo ha deciso di far sopravvivere.


Il confronto con la mole di immagini riesumate dagli Archivi Alinari non può lasciare indifferenti, la mostra non vuole permetterlo: lo strappo che si sente può essere letto come la caduta precipitosa in terra di Icaro o una tela di Fontana, in ogni caso ciò che gli occhi assorbono girando tra le sale può – e forse deve – lasciare spazio al quesito, dopo la marcata esclamazione del titolo.
Un ultimo effetto su cui può valer la pena soffermarsi della mostra è forse il paradosso cui ci mette di fronte: da un lato, lo sconosciuto bagaglio storico degli Alinari si presenta come terreno più solido su cui camminare rispetto al contemporaneo, con riferimenti che in qualche modo collocano molte delle opere esposte nella storia dell’arte. La serie sulle espressioni del mimo di Marion Wulz (1954) pare l’affascinante riproposta dello studio scultoreo di Messerschmidt sulle espressioni facciali; i giocatori di carte qui rappresentati da Helene Magdalena Hofmann (1904-06 ca.) sono un soggetto storicamente ricorrente, da Cézanne ai primi esempi di cinema muto. La novità che si deve fronteggiare pare quindi attutita da una certa sicurezza, quel tipo di sicurezza che diventa via spianata per poter entrare in dialogo con autrici del tutto sconosciute.

Il vero campo ignoto è individuabile, allora, negli esempi proposti del panorama contemporaneo: quasi in assenza di trazione, vista come una forza che agisce su un corpo tendendo ad allungarlo nella sua stessa direzione, il suolo di partenza ha come lasciato totale libero arbitrio nelle conseguenze formali da trarre, generando isole ancora da associare a un continente o addirittura tra di loro. Questa la sfida, allora: come nel “Rendering” (1990) dell’opera incompiuta di Schubert realizzato da Luciano Berio, il visitatore e lo storico di oggi sono tenuti a formulare un sentiero non ancora ben tracciato, a costruire quella base di sicurezza che possa spingere al dialogo e unire i punti anche distanti tra di loro.
Si può pensare forse che mostre di questo tenore servano davvero a scoprire la grande fotografia del passato rimasta nell’oblio – con o senza questione di genere – e a intendere la storia non come sepolcro su cui ballare con spensieratezza, ma come base utile perché un linguaggio continui ad evolvere, com’è stato col volgare dal latino, e a creare ponti di comunicazione sempre più arditi, pur nella coscienza della radice.
La foto di copertina è di Helene Magdalena Hofmann, Tre uomini giocano a carte, Gorizia, 1904-06 ca., aristotipia alla gelatina, Archivi Alinari, Firenze.
La mostra FOTOGRAFE! Dagli Archivi Alinari a oggi, curata da Emanuela Sesti e Walter Guadagnini, si tiene dal 18 giugno al 2 ottobre 2022 Villa Bardini e Forte di Belvedere. Per informazioni: https://www.villabardini.it/fotografe-dagli-archivi-alinari-a-oggi/







