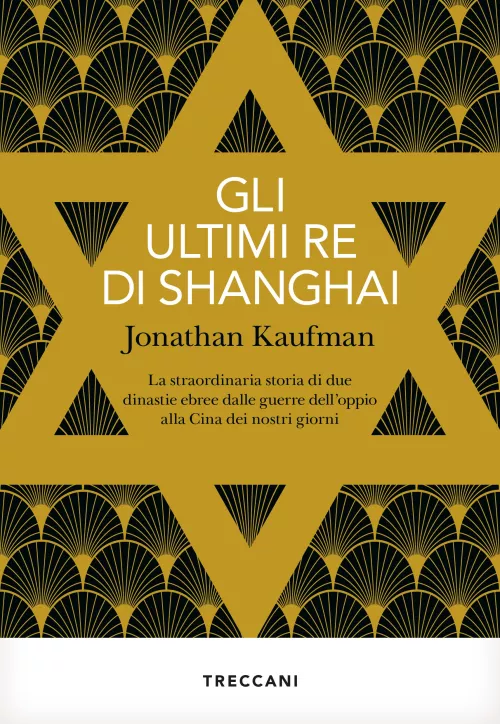Gli ultimi re di Shanghai
È difficile scrivere di un bel libro, come Gli ultimi re di Shanghai, di Jonathan Kaufman (Treccani, 2022), che però non mi è piaciuto. Riconoscere l’autorevolezza dell’autore, l’interesse dell’argomento trattato, la buona sceneggiatura in grado di condurci da un’epoca all’altra attraversando tragedie, ma sapere che a terminarne la lettura io ci ho messo un’eternità, che ogni volta riprenderlo tra le mani mi costava. Andiamo con ordine.
Protagoniste sono due famiglie che hanno fatto la storia dell’Asia in epoca coloniale, i Sassoon e i Kadoorie. Leggendo quei nomi mi sono ricordato di un edificio nel centro della Bombay (scusate: Mumbai) sud, quella degli edifici coloniali britannici neomoghul, mattoncini rossi sormontati da sbuffi di panna in forme floreali. Lì, a Kala Ghoda, tante volte sono entrato nella frescura della Sassoon Library, tra la vecchia mobilia e gli scaffali in legno scuro, salendo al primo piano dove, su una balconata coperta, uomini anziani in kurta bianco leggevano il giornale abbandonati su piccole sdraio da spiaggia.
Sul retro un giardino ombroso ospitava qualche anno fa, e chissà, forse ancora ospita, i dibattiti del festival letterario che sciorinava tutti i nomi della narrativa e saggistica contemporanea in città. Come a dire: leggo la storia di due famiglie di origine bagdadina, ebree, che hanno condiviso la storia della dominazione coloniale in India e in Cina, e in qualche modo mi rendo conto di averla toccata con mano, l’evidenza di quella storia.
Non solo a Bombay: nella Shanghai che fu Concessione Internazionale, lungo il Bund che allinea sul fronte del fiume antichi e maestosi edifici costruiti appunto da quelle famiglie di ebrei bagdadini – la modernità precedente a quella dei grattacieli che campeggiano oggi a Pudong, sulla riva opposta del fiume – su quel Bund io ho trascorso giornate quando ero in visita a Shanghai, incontrando scrittori e bella gente sulle terrazze panoramiche, e finendo, come ogni visitatore superficiale, per restarmene accoccolato in una estetica europea, a me famigliare.
Europea, sì, come diceva un buon amico di Elly Kadoorie: “I cinesi non fanno nessuna differenza tra un ebreo e un cristiano. Ai loro occhi sono egualmente stranieri.” E, aggiungo, sicuramente i cinesi riconoscevano i Sassoon e i Kadoorie come parte integrante dell’entourage coloniale britannico, protagonisti non solo del libro di Kaufman, ma anche della costruzione di un’economia capitalista in Cina: che sarebbe, questo sì, argomento di grande interesse, indagare più a fondo su quanto la penetrazione occidentale nel Paese di Mezzo ne abbia modificato l’antica struttura feudale, quanto il commercio con il resto del mondo dopo la Guerre dell’Oppio abbia inserito la Cina in un economia già a quel tempo globalizzata.
Kaufman però questa indagine non la propone, resta concentrato sulle due famiglie e va avanti come un diesel, narra i progenitori e quelli che hanno tenuto alta la fiaccola di un potere famigliare, costruendo una lunga successione di aneddoti, un po’ cronachistica, che a me ogni volta fa domandare: perché? Perché proseguire la lettura? Devo starci attento: due amici, nel giro dei faticosi dieci giorni di lettura, mi hanno parlato di questo libro dicendosene affascinati. Il mio giudizio è dunque discutibile, è personale, non ho pretese di oggettività o autorevolezza.
Riconosco che Gli ultimi re di Shanghai è un grande libro, l’affresco storico – così si usa dire – che compone è magnifico, chi niente sa di quei luoghi e di quei tempi ne ottiene qui un’infarinatura eccellente che magari invoglia ad approfondimenti ulteriori, anche se lo sguardo di Kaufman è appiattito sulle vicende dei colonizzatori, ne sposa il punto di vista mentre questi procedono alla conquista della Cina un po’ come dei narcos, sull’onda del commercio di oppio che, per come l’autore lo presenta, sembra aspirina. Kaufman incardina però il racconto sulle persone, sui membri delle due famiglie, e allora vorrei vederli scintillare questi personaggi.

David Sassoon, e Victor, e Elly Kadoorie, io proprio non me li vedo, davanti agli occhi. Di questi tre l’immagine che conservo più forte e chiara è quella delle fotografie che Kaufman chiama a far da testimoni alla sua scrittura: lo sguardo e l’abbigliamento e la posa di David, con tre dei suoi figli, e ancora Elly Kadoorie patriarcale e lo sguardo imbarazzato di due figli suoi, poi Victor tra le donne che sembra uscito dalla Los Angeles degli studios. Kaufman è premio Pulitzer, direttore di una prestigiosa scuola di giornalismo a Boston, scrive di Cina da trent’anni. Io come sempre faccio una gran fatica a leggere i libri dei giornalisti: documentati, esaustivi, completi nella scansione delle epoche e degli eventi, a me giungono piatti, ne vorrei un riassunto veloce.
Ho dato conto su Doppiozero della mia lettura, sempre sull’Asia ai tempi della dominazione coloniale, di Anarchia di Dalrymple, tutt’altra cosa, un libro che se lo apri a una pagina qualsiasi e ne leggi un capoverso già ti basta perché Dalrymple è scrittore vero. Epoche, battaglie campali, congiure di palazzo e conquista coloniale, ma, soprattutto, personaggi che scintillano.
Succede poi che, mentre avanzo a fatica nella lettura del libro di Kaufman, mi capiti tra le mani la biografia di un autore da me molto amato, J.G.Ballard: nato nel 1930 nella Shanghai della Concessione Internazionale, lì dove stavano i Sassoon e i Kadoorie. Bastano poche pagine, ed eccola comparire vivida, Shanghai: un ragazzino che la percorre in bicicletta, che vede la miseria dei molti cinesi lungo le strade, il lusso e la bella vita dei bianchi nella Concessione, e tutto osserva con una curiosità fremente di cui ci fa partecipe: mi consente di impossessarmi di quei luoghi, di vederli chiari, mi sembra di interloquire con la galleria di persone e non solo personaggi che il ragazzino Ballard incontra, e che va a sollecitare, europei, cinesi, o giapponesi.
Quando i giapponesi bombardano Pearl Harbor in una domenica di dicembre del ’41, che per l’undicenne Ballard è già un lunedì a Shanghai, la guerra diventa mondiale, e comincia l’esperienza del campo di Lunghua, dove vengono internati i bianchi delle nazioni nemiche del Giappone: anni per lo più felici, ricorda Ballard. Ma io devo tornare a Kaufman, che sorprendentemente narrando gli anni trenta ha cambiato marcia: la guerra sinogiapponese, e poi il conflitto mondiale, le migrazioni degli ebrei in fuga dalla minaccia nazista, poi i giapponesi che attaccano l’impero industriale Sassoon: qui la Storia scrive una grande sceneggiatura e Kaufman la cavalca, con mestiere.
Qui si può restare affascinati dalla vittoria dei comunisti nel ‘49, la fine, dal punto di vista cinese, dei cent’anni di umiliazione iniziati con l’oppio, e qui c’è la storia dell’Asia che si libera del colonialismo: Victor Sassoon va alle Bahamas, invece Lawrence Kadoorie torna a Shanghai e trova una via di collaborazione con il regime comunista, però ancora né Victor né Lawrence io me li vedo davanti agli occhi, resta un po’ un teatro dei pupi: le battaglie, appunto, i vincitori e i vinti. Dentro a un’impostazione, quella di Kaufman, che è di adesione totale al punto di vista europeo e occidentale: quando correttamente individua nel massacro di Tian’anmen, 1989, il punto di partenza dell’apertura della Cina al turbocapitalismo e alle multinazionali, Kaufman ci parla di ‘acume politico’, e basterebbe questo a farmi girar la testa da un’altra parte. Poi il libro finisce, i Kadoorie ancora sugli scudi, i Sassoon quasi dimenticati. Siamo ai ringraziamenti, e su una settantina di nomi solo una manciata sono i cinesi: anche le fonti, di questo racconto sui re di Shanghai, sono tutte europee. Questione di punti di vista.