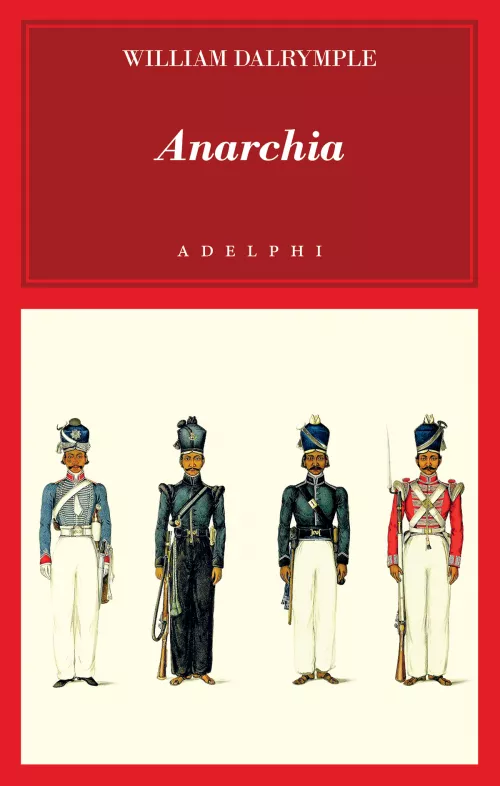Dalrymple: la vera storia del colonialismo inglese
Si dice di un libro a volte che sia il Guerra e pace di un tempo e un luogo dato. In questo di William Dalrymple, Anarchia (traduzione di Svevo D’Onofrio, Adelphi 2022) siamo in India, seconda metà del Settecento, e si narra l’irresistibile ascesa mercantile e militare della Compagnia delle Indie Orientali britannica, che travolse l’Impero mughal e con quello i regni minori nei quali si era frammentato il subcontinente indiano. Si dà conto delle campagne militari, della tattica e della strategia, della cavalleria e degli obici. Si dà conto anche degli intrighi, della politica, delle alleanze composte e poi tradite, e ci si mette sotto agli occhi la costruzione di un’impresa – company, società per azioni – che ebbe il pregio di inaugurare una stagione di floridi commerci tra il paese delle spezie e degli ori e il paese della rivoluzione industriale, ma lo fece annichilendo lungo il percorso una manodopera sfruttata fino al midollo.
E divenne, la East India Company, il grimaldello in virtù del quale fu inchiavardata senza una conquista militare diretta la signoria della Corona britannica su quel pezzo di mondo: fu il Raj, con capitale Delhi e duecento milioni di sudditi, tra l’Himalaya che guarda alle steppe del nord, e il capo sud a Kanyakumari, che guarda in faccia l’equatore. La guerra la fece la company, e come in ogni Guerra e pace che si rispetti ci sono allora le congiure di corte, le discendenze familiari ambigue e fin perverse, i deboli e i forti, i paranoici e gli assennati, molti cavalli, alcuni elefanti e un ultimo imperatore mughal, Shah Allam, fantoccio degli inglesi, torturato dal prediletto figlio adottivo, cieco. E poi ci sono gli avventurieri, i Clive, Hastings, Wellesley, non ufficiali ma consiglieri delegati nominati a dar soddisfazione agli azionisti londinesi della Compagnia delle Indie Orientali, con i libri sociali in una mano e la spada nell’altra.
La qualità migliore di Anarchia è però la capacità di insinuare nel lettore pensieri laterali, domande fuori contesto che sorgono improvvise. La mia prima: perché fu l’Europa a conquistare l’Asia, e non il contrario? Non erano, come Dalrymple ricorda, l’India e la Cina a quel tempo a pari livello tecnologico e culturale, in certi campi più avanti? Fu solo la potenza delle cannoniere a determinare questa epocale sopraffazione – costruendo una gerarchia del mondo che solo oggi sembra rimessa in discussione? Anarchia ben ci dimostra come le tattiche militari degli inglesi o la loro artiglieria non fossero così superiori a quelle degli avversari, e come gli indiani acquisirono la strumentazione materiale e concettuale del nemico in breve tempo.
E dunque c’è altro alle spalle della costituzione del dominio coloniale britannico, il più vasto che il mondo abbia conosciuto. C’era, questo è il fatto, una spinta propulsiva ineguagliata nella storia, che è insufficiente definire come il risultato della rivoluzione industriale, dell’affermarsi di nuove tecniche di produzione e di creazione di energia. Dalrlymple ne individua il fulcro nell’idea di società per azioni, che concentrando ricchezze private le rende motore di attività irresponsabile, perché le ricchezze reincarnate in capitali, alienate dai proprietari, prendono vita propria, tese sacralmente alla propria moltiplicazione, nelle mani di capitani di industria – colonnelli e generali per quanto attiene alla Compagnia delle Indie – il cui solo orizzonte e Graal è l’utile di bilancio.
La massa del capitale accumulato si trasforma in energia, volta all’incremento finale del capitale impiegato. Sul campo, lascia posti di lavoro, ma stritola gli individui. In quel tempo in India l’energia causò la dissoluzione dei poteri preesistenti, inesorabile fu la concentrazione delle risorse volte a questo scopo. Si chiama capitalismo, ha raddoppiato la speranza di vita nel mondo in un par di secoli moltiplicandone per otto la popolazione e ancor oggi dove, come in Cina, gli si spalancano le porte, costruisce prodigi.
Del resto fin Marx e Engels affermarono il carattere rivoluzionario del colonialismo: faceva girar la ruota della storia. Una volta affermatosi sul globo intero il capitalismo avrebbe poi prodotto il suo anticorpo più potente, il proletariato, capace di fargli argine e di condizionarne il percorso: profezia che pensando all’India recente, alle grandi manifestazioni contadine capaci di vincere battaglie pare ancora attuale, pensando invece alla dittatura cinese e alla sua capacità di reprimere ogni dissenso, no.
Ma Dalrymple? Preso dal mio pensiero laterale me ne sono allontanato a distanze siderali. Torno al libro. Anarchia ci fa osservatori di una Storia che ha come fulcro l’economia, i rapporti mercantili, i prezzi e la loro formazione, e di conseguenza le convenienze, le alleanze che disgregarono ogni possibile unitarietà politica e statale del subcontinente, salvo aprire la strada a quella ritrovata del Raj: la Corona britannica. Dalrymple ce lo dice chiaro: “La transizione dell’India al colonialismo avvenne per mano di una società a scopo di lucro, che operava al solo fine di arricchire i suoi investitori”. E più avanti: “(…) la conquista militare, l’assoggettamento e il saccheggio di vaste aree dell’Asia meridionale. A tutt’oggi rimane quasi certamente il supremo atto di violenza imprenditoriale della storia del mondo”.
E infine: “Quando gli storici britannici discutono dell’eredità del colonialismo britannico in India, di solito citano la democrazia, lo stato di diritto, le ferrovie, il tè e il cricket. Ma l'idea della società per azioni è forse una delle più cruciali esportazioni britanniche in India, e ha cambiato l’Asia meridionale, nel bene o nel male, più di ogni altra nozione europea. La sua influenza supera quella del comunismo o del cristianesimo protestante, e forse anche della democrazia”.

Anche qui nasce un pensiero laterale, che lo stesso Dalrymple qua e là lascia affiorare: ci insegna qualcosa sul mondo presente, la storia della Compagnia delle Indie? Un mondo, il nostro, in cui molte multinazionali hanno un patrimonio superiore a molti stati nazionali, e – usiamolo, questo modo di dire – una superiore potenza di fuoco. Dalrymple indaga il rapporto tra la Compagnia delle Indie e lo stato britannico, ne mostra le contraddizioni, gli scontri, ma anche la permeabilità reciproca dei due contraenti: sono molti i parlamentari e i Lord che comprano a quel tempo azioni della Compagnia, il cui valore in borsa sale vertiginosamente, e allora altro che conflitto di interessi. (Sembra intanto, Dalrymple, sopravvalutare la democrazia britannica del diciottesimo secolo, con un parlamento eletto sì, ma su base di censo, il diritto di voto circoscritto ai maschi proprietari di terra, di immobili o di impresa).
La dominazione coloniale, durata più di due secoli, si connotò non solo in India come un’iniziativa partecipata dalle grandi compagnie private. La stessa Compagnia delle Indie Orientali ebbe gran ruolo nel resto dell’Asia, per esempio in Cina, come ha bene raccontato un altro autore indiano, Amitav Ghosh, nella sua Trilogia dell’oppio – o dell’ibis. Ed è lo stesso Dalrymple a ricordare come la battaglia per l’indipendenza americana cominciò con il Boston Tea Party e le navi della Compagnia delle Indie Orientali, episodio finale del boicottaggio delle sue attività sul suolo americano.
Rapporto conflittuale, quello tra lo stato e il privato, che si concluse agli albori del nuovo secolo, il diciannovesimo, con la messa in riga della Compagnia – una volta esaurito il suo compito, viene da dire. Ancora il pensiero laterale fugge: a domandarsi che rapporto ci sia oggi tra grandi corporation e stato, sia dove la democrazia c’è, sia, come in Cina, dove lo stato è nelle mani di un’oligarchia.
Domande, molte domande. Davvero è il pregio di questo libro, grande ricostruzione storica (delle più di seicento pagine un centinaio sono note e bibliografia, a testimoniare la profondità della ricerca), ma indubbiamente anche grande romanzo, per la capacità di dar vita ai personaggi che la popolano. Dalrymple ara il campo sconfinato della literary non fiction, i fatti sono esposti nella loro drammatica e definitiva verità, ma il racconto è fatto per prenderci e portarci via, più che Guerra e pace dovrei menzionare Storia e storie, nel reciproco rispecchiarsi e riverberare.
Conosco la mia fatica nel leggere saggi se mi annoia la scrittura, per quanto pure sia interessante l’argomento trattato, e ringrazio Dalrymple che vivifica gli eventi con la sua penna, pur letto in traduzione. Anche in questo caso il pensiero laterale prende il sopravvento: romanzare, come si diceva un tempo, falsifica la Storia? Non si fa Dalrymple prendere la mano da questioni, per così dire, di sceneggiatura, al punto da stravolgere i fatti e farne invece, come dire, una cosa pop? I buoni giornalisti oggi diffidano dello storytelling, che piega la notizia alle sfumature dello spettacolo, ma qui siamo in presenza di uno storico che è anche un grande scrittore: va bene così.
E poi, in Anarchia: gli amministratori delegati, condottieri. Dalrymple apre il libro, d’emblée, con un dramatis personae. Dunque, 1: gli inglesi. Robert Clive, che viene dal nulla e prende il comando di tutto, Warren Hastings il giusto, il capro espiatorio, Richard Colley Wellesley, che senza far parola agli azionisti riporta l’India sotto il controllo dello stato britannico.
Meravigliosi tutti, i personaggi della tragedia, anche nella loro crudeltà, bestialità, orrore, alle prese con l’ineluttabile. Più degni, parrebbe dal racconto di Dalrymple, 2: i regnanti e i condottieri indiani: gli sconfitti. Ma davvero allora la Storia si costituisce di personaggi siffatti? Pensiero laterale: cosa mai ci facevano studiare a scuola, a noi, che pareva diventar tutto commedia, epopea, favola grande di grandi uomini, con qualche eccezione a confermar la regola: le ventitré vigliacche pugnalate a Cesare, Marat nella vasca da bagno.
Historia magistra vitae, ma ancora nei licei di venti anni fa non ci si discostava da un racconto buono per una fiction di primetime Rai3, e a noi e i nostri figli la Storia poco maestra è stata, se non quella che abbiamo avuto la fortuna di sperimentare con i corpi e le menti nostre: il nostro presente. La vicenda di Hastings è educativa alquanto: “… Morigerato, erudito, diligente, austero, infaticabile lavoratore, era un noto indofilo e in gioventù si era opposto fieramente al saccheggio del Bengala da parte dei suoi colleghi” – i manager, certo, ciascuno con la sua personalissima agenda di sfruttamento dell’India e degli indiani. Il suo collega e avversario Francis però, “politico irlandese e polemista intrigante”, il cattivo vero le cui malefatte Hastings seppe contenere, riuscirà a fare incriminare Hastings per le malefatte della Compagnia nel momento in cui il pendolo si sposta a sfavore del privato e torna in auge lo stato. Brutto affare, la Storia, Hastings: ricordarsi di tenere giù la testa.
Ma venne infine assolto. E qui l’ultimo pensiero laterale mi scappa e non riesco a trattenerlo. La domanda chiave: se la Storia e le storie questo sono, un’infilata di violenze e sopraffazioni, di bugie e tradimenti, di malesseri individuali maldestri, inadatti a squarciare il velo di maya, destinati piuttosto a reincarnarsi in maledetti atti di potere, allora noi, qui, scrittori e intellettuali, cosa scriviamo a fare? Quale parlare illuminista e di che, pretendiamo da noi, se non è volto a far fronte all’orrore? Tutto il resto è intrattenimento, vacanza. Paradosso: era, la seconda metà del Settecento, il periodo d’oro dell’illuminismo, scientifico e sociale. Gli azionisti della Compagnia delle Indie non responsabili dei massacri compiuti in India secondo il diritto societario che regola le SpA – e le Srl pure, se è per quello – vedevano gli utili trasformarsi in dividendi e passavano all’incasso: hanno vinto loro, o ha vinto l’illuminismo?