I buoni siamo noi
La lettura mi ha tirato fuori tutto quello che in questi mesi, in questi anni, avevo nascosto in fondo a me stesso. Ha acceso un riflettore da un'altra angolazione (non la mia) e ha messo in luce quel cono d'ombra che ho vissuto, ma mai guardato e affrontato, riletto, analizzato. Quelle cose con cui avrei dovuto fare i conti e che invece ho preferito nascondere, nel tentativo di dimenticarle.
Sento la necessità di parlarne, con chi era con me in quel periodo, con gli amici di una vita e con i conoscenti, con tutte quelle persone che per oltre tre anni mi hanno visto assente, profondamente impegnato in quello che facevo, e senza altro tempo per altro e per altri. Troppo spesso in quel periodo mi sono sentito dire oppure ho sentito dire: "Daniele non c'è, deve salvare il mondo!".
Non ho salvato nessuno.
Io sono salvo, ma vinto, e ho bisogno di raccontare quello che è successo […]
[status Facebook di Daniele R., 17 maggio 2014, in seguito all'uscita de I buoni di Luca Rastello,
133 “mi piace”, 21 condivisioni]
Poi, un giorno, capita che parta un ultimo giro di telefonate, messaggi, whatsapp, e questa volta non è come le altre, non so chi se ne sia reso conto in diretta, tra quelli che avevano l'automatismo di chiedersi Come sta, Luca?, con il solito sgomento che lui sfuggiva e con l'abitudine a sperare che la sua partita contro la malattia sarebbe stata eterna. Supplementari, rigori a oltranza e alla fine ha vinto lei, la malattia, e dopo dieci anni si è portata via Luca Rastello. Giornalista, scrittore, amico.
Eppure, in questi giorni in cui il vuoto dovrebbe invadere le vite di molti di noi, si respira una nuova comunità che lui aveva sapientemente intessuto intorno a sé, con il suo meraviglioso sogghigno da spirito critico e da voce libera, come a dire – come sapeva dire a chi incalzava con le sue parole – Non vi libererete facilmente di me. Ostinatamente vitale anche nel morire, così un suo grande amico, quasi un figlio, l'ha definito, questo momento – “passaggio triste, eppure ostinatamente vitale”.
L'impressione, man mano che scorrono i giorni dopo la morte di uno dei più grandi intellettuali del nostro presente, è che le migliaia di pagine che ci ha lasciato si stiano sovrapponendo a questa comunità di gente – mi verrebbe da dire – per bene, una comunità che inizia a prendere coscienza di esistere. E che si sente legata dalla voglia di imparare a vedere il mondo coniugando un impegno in prima persona lontano dalla retorica passe-partout con un'autocritica capace, in potenza, di essere anche radicale.
Luca ci ha mostrato in parte la via per imparare a sfuggire alle nostre contraddizioni, a provarci almeno, a partire da una conoscenza profonda e laica di noi stessi, e dalla conoscenza della distanza – se c'è – tra quello che diciamo e scriviamo e quello che facciamo. Per questo, credo, in questi giorni in molti non riescono a non raccontare il rapporto umano – intenso e costante, occasionale o impressionistico – che hanno avuto con lui. Perché molti lo hanno visto fin da subito come un maestro – anche se lui la schivava, questa definizione –, uno che parlava e scriveva per lasciare un segno. E il suo fare e il suo farsi ci mostravano (ci insegnavano) uno sguardo sulla realtà. Lasciavano segni.
In una delle ultime pagine che Luca ha scritto, ne Il racconto onesto (a cura di Goffredo Fofi, Contrasto 2015), un libro che raccoglie le risposte di sessanta scrittori sul rapporto tra scrittura e realtà, leggiamo che “[…] il termometro è l'urgenza etica, la rilevanza che ha per quello che scrive il potenziale critico che la storia ha rispetto alla vita reale”. Lo scrive tra parentesi, dopo aver sostenuto “Mi sembra che una buona storia nasca sempre e comunque dall'esperienza diretta di chi la scrive”, e prima di aggiungere, con il suo understatement mai eccessivo: “Ma sono banalità”.
Lucarastello – così lo si chiamava nella famiglia allargata che ho avuto la ventura di frequentare, tutto d'un fiato: Lucarastello – non è mai stato banale, e questo suo modo eccezionale di stare al mondo ha contagiato chi lo conosceva da sempre e chi (di altra generazione) da venti o dieci anni, chi l'ha sfiorato solo nell'ultimo scorcio della sua vita e chi, dietro alle pagine che ha avuto tra le mani, non ha mai visto il suo volto ispido e sincero. A tutti quelli che l'hanno conosciuto brillano gli occhi, a parlar di lui, e anche a molti tra quelli che l'hanno vissuto in forma di pagine, che poi è quello che ci resta e ci resterà per sempre di chi ha il dono che lui aveva: la letteratura tra le dita.

Un giorno di sette anni fa sono andato a casa di Luca – avrei voluto farlo molto ma molto di più, in questi anni – e ho scoperto che lui schedava i suoi libri sulla prima pagina bianca reperibile al loro interno. Numeri di pagina, qualche parola chiave per ritrovare le sottolineature più importanti e andare a estrarne la linfa a colpo sicuro. Non so se lo facesse con tutti i suoi libri o solo con alcuni, so solo che mi ha insegnato questo metodo che a mia volta ho trasmesso ad altri e che non ho mai abbandonato. I quattro libri suoi che ora ho tra le mani, e che sono quelli che vorrei ricordare perché qualcun altro li vada a cercare, sono innegabilmente vergini di queste schedature. Forse per un ossimoro del destino, forse perché li ho semplicemente divorati, forse perché ho provato a non voler vedere il momento in cui avrei voluto scriverne perché lui non ci sarebbe stato più.
D'un fiato, vorrei provare a dire cosa secondo me tiene insieme La guerra in casa (Einaudi, 1998), una sorta di reportage narrativo, eclettico nella sua struttura, del terrificante smembramento di quella che oggi chiamiamo “ex Jugoslavia”, con Piove all'insù (Bollati Boringhieri 2006), forse il più bel romanzo sugli anni Settanta, con Io sono il mercato. Teoria, metodi e stile di vita del perfetto narcotrafficante (Chiarelettere 2009) e con I buoni (Chiarelettere 2014), un altro romanzo, ma soprattutto un ritratto feroce di una realtà che feroce sa essere, quella di chi si occupa di fare “del bene”. Provo a dire cosa credo che li tenga insieme, a parte la denuncia radicale dell'ipocrisia del “nostro” mondo, che accomuna questi quattro libri anche con La frontiera addosso. Così si deportano i diritti umani (Laterza 2010) e con Binario morto. Alla scoperta del corridoio 5 e dell'Alta velocità che non c'è (Chiarelettere 2013, con Andrea De Benedetti), che però non ho letto. Lo farò, e ne hanno scritto e ne scriveranno ancora altri con competenze che io non ho[1].
Tra le prime pagine de La guerra in casa incontriamo subito lo sguardo indagatore che Luca ha saputo applicare alla guerra che travolse casa loro, degli “altri”, ma anche e soprattutto a come il nostro mondo in pace si trovò a dover gestire il proprio modo di vedere quel conflitto, e il proprio modo di agire per modificare il corso della storia:
Non si parla dunque della guerra, ma di quella guerra e noi, dell'incontro, quasi sempre fallimentare, fra chi è coinvolto e chi osserva, degli sguardi che da questa sponda si sono gettati sull'altra. Quasi sempre con le migliori intenzioni. La coppia su cui il racconto si articola è la coppia qui-lì, con attenzione privilegiata al qui.
Se una storia è raccontata, è quella della corruzione di uno sguardo, il mio, destinato a perdere gradualmente l'innocenza originaria, a mano a mano che progrediva la vicenda del coinvolgimento – casuale e involontario – nelle attività «umanitarie» in ex Jugoslavia.
Ogni capitolo è un affresco incalzante, incredibilmente umano e rabbioso, sorprendentemente attuale, delle contraddizioni che il conflitto nei Balcani ha sbattuto nel nostro mondo, dalle parole con cui viene raccontato il massacro di Srebrenica al tono glaciale con cui ci vengono mostrati, episodio per episodio, gli interessi politici ed economici che hanno guidato l'ingerenza del mondo occidentale e la sua strabiliante capacità di immobilità quando avrebbe potuto essere decisivo nel “bene”. Nel libro Sarajevo, diventata il simbolo metonimico del disastro, si intravede solo di tanto in tanto. Ma ci sono gli uomini, e ci sono le donne, e sono reali. In quelle pagine Luca ha tracciato un'antropologia delle figure coinvolte in quella guerra, dai cecchini ai leader delle fazioni in campo, dai militari ai civili braccati, da chi fu pronto a tradire la “sua parte” per interessi a chi lo fece perché provò ad ascoltare, tra i colpi di fucile e i bombardamenti, la voce della propria coscienza. Lavorando a questo libro ha spalancato gli occhi su quel conflitto, diventando ben consapevole del fatto che ci sono situazioni in cui “Non c'è più giusto o sbagliato: c'è solo la guerra”, come dice uno dei protagonisti di un film che parla di un'altra guerra civile, quella che si scatenò in diversi angoli della nostra Europa occupata dai nazisti, e che si intitola L'ombra del nemico (di Olen Christian Madsen, 2008).
La guerra in casa si chiude con un'altra immagine di ombra, nella commovente delicatezza della dedica alla figlia di Luca, Elena, “nata all'ombra dell'Est”:
Elena è rimasta in cucina, a riordinare oggetti secondo le sue triadi familiari, nominandoli in una lingua di mezzo per cui non c'è risposta in queste storie che, pure, la coinvolgono. Incontrerà anche lei intellettuali, giornalisti, militari, preti, sindaci e, forse, «truppe di pace», sotto casa e altrove. Forse non crederà alla leggenda di Sarajevo, quella città lontana e strana dove accaddero cose che l'Europa non conosce. Eviterà, forse, la trappola teleologica del senso di colpa per misurarsi direttamente con la colpa, concretissima colpa, di vivere qui.
In questo libro non si parla di Sarajevo. E forse neanche della periferia bosniaca, lontana da Sarajevo, che ha occupato la mia testa e molto del mio cuore per cinque anni. Si parla di una marcia al ritmo della fanfara: cadi in un luogo di guerra pensando di portare un punto di vista, difendere un ruolo, rappresentare una cultura; molto probabilmente, invece, è la guerra che ti assegna il ruolo che ha deciso per te.
Crescono alcune cose oscure e ambigue ai margini di una guerra: fra queste, ti piaccia o no, ci sono i piani di pace, le truppe di pace, le azioni di pace, gli accordi di pace, tu.
Luca ci sarebbe arrivato, a larghe spire, a fare di nuovo i conti con quel “tu” che per lui era se stesso e che sa essere una lama nel petto di ciascuno di noi, a volersi soffermare. Ci sarebbe arrivato sedici anni dopo, passando per l'indagine e la scrittura intorno ad altri temi che hanno segnato il suo modo di stare nel mondo e di farsi domande sempre scomode, a partire dagli altri due libri che ho citato: Piove all'insù è un romanzo, del quale l'unico spoiler che mi posso permettere viene dalla materia che maneggio con maggior costanza, la scrittura della storia, e l'ha osservato Giovanni De Luna in Le ragioni di un decennio. 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria (Feltrinelli 2009), sostenendo che Piove all'insù è “un romanzo avvincente, ma con un forte e convincente impianto storiografico”. In questo libro, nel quale il riverbero della storia familiare dell'autore è costante, si appannano i confini tra parole che vengono spesso sventolate come certezze, e il lettore si trova aggrovigliato tra rivoluzione e reazione, tra militanza e lotta armata, tra violenza e utopia, in quegli intrecci umani che hanno, da sempre, fatto la storia, in quelle contraddizioni tra quello che vorremmo essere e quello che in fondo siamo. Con i lati più meravigliosi e più oscuri della realtà che, spesso, camminano al nostro fianco, come fratelli, come amici.
Ed è un tema che Luca ha affrontato di petto in Io sono il mercato, una sorta di reportage “costruito in forma narrativa” in cui Luca assume il punto di vista di un narcotrafficante che è incredibilmente un nostro simile: non è un narcos con il coltello fra i denti ma un signore di origine veneta, un signore quasi – mi verrebbe da scrivere – per bene, che parrebbe semplicemente aver capito come va il mondo. Luca conosce la lingua di quest'uomo, e ce la ripropone fatta decantare in una scrittura superba: hanno un vocabolario comune e non solo perché Luca sapeva vedere l'umanità in chiunque – nei cecchini come nei militari che ventilavano colpi di Stato in casa sua, quando era un ragazzino – ma perché l'aveva studiato per anni, quando era direttore del mensile “Narcomafie”, edito dal Gruppo Abele di don Luigi Ciotti. L'aveva studiato e raccontato per anni, quel vocabolario, prima di essere accompagnato alla porta.
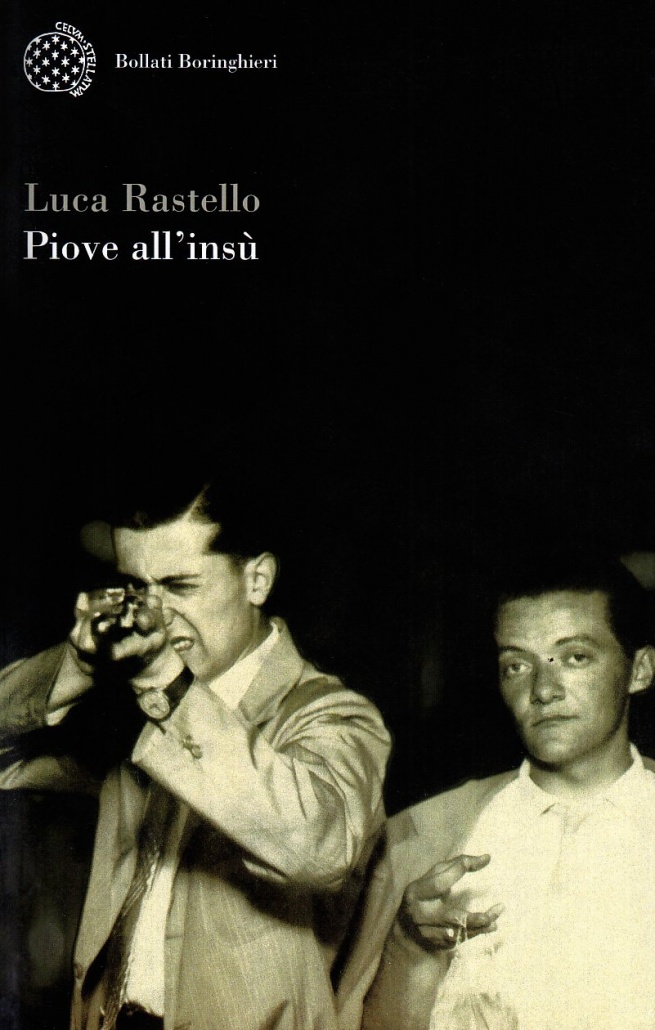
E arrivo all'ultimo dei quattro libri dei quali vorrei parlare: il romanzo-denuncia I buoni. Luca ha investito ogni sua energia nella ricerca della coerenza, portando in salvo dalla frana jugoslava decine di persone – uno spaccato autobiografico commovente si trova nel capitolo “La leggenda di Delfino” in Undici buone ragioni per una pausa, Bollati Boringhieri 2009 –, dopo aver passato una parte considerevole della sua vita a credere che si potesse “organizzare” il bene. Ma non ha mai smesso di interrogarsi sulle contraddizioni dell'impulso all'intervento in soccorso di chi è in difficoltà, come aveva già fatto nel suo libro sulla guerra nei Balcani. Lo dimostra tra gli altri un suo testo datato 14 settembre 2006. Una sorta di spartiacque involontario, dal momento che si colloca esattamente a metà: otto anni dopo l'uscita de La guerra in casa e otto anni prima de I buoni. In questo testo Luca rendeva davvero universale un dilemma che, finché le guerre si erano combattute lontane dalla nostra soglia, in fondo non ci riguardava se non come riverbero delle memorie familiari, e che, di colpo, per la sua generazione, divenne attuale:
La guerra era una cosa altrui, lontana nel tempo e nello spazio. Improvvisamente ce la troviamo lì, la guerra diviene accessibile e scopriamo la sensatezza di gesti molto semplici. Scopriamo quello che è stato chiamato in alcuni contesti, finalmente anche ufficiali, “il paradosso del gesto sensato”. Il gesto sensato, cioè il gesto di salvare una vita, cioè il gesto che era inaccessibile ai destini alienati delle metropoli occidentali del tardo ventesimo secolo; crescevi e operavi in città dove non potevi fare liberamente niente di sensato, studiare, diventare professionista, cercare di fare la rivoluzione e non riuscirci, diventare frustato, farti le pere, diventare un po' delinquente, o un po' squalo sul mercato del lavoro, fare le scarpe ai tuoi colleghi, diventare giornalista senza neanche vergognarti, come dice un poeta, e tutte queste cose qui – tutto sommato girare in tondo. Anche magari con la frustrazione dei baby-boomers passati attraverso gli anni '70 di avere anche tentato di cambiarlo, quel mondo lì, e di aver visto che si era veramente fuori tempo massimo.
Improvvisamente ti capita che salvi delle vite, e lì con la tua macchina scassata metti della gente sul sedile, li porti a casa, quella gente lì è viva e non morta, quel bambino cresce e invece non sarebbe cresciuto e fa la scuola e invece non avrebbe avuto la scuola. E diventa una delle forze attive, perché riesce anche a dare un po' di consenso politico, forze vive del tuo stremato tessuto sociale, perché l'arrivo di gente in fuga da una guerra è sempre stata una risorsa per qualunque società civile avanzata e non è mai stato un limite – di queste cose ci rendevamo conto: improvvisamente c'è la possibilità di compiere un gesto che conferisce senso e direzione all'intera esistenza di chi lo compie. Tu diventi un individuo sensato perché compi un gesto sensato, scopri che senza il gesto sensato non sei un individuo sensato.
Sembrano aforismi, sembrano banalità logiche, ma non lo sono. Perché il gesto sensato nasconde in sé un pericolo mortale: è talmente forte, come ritorno sulla percezione di sé e dei propri destini, nei confronti del soggetto che lo compie che abbassa in maniera radicale tutte le soglie critiche.
È questa la capacità di autocritica radicale di cui parlavo all'inizio, questo saper vedere in sé il pericolo di diventare il teorico di una sorta di pensiero assoluto, il pericolo di diventare mitocrate di te stesso, del tuo modo di fare le cose, del tuo “mondo”. Non ho la più pallida idea di dove fossi io mentre Luca diceva queste parole, né so dove le ha lette[2]. E temo che anche se lo avessi ascoltato sarei cascato comunque nel “paradosso del gesto sensato”. Il rischio di diventare cinici, disincantati, è naturalmente speculare, ma sono convinto che questa comunità che si trovava intorno a Luca e che dall'uscita de I buoni si sta riconoscendo è forte del fatto che le migliori intenzioni di stanare il paradosso ci sono. Di “sgamarlo”, come diceva lui. Chi sta a distanza di sicurezza da questa perdita, o chi sta cercando di reintegrare Luca in un pensiero vagamente riformista che vedeva lui – il suo pensiero capace di essere scomodo, drastico – come potenziale nemico, suppongo non abbia intenzione di riconoscere il pericolo di stare dalla parte dei “gesti sensati”, dalla parte del “bene”.

Non ci ha impedito di sbagliare, Luca, non ci ha impedito di non scontrarci con le implicazioni radicali di quello che ha raccontato ne I buoni: l'associazionismo, il “mondo del volontariato” (che sovente di volontario ha molto poco), quello che gli addetti ai lavori chiamano spesso – e fa parte di un illusorio gioco al chiamarsi fuori, “né pubblico, né privato” – Terzo Settore. Molti di noi hanno sbagliato, credo, a non chiedergli esplicitamente cosa fare, pur sapendo che lui ci avrebbe sorriso e si sarebbe scansato, perché lui non si sentiva un mentore ma semplicemente una persona che voleva discutere e pensare, e pensando e discutendo dar spallate al mondo – ai mondi – del quale ha scritto. Alcuni di noi sapevano dell'uscita de I buoni: ne avevamo chiacchierato (chi più, chi meno) con lui, non potevamo che restare ammirati di fronte al suo brillante assunto, vale a dire che solo un romanzo avrebbe potuto rendere universale la sua critica, e che solo un romanzo avrebbe potuto rendere la critica anche autocritica, pronta a “sgamare” anche le nostre contraddizioni.
E allora, in chiusura, un po’ in veste di omaggio e un po’ di autocritica non troppo velata, lascerei qua sotto, incollata come per sbaglio e tale e quale, la recensione de I buoni che avevo scritto il 9 giugno 2014 e che per infinite ragioni – non ultima una sorta di prudenza tipica di questo mondo, e di questa città – alla fine non pubblicai da nessuna parte.
Così, per vedere l'effetto che fa.

Il titolo era I buoni siamo noi, e l'avevo avevo fatta leggere a Luca, all'epoca. Oggi mi cullo nella speranza che un gesto del genere gli strapperebbe un sorriso:
Il libro è uscito da meno di due settimane, e si è scatenata la bufera. Da Giancarlo Caselli a Goffredo Fofi, da Adriano Sofri a Nando Dalla Chiesa, il dibattito che infuria sembra si muova sull'asse: con lui o contro di lui. Un libro che è stato lanciato come un “feroce ritratto della retorica del bene” (Antonio, lettore, sulla quarta di copertina) e che è stato letto (almeno da chi l'ha recensito, si spera) come un malcelato atto d'accusa contro “l'universo donciottesco”, la galassia di associazioni riunita intorno alla figura carismatica di Don Luigi Ciotti: Gruppo Abele, Libera, Acmos, FLARE e Terra del Fuoco in particolare.
Chi sapeva dell'uscita de I buoni di Luca Rastello si chiedeva da mesi se avrebbe creato scalpore, e a che livello: quanti lettori avrebbe coinvolto il primo romanzo dell'editore Chiarelettere? E chi tra loro avrebbe intravisto – a torto o a ragione – tra i suoi protagonisti tanti volti arcinoti del “volontariato” torinese e italiano? E tra questi protagonisti, chi avrebbe alzato lo scudo e chi la spada?, qualcuno avrebbe colto l'occasione per usare questo romanzo come uno specchio? Noi sapevamo che si sarebbe scatenato il finimondo almeno tra gli addetti ai lavori, almeno nella nostra Torino.
Noi, che c'eravamo. Negli ultimi anni, almeno. Siamo pezzi fuoriusciti proprio da quel mondo, della generazione che segue quella di Rastello, e molti dei motivi per cui ce ne siamo andati sono descritti senza esitazioni, senza giri di parole, nelle feroci pagine de I buoni. Noi riconosciamo nell'affresco che Luca ci ha regalato un mondo che spesso inizia a confondersi con il male che dichiara di combattere, dove la vita delle persone in difficoltà è business, dove i diritti dei lavoratori sono appannati se non inesistenti; riconosciamo un mosaico di progettifici dove si vive di relazioni di potere, “ganci” e contatti da fare impallidire la politica più clientelare. Anche per questo ce ne siamo andati, per non lasciare abbassare la nostra asticella etica fin sotto la cinta, per restare umani e – perché no – sognatori. Non sappiamo se quelle di Luca siano pagine “disincantate” – così in molti le descrivono –, l'incanto non è una categoria lucida, e poi per essere disincantati bisogna essere stati incantati, e a noi è capitato.
Luca Rastello ha insistito molto sul fatto che I buoni parla innanzitutto del male che esiste dentro di noi, che si fa fatica ad accettare, soprattutto quando ci riempiamo le giornate di “giuste cause”. Perché questo libro a noi – e a tanti altri, immaginiamo – racconta una storia di complicità, se la vogliamo vedere. Migliaia di persone hanno sfiorato questo impero del bene, spendendoci notti e giorni, molto spesso hanno cominciato con un sincero impegno, con “la frusta dell'oltre”, refrain che nel libro ricorre sulle labbra dei professionisti dell'associazionismo, uno degli incalcolabili, ruvidi neologismi che affollano il “terzo settore” – così lo chiama chi ci vive, o ci sopravvive.
Tra le parole grosse che stanno volando in questi giorni, abbiamo sentito dire che non si possono gettare palate di fango su un mondo per carità imperfetto come ogni prodotto umano ma che combatte veramente mali che esistono, la mafia, la marginalità, eccetera eccetera – ennesima rielaborazione del fine che giustifica i mezzi, in fondo. Ma il “terzo settore” è un prodotto storico che vive una profonda crisi di coscienza, almeno agli occhi di molti di quelli che – dagli anni Novanta a oggi – l'hanno visto dall'interno, e non doveva andare per forza così. Non è sempre così.
Molte delle “scene” che affollano il libro noi le riconosciamo. Sappiamo – o possiamo intuire unendo molti indizi – quando sono accadute, con che protagonisti, quanto (poco, in verità) la libertà finzionale è intervenuta a modificarle, a colorarle leggermente. In alcune di quelle scene, noi eravamo presenti. Abbiamo sentito gli sgangherati machismi, abbiamo assistito allibiti – e a volte li abbiamo persino votati – a virtuosismi amministrativi, abbiamo accettato che innanzitutto a noi stessi venissero negati i basilari diritti del lavoro, per poi scendere in piazza insieme ai sindacati, il primo maggio. Abbiamo sentito storie di passivi stratosferici raccontate con il sorriso sulle labbra – ma sì, cosa vuoi che siano qualche centinaio di migliaio di euro – e abbiamo visto soldi girare come trottole per coprire buchi su buchi creati da mala gestione, nel migliore dei casi. Abbiamo visto gente uscita o sbattuta fuori a calci accompagnata da una damnatio memoriae perpetua – come è capitato a Luca – e spesso “accompagnata” (così vengono chiamati i licenziamenti, da quelle parti) da insinuazioni pesanti, al limite della querela.
Andarsene non è stato facile, perché ci abbiamo creduto, in questo mondo. Non è facile ammettere di essere stati ciechi, sordi, e poi muti. E per questo siamo grati a Luca, per aver detto con voce salda parole importanti, per questo ritratto feroce di un mondo che feroce sa essere, che sa surfare sui confini della moralità, e che si racconta come il migliore dei mondi possibili, per combattere il male. L'unico, forse. E se non sei con lui, sei contro di lui. Come direbbe Luca, il problema siamo noi. Il problema sono i soldi, il potere, il prestigio. Le “giuste cause” sono una cosa seria.
Noi siamo stati osservatori, critici, abbiamo sofferto la nostra impotenza, e poi un doloroso divorzio – siamo stati complici, anche.
Questo è un romanzo, si dirà, è solo un romanzo, in fondo.
Eppure I buoni ci dice, se vogliamo ascoltarlo: prima di ricominciare, se vogliamo ricominciare, leghiamoci alla nave come Ulisse, non ascoltiamo il canto delle sirene, se esiste il bene e se da quella parte vuoi combattere gireranno soldi, e tanti, vivrai immerso nella precarietà e nei rapporti di potere più squallidi, dovrai essere saldo, incorruttibile, donchisciottesco, forse, perché – sono parole di Calvino – “basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell'anima e ci si trova dall'altra parte”.
Questa storia per me è stata una grande illusione, dove la morale è stata spesso doppia, dove Legalità e Trasparenza valevano solo per gli altri. In casa "nostra", invece, ci si regolava secondo convenienza.
Questa storia per me è stata una realtà dove l’incontro fra ottime intenzioni e relazione di aiuto e modello-impresa ha creato una miscela pericolosa: un intreccio di rapporti ipocriti di potere e sottomissione in quell'odore di soldi e sessismo di cui tutto il dolore del mondo non costituisce altro che l’ovvia periferia. Ho "toccato con mano" la "retorica del bene” e della solidarietà di chi vuol fare di ogni aiuto soltanto "un progetto”.
Perché gli oppressi sono utili e devono essere visibili soltanto quando sono vittime. Non importa di cosa: l’importante è che rimangano tali e che si possano compiangere.
Lo ripeto: non è stata tutta merda, anzi. Ma oggi è di quella che resta l'odore.
Sono stato complice di molte cose, voglio sentirmi libero di parlarne, di dissentire.
Quello che è successo non può essere un tabù.
[status Facebook di Daniele R. 17 maggio 2014]
[1] Segnalo anche il libro – a quattro mani con Antonio Pascale – nato da un'iniziativa di Biennale Democrazia 2009 e pubblicato con il titolo Democrazia: cosa può fare uno scrittore? (Codice Edizioni 2011), che contiene un suo intervento molto critico sull'“overdose di retorica”, nel quale non manca l'autoironia sullo “Scrittore Civile”, in chiusura del quale leggiamo che “la tensione alla verità non va raccontata, va praticata”. Un altro discorso andrebbe fatto per Undici buone ragioni per una pausa (Bollati Boringhieri 2009), forse una raccolta di racconti, senza dubbio un affresco intimo, potentemente letterario, nel quale la voce dell'autore assume infinite sembianze, in prima persona, parlando di sé e parlando d'altri. E costruisce delicatamente il suo libro “delle cose penultime” che accompagna il lettore in un viaggio – sospeso su frammenti di sogni – tra veterani e sindacalisti sudamericani, tra la Bosnia e il letto di un ospedale, tra le sponde del fiume Po e la Patagonia, tra armeni e azeri e conflitti arcaici, tra la voce di un maiale e una vigilia di Natale che strappa lacrime, a leggerla oggi.
[2] Nel corso della stesura di questo articolo mi è stato segnalato che si trattava di un intervento al convegno Il ruolo dell’OSCE e delle altre organizzazioni internazionali nella ricostruzione post-conflitto in Bosnia Erzegovina, organizzato da MSOI (Movimento studentesco per l'organizzazione internazionale) Torino. Il testo è stato poi pubblicato nel 2008 negli atti del convegno, intitolati Don’t Forget. Studi sulla Bosnia Erzegnovina. Ringrazio Alice Ravinale per la segnalazione.







