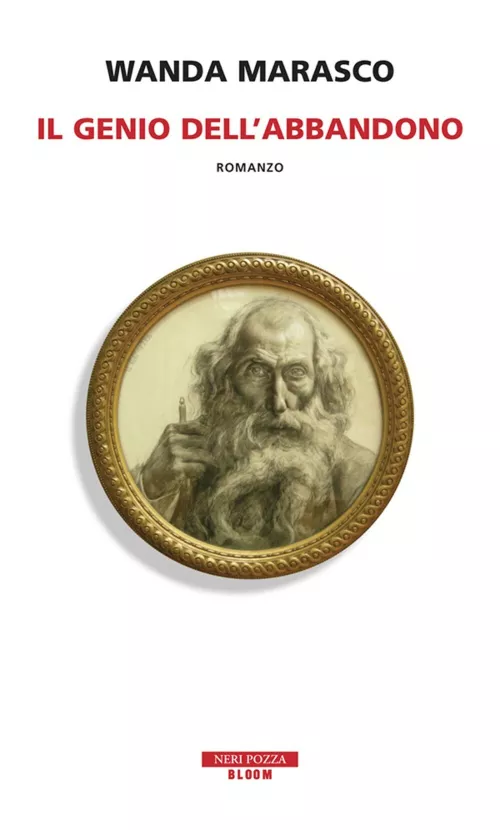Il genio dell’abbandono. Wanda Marasco
In prima approssimazione, Il genio dell’abbandono di Wanda Marasco è la biografia di un artista. Oggetto del libro è infatti la vita dello scultore e pittore Vicenzo Gemito, nato a Napoli nel 1852 e ivi scomparso nel 1929 (per inciso, ricordo che fino al 16 luglio sono esposte al Museo di Capodimonte 90 delle 372 opere della collezione Minozzi, acquisita l’anno scorso dal Ministero dei Beni culturali, in attesa di restauro e sistemazione definitiva). Ciò premesso, dell’impresa della Marasco non s’è però ancora detto nulla. Per quanto scrupolosa possa essere la corrispondenza con i documenti e le testimonianze – a partire dal profilo che Salvatore Di Giacomo pubblicò, vivente ancora Gemito, nel 1923 – l’interesse di quest'opera sta infatti altrove; e i suoi pregi non sarebbero inferiori se il personaggio fosse inventato di sana pianta. In altre parole: il protagonista di questo libro è così profondamente, radicalmente reinventato, che la conformità con quanto è storicamente documentabile costituisce, a conti fatti, una circostanza secondaria.
Non basta. Vincenzo, Vicie’, è bensì un personaggio di indiscutibile forza, che per di più è in scena dalla prima all’ultima pagina; ma non darei per scontato che Il genio dell’abbandono – romanzo, molto più che biografia: romanzo, non biografia – sia, nel senso più pieno dell’espressione, il romanzo di un personaggio, per quanto indimenticabile. La vita di Gemito – «meschino per nascita, magnifico per natura» – c’è tutta, s’intende, nella sua densità avventurosa e davvero romanzesca. La nascita oscura; l’abbandono alla ruota dell’Annunziata; l’errore nella trascrizione all’anagrafe, che trasforma l’eletto, augurale cognome scelto da una monaca – Génito – in un doloroso, fin troppo veridico presagio (Alberto Savinio ne sarà colpito). Quindi la famiglia adottiva, di assai umile condizione; la precoce vocazione artistica; la turbolenta adolescenza; le botteghe dove si forma (Emanuele Caggiano, Stanislao Lista), il sodalizio con il coetaneo Antonio (Totonno) Mancini, futuro pittore di vaglia; i primi riconoscimenti, le prime sculture famose (come il busto di Giuseppe Verdi), il legame con la modella francese Mathilde Duffaud; il soggiorno a Parigi, dove, oltre a frequentare un milieu artistico irripetibile, contrae la sifilide; il ritorno a Napoli, il matrimonio, la non facile vita coniugale, i primi sintomi e poi la manifestazione conclamata dello squilibrio psichico che lo porterà al manicomio di Villa Fleurent a Capodimonte. E poi il ritorno alla libertà, il controverso rapporto con la figlia Peppinella, la lunga auto-reclusione in casa; e naturalmente la fitta trama dei successi e delle incomprensioni, delle fissazioni e delle metamorfosi – la storia insomma di una celebrità dolente e controversa, incapace di appagamento, ignara di serenità.

Vincenzo Gemito, Giuseppe Verdi, 1873
Eppure il senso di questo libro sta altrove. In primo luogo, in una operazione sul linguaggio. Il genio dell’abbandono è scritto in un italiano screziato, spesso gremito di napoletano, molto al di là della robusta presenza del dialetto nei dialoghi. Il tratto distintivo dello stile della Marasco consiste nell’imprevedibile mescolanza dei due registri nelle parti narrate, non riconducibile al semplice criterio della maggiore o minore prossimità alla sfera verbale dei personaggi, né conforme al livello di realtà evocato via via dal racconto. A governare le emergenze del napoletano nel tessuto narrativo è un meccanismo più sottile, che si direbbe risponda a un ritmo interno, quasi a una pulsazione verbale, diastoli e sistoli: o forse, più esattamente, a un’esigenza di tipo scenico. Di fatto, la narrazione della vita di Gemito assume la forma d’una sorta di teatro linguistico, dove il trascolorare del dettato dall’italiano al napoletano e viceversa dipende da ragioni variabili secondo i casi e impossibili da ridurre a formule. A porgere il racconto s’accampa insomma una voce recitante, anonima ma fortemente caratterizzata, capace di straordinarie modulazioni: una voce di volta in volta secca, sinuosa, avvolgente, spiccia, ipnotica, che usa il napoletano ora per sottolineare le parole, ora per sfumarle, ora alzando il tono, ora abbassandolo. E anche se non mancano i termini detti di preferenza in napoletano – suscio, soffio; scigna, scimmia; annuro, nudo; astici, terrazzi (cito di proposito voci non registrate dal prezioso glossario in appendice, che si vorrebbe più generoso) – anche se, dicevo, c’è un lessico napoletano ricorrente, rimane chiaro per altro verso che il confine è assolutamente aperto, il rapporto fra le due lingue è fluido e reversibile. Non perché sia armonico, però; anzi, proprio per la sua intima, vibrante drammaticità.
E questo perché – siamo al secondo aspetto fondamentale del libro – più che la storia di Vincenzo Gemito, Il genio dell’abbandono è un discorso sul dolore e sulla separazione che riguarda innanzi tutto il protagonista, ma non si limita a lui. Di qui i Leitmotive della vicenda: la sofferenza mentale (la prima scena del libro è quella della fuga da Villa Fleurent), le barriere emotive, le visioni, gli sdoppiamenti, le fratture interiori, che possono essere declinate in maniera diversa, mai riparate o risarcite. La fenomenologia è ricca, a cominciare dalla moltiplicazione dell’identità. Ecco il protagonista, evaso dal manicomio, nascosto tra le fronde di una quercia: «E fu così che Vicienzo, metamorfosato in scigna, lince e serpe, liquidò Vicienzo umano, a partita vinta con lo sgomento d’essere diventato in parte entità animale e in parte grande spirito arboreo» (p. 33). Vincenzo durante il ricovero, smanioso di autoritrarsi: «Gemito vive con materiale da diluvio. Gemito è ancora “umano”, ma rischiosamente. Provvede al miglior disastro. È attore tragicomico perché sta interpretando sparpagli di vita stuprata. Vedi riferimenti letterari: Chisciotte, Amleto, Sigismondo, Orlando, eccetera. Nonché altre vite vissute in condizioni di forte squilibrio e di continua lotta» (p. 43). O ancora, finalmente a casa a dipingere: «Ricevute le cose che aveva chiesto, messo a posto fogli, matite, arnesi, carta liscia, carta abrasiva, pezze e spugne, ebbe chiaro, così come aveva intuito Mastro Ciccio, il pensiero di riemergere. Di riemergere dall’autoritratto, usando tre facce in tensione: ‘a soia, chella riflessa nello specchio e quella che stava nascendo sul foglio» (p. 90) (da segnalare, en passant, la scelta di un autoritratto come immagine di copertina).
Accade spesso che la scissione interiore divida il soggetto in tre parti. Un ultimo esempio. Poco dopo la morte del padre adottivo Giuseppe Bes, mentre lavora nella bottega di Caggiano, Vicie’ apprende per caso che il maestro di bottega intende presentare a un concorso i suoi disegni a nome proprio, con la scusa che l’apprendista non ha ancora raggiunto l’età minima per partecipare. Il ragazzo s’infuria; per rabbonirlo, gli offrono un dolce. «Vicienzo pensava che in quel momento ce steveno tre Vicienzo: ‘o primmo se magnava ‘a sfugliatella; il secondo voleva tornare al più presto areto pe’ sputa’ ‘n faccia al Maestro; l’ultimo formulava un pensiero su Bes, che forse, abbracciando i propri sogni, viato a isso se n’era fuiuto in Oriente» (p. 134).
Un’altra serie di fenomeni riguarda le presenze fantastiche. Semplice e (per dir così) canonico è il caso dell’amico immaginario con il quale Vincenzo dialoga a Villa Fleurent, anche al momento della fuga («Stanno penzanno ‘a festa, chist’è ‘o mumento!» sibilò all’amico Peppino). Più complicato il caso della madre viva ma lontana, che il protagonista, in quel momento a Parigi, si figura morta per poterle parlare del vergognoso segreto (il «mal franzese»). E tanti altri: dallo spirito del secondo marito della madre, Mastu Ciccio, defunto da tempo, che accompagna Gemito quando in tarda età decide di tornare a Parigi, fino alla persistenza di Vincenzo medesimo dopo la morte, a titolo ormai di puro fantasma, accanto alla figlia Peppinella: per parte sua vittima quand’era ancora infante di un gesto inconsulto del padre, e poi legata a lui da un rapporto che emulsiona viscerale attaccamento e sostanziale estraneità (“Disse agli amici di Gemito che doveva rispondere secondo due dolori. Uno era elastico e l’altro era rigido. Nel primo ci stava Peppinella con la missione di perpetuare il nome di Gemito, nel secondo una figlia che aveva capito poco, e quel poco preferiva tenerselo dentro») (p. 326).

Vincenzo Gemito, autoritratto su lettera
Tra le frasi più di frequente ripetute, quella del titolo. Il primo a citarla è l’amico Francesco Cangiullo, discettando sulla sua nascita: «Vicie’, e chi se ne fotte del sangue delle origini? Cazzate. E vedi il caso tuo. Non hai mai avuto padre e madre naturali, ma una forza del fato. Per te c’è stato un genio, il genio dell’abbandono, Vicie’. Perché, se non ti abbandonavano, tu forse non saresti mai diventato Gemito, il grande scultore Vincenzo Gemito!». Ma il genitivo del titolo potrebbe avere anche un valore diverso. Il rifiuto che si ribalta in privilegio, a ben vedere, è una lectio facilior, da temperare con altre interpretazioni possibili: il talento nativo che non si lascia annichilire da un destino segnato dagli abbandoni, il benigno spirito protettore che tutela gli abbandonati.
Al mistero della nascita fa riscontro il carattere pubblico e solenne delle esequie. L’enumerazione che contraddistingue la scena richiama alla mente una moderna replica dell’arca di Noè, o uno dei presepi che affollano le botteghe di San Gregorio Armeno. «La notizia di Gemito che moriva attraversò tutta Napoli. Si diramò dai circoli artistici ai vasci, dove campava il popolo che aveva chiamato Gemito “’o scultore pazzo”, ma con l’affetto di chi conosceva sulla propria pelle l’assurdo e l’oscurità della sorte. Tra quella gente prima passò un murmulìo di solidarietà, poi si fece il silenzio. Era un popolo impressionato. Maschi e femmine di varia forma. Chi a lacerta, chi a pulicino, iatta, serpe, sórece, passariello, lupo, coniglio, pesce, scheletro, scrofa, pecuriello. A molti di loro, nei momenti in cui c’erano stati buoni guadagni, Gemito aveva fatto del bene» (p. 317). Le analogie zoomorfe, a volte spinte – come s’è visto – fino all’identificazione, offrono un campionario inesauribile: e suggeriscono l’idea di un intrinseco nesso tra la capacità di partecipare della condizione di tutti i viventi e il talento di trarre figure umane dalla creta.
Un altro filo rosso del libro sono le immagini di Napoli. Fra le altre cose, Il genio dell’abbandono è una strepitosa galleria di scorci e vedute di strade, case, folle, persone, luci – come questa città al crepuscolo: «A Napoli, dai secoli dei secoli, il primo buio è preceduto da una malattia dei colori. Nascono screziature viola ‘e ffeneste, strisciate blu sopra gli astici, macule rossigne a ogni purtone. S’appìcciano fanali e lumi. Se stenne na segatura giallo oro annanz ‘e pputeche. In cielo la luna cresce continuamente, come un pane largo e appiattito. Iesceno ‘e viziuse, ‘e mariuole, ‘e femminielle, le ronde ubriache. Iesceno ll’uommene ammascarate, ‘e disperate, ‘e ‘mbrugliune. Stanno in uno squilibrio di collera, malaffare e debolezza. Con mani, cosce, sanghe, sforzo dei muscoli, purchiacche, mascelle, rabbiosamente a mostrare affetto per questa luce ammiscata ‘o nniro, sotto minaccia. A Napule l’ultima luce mescola morte e resurrezione» (pp. 129-130).
Come spesso avviene agli scrittori napoletani, il romanzo è anche il resoconto di un modo di vedere, di vivere Napoli (forse è impossibile vivere a Napoli senza vivere Napoli). Quella che emerge dalle pagine di Wanda Marasco è una napoletanità dolente e vitale insieme, vulnerabile ma non rassegnata; e soprattutto vertiginosamente profonda, non solo nelle oscurità della psiche. La voce narrante scruta e riferisce, oscillando fra straniamento e solidarietà, nella consapevolezza che nessuna compassione basta a scioglierne gli enigmi.
Wanda Marasco, Il genio dell’abbandono, Neri Pozza, Milano 2015, pp. 352, € 18.