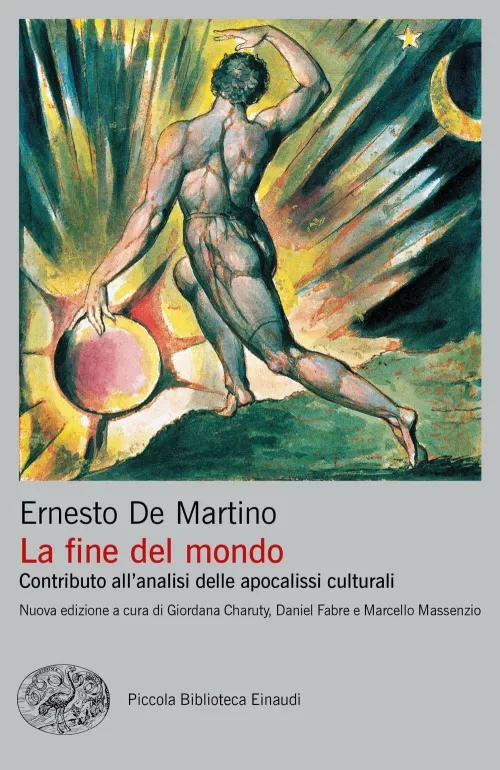Ernesto De Martino / Il mondo deve continuare, ma può finire
Ernesto De Martino (Napoli 1908 - Roma 1965), il nostro grande antropologo, dapprima studiò le persistenze di un mondo culturale antico sorprendentemente vive in diverse aree del Mezzogiorno d’Italia ancora a metà del XX secolo. Non fece coincidere l’isolamento geografico con un isolamento etnico dei contadini, visti anzi in rapporto dialettico con la cultura del mondo borghese dominante, e colse il salto fra culture tradizionali con un proprio universo di conoscenza e rimedi, e la società moderna disperata e dipendente da specialisti con delega totale circa il sapere sulla vita e la fine. Nelle ricerche che seguirono si affacciò, alcuni anni prima di morire, sull’interpretazione della sorte del mondo moderno nell’era dell’atomica e contemplò il senso e la possibilità del perire della società occidentale nella concezione della sua ultima perturbante opera, pubblicata postuma per la sua morte improvvisa e prematura: La fine del mondo. Contributo all’analisi della apocalissi culturali.
Di questo libro, a settembre 2019 è uscita, a distanza di tre anni dall’edizione francese del 2016, una nuova edizione italiana da Einaudi, che è ormai la terza dopo la prima del 1977, e la seconda del 2002, curate entrambe da Clara Gallini (Crema 1931 - Roma 2017), che a vent’anni seguì il suo maestro nelle ricerche in Sardegna. In quest’ultima versione, curata da Giordana Charuty, Daniel Fabre e Marcello Massenzio, il libro si rinnova alquanto, al di là dei nuovi criteri di ordinamento dei materiali e di selezione dello stesso che sfoltiscono il testo dalle citazioni non commentate, per un’ulteriore rilettura del pensiero di De Martino che vi circola ora più chiaramente di ieri.
Ernesto De Martino vi è consacrato come pensatore europeo, con la riconferma a distanza del superamento, già presente nella seconda edizione del 2002 da parte di Clara Gallini, delle perplessità espresse nella sua introduzione alla prima edizione che quest’opera concepita fra il 1960 e il 1965 aveva generato in lei circa l’attualità e il valore nel mondo contemporaneo.
L’antefatto che spiega la genesi di tali dubbi riguarda, così mi sembra, la legittimità del passaggio dalla prima fase, quella di Il mondo magico e quella “meridionale” dei suoi studi, alla seconda, in cui pure si riversavano i temi portanti della prima, percepita come slegata da quella concretezza, distante dai principi del materialismo storico e rivolta a un universo sempre più permeato da letteratura, filosofia, psichiatria (anche se già nel Mondo magico c’è il riferimento a Heidegger e Janet), forse da irrazionalismo o idealismo, e comunque inattuale.
Alla prima uscita il libro suscitò non solo perplessità, ambivalenze e sconcerto per la complessità e diversità dei campi disciplinari interessati, sconvolgente per la tradizione accademica, ma anche voci di apprezzamento, come quella di Carlo Ginzburg, che all’epoca lavorava al suo “paradigma indiziario”.
Formatosi nell’insegnamento di Alfonso Omodeo e di Benedetto Croce, De Martino intraprese strade di ricerca originali, non senza ritorni almeno temporanei o parziali nell’alveo originario, la cui origine è lo studio documentale degli usi delle culture tradizionali e in esse del magismo come sistema di protezione della labilità del soggetto intrinseca nel tempo aurorale dell’umanità in cui si colloca il primo drammatico differenziarsi dal mondo in cui era “gettato” dell’individuo come tale, come presenza, concetto cruciale in De Martino che sta a significare la pienezza della persona nella partecipazione e nell’azione nel mondo storico. Tali studi erano confluiti nel libro Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo (1948).
E proprio a questo libro, e «alla prima formulazione del rapporto problematico con il mondo», nucleo originario della stessa riflessione che ritroveremo in La fine del mondo, si ricollega l’apprezzamento di Ginzburg, che «propone di inserire Il mondo magico, [ ] così come Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno — assieme a Paura della libertà di Carlo Levi, Apologia della storia o mestiere di storico di Marc Bloch e Una storia modello di Raymond Queneau — in una costellazione europea di libri dell’«anno zero» scritti sotto la minaccia nazista del crollo di un mondo». L’apprezzamento si estende poi oltre, perché le differenti linee teoriche idealiste o ispirate a un’«antropologia maussiana di addomesticamento del mondo», riconducono una lettura storica di De Martino a «un contesto culturale non esclusivamente italiano», oltre a dimostrare un confronto serrato con lo storicismo e i suoi limiti.
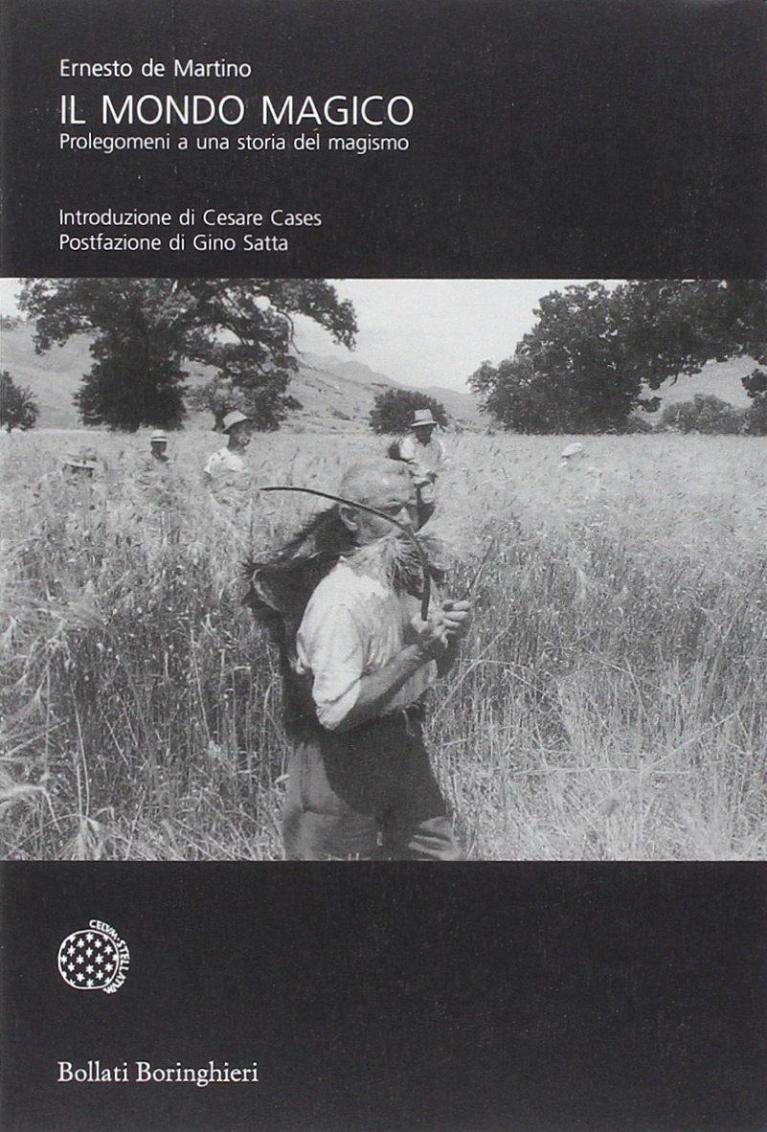
A quest’attività, e in continuità di senso, era poi seguito il lavoro sul campo nel sud d’Italia cui si accennava all’inizio, culminato nei libri della grande trilogia meridionale: Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria (1958), Sud e magia (1959), La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud (1961).
Ernesto De Martino aveva una mente geniale e due occhi “celestini” in un volto “ossuto, squadrato a linee dure”. Occhi “abituati a scrutare al di là dei confini del nostro tempo, del conoscibile”, e a guardare in faccia la morte. Come ricorda Clara Gallini nella prefazione all’ultima edizione di Morte e pianto rituale — libro di “tragica bellezza”, emblematico della sua potenza d’indagine, che avrebbe vinto sollevando inquietudine il premio Viareggio del 1958 — era un tale uomo che più di tutti poteva apprezzare la vita. Di fatto egli studiò sul terreno del nostro Sud con profondità e accuratezza di dottrina i modi sedimentati nei tempi dal lavoro della cultura per difenderne l’assoluto valore dagli attacchi del negativo storico. Del male che poteva assumere allora, fra le popolazioni studiate di un mondo arcaico e povero agro-pastorale, sostanzialmente pagano anche se nominalmente cristiano, la forma della malaria, della mortalità infantile, della grandine e della siccità, del fulmine che uccide il prezioso mulo di un contadino, della carestia, ma anche della volontà di dominio o addirittura della malevolenza altrui generate dalla brama amorosa o dall’invidia e portate ad effetto attraverso fatture e altri sortilegi come la pratica del malocchio, insomma da una magia aliena o ostile al soggetto, di cui De Martino non manca di cogliere l’analogo opposto, suo antagonista almeno altrettanto potente. Esso sarà descritto nelle sue opere come una magia benevola al servizio della vita e della permanenza del gruppo umano, come arsenale di incantamenti e rimedi, che non sono altro che dispositivi di funzionamento e atti rituali e psichici costitutivi di un sistema teorico che si sviluppa e si compie tuttavia nella sua complessità, facendo presto rilevare come non sia tanto la bassa magia cerimoniale a proteggere, ma l’idea che esista un principio al servizio del bene e della salvazione non solo dell’individuo, ma dell’intero gruppo umano di appartenenza. Con il distacco delle ipotesi soteriologiche come sistema di pensiero dalla magia come fenomeno circoscritto e situato nel campo della “metapsichica” il cui significato si esaurisce in singoli atti e scopi, viene introdotto il superamento della dimensione destinale dell’individuo nella sua finitezza, e l’ingresso in un sistema che sfugge alla presa del tempo storico — destorifica cioè il negativo sottraendolo al piano inesorabile della realtà contingente e a un tempo irreversibile — e apre a un diverso piano di realtà, al tempo ciclico della natura e della religione, alla reintegrazione della presenza e alla salvezza di tutti in un tempo mitico-religioso e in un escaton di là da venire, ma promesso, che supera la prospettiva della fine senza riscatto del singolo, o l’apocalisse di una civiltà. Questo tempo nell’orizzonte cristiano coincide con la parusia e la palingenesi, e non vi è la prospettiva dell’eterno ritorno, mentre nell’orizzonte laico, nella prospettiva marxista si vuole che la salvezza sia frutto dell’affermarsi di un pensiero razionale, e di un progresso forse da tutti idealizzato e dato per certo sul modello evoluzionistico o della progressione escatologica cristiana che si inscrive nel tempo irreversibile della storia.
Ritroviamo tale dispositivo e le sue articolazioni anche nella Fine del mondo. Ed è esattamente fra queste polarità che si muove sempre De Martino, con tutte le difficoltà, le contraddizioni, le aporie del caso, proponendo tuttavia modi alternativi o di integrazione delle due visioni, che nel suo progetto e nel libro trovano espressione e un accurato approfondimento da parte dei curatori.
In una fase successiva De Martino, quella che porta a La fine del mondo, e ancora una volta in continuità di senso a mio avviso, si aprì a una ricerca più astratta di sapore fenomenologico-esistenzialista — permeata dalla riflessione filosofica e dalla letteratura, nel riferimento ad autori come Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Albert Camus — avvertita come necessaria a fronte delle inquietanti incrinature della nostra società occidentale dopo i disastri delle due guerre mondiali. Essa implicava il confronto dell’antropologia con la psichiatria e la psicopatologia per indagare sulla possibilità della fine oltre il dramma del mondo magico, sui momenti critici dell’esistenza e della storia in cui è più forte il bisogno di un dispositivo di protezione per il singolo o per una comunità; sul declino dell’ordine mondano per il singolo uomo, e sull’eclissi di un mondo come evento ciclico o come rischio permanente di naufragio della cultura nell’abisso. Un confronto che serviva anche a riaffermare la differenza e l’autonomia culturale delle figure di espressione etnografica della crisi, come il tarantismo, momento di intenso disagio concomitante con un momento cruciale del ciclo agrario, dai quadri psichiatrici, come quello dell’isteria, e inoltre a rifiutare l’idea che essi possano esistere e determinarsi nel vacuum senza mondo in cui li oggettiva lo sguardo clinico collocandoli al di fuori di ogni dimensione culturale.
La differenza è assai chiara nella descrizione, ricordata nella premessa di Massenzio, che fornisce De Martino di una crisi di tarantismo “in statu moriendi”, cioè spogliata del supporto coreutico-musicale indispensabile per inscriverla in una partitura culturale e quindi in un’efficacia simbolica, cui assistette il 28 e 29 giugno 1959 nella Chiesa di San Paolo a Galatina.
Il quadro etnografico privato dell’integrità del suo corredo di colori e di partecipazione rituale con danze e suoni, ben noto allo studioso, si appiattisce riducendosi a disgregazione della presenza e del senso, a quadro clinico di un evento psicopatologico (secondo la clinica) irrelato: «Avevamo ancora nella memoria l’esorcismo musicale visto pochi giorni prima a casa di Maria di Nardò, così ordinato e regolare: [ ] ma ora davanti ai nostri occhi non vi era che un intrecciarsi di crisi individuali senza orizzonte, il disordine e il caos. In cappella non c’erano né la musica, né i nastri colorati, [ ] né tutto il vario simbolismo messo in moto dall’esorcismo musicale in azione: e in assenza di questo tradizionale dispositivo di evocazione e di deflusso i tarantolati naufragavano. [ ] Le scene che vedevamo dall’alto della nostra tribuna ad audiendum sacrum ci davano l’impressione di pietruzze colorate in un caleidoscopio in frantumi: inerti abbandoni al suolo, agitazioni psicomotorie incontrollate, [ ] scatti di furore aggressivo, e ancora archi isterici, lenti spostamenti striscianti sul dorso, abbozzi di passi di danza, tentativi di preghiere, di canti, conati di vomito».
Il passo immediatamente successivo del pensiero di De Martino è il confronto fra le apocalissi culturali e le apocalissi psicopatologiche.
Infatti, come rilevano ancora i curatori, «Situazione storica da un lato, condizione umana dall’altro: la tensione oppone dunque storia e ontologia, e De Martino avrebbe definitivamente posto l’accento su quest’ultima”. Il che autorizza a paragonare fra loro delle apocalissi culturali prive di connessioni storiche [ ] e soprattutto a introdurre la correlazione con le apocalissi psicopatologiche, i “deliri da fine del mondo”, vissuti individualmente».
Da un lato il mondo estraniato della Nausea di Sartre, in cui l’uomo è spaesato, dall’altro la perdita della “patria culturale”, la scomparsa della familiarità e riconoscibilità dell’ordine mondano, come nel caso della psicosi del contadino bernese.
Quella prospettiva, leggiamo oggi nell’introduzione di Charuty e Massenzio, assumeva “a oggetto d’indagine la condizione umana in generale”, nella consapevolezza che «Il Dasein, la presenza al mondo, è minacciata di dissoluzione per ogni uomo e ogni società, in ogni tempo e in ogni luogo».
Come fa notare Massenzio, De Martino ha individuato la radice del male di vivere “nella condizione umana in sé”, nell’angoscia del divenire, “nella relazione che l’uomo intrattiene col tempo e il suo fluire”, estendendo il rischio della crisi al di là del mondo magico, fra noi.
De Martino peraltro, con il criterio di trascendimento di sé nel valore, fornisce una cornice soteriologica laica attraverso la valorizzazione di un’intersoggettività culturale fra gli uomini, che può prescindere dalla perdita di contatto col sacro di oggi. Se ne avvantaggia l’uomo isolato dal divino, come pure lo schizofrenico che ha perso il legame col mondo, dunque l’uomo implicato nel passaggio “dall’abisso di Agostino e dei mistici all’abisso caotico e vuoto che inghiotte, il gouffre di Pascal e di Baudelaire”.
Il valore attuale della sua svolta epistemica per la comprensione delle apocalissi culturali sta anche nella ridefinizione della piattaforma e della prospettiva del proprio lavoro. Come osservano Charuty e Massenzio, essa non è più soltanto lo studio delle società arcaiche, ma l’incontro etnografico «in sé, nel contesto delle società contemporanee, in situazioni di ineguaglianza, di violenza, di dominio simbolico».
«L’oggetto intellettuale che ne scaturisce» osservano ancora Charuty e Massenzio, è «un progetto di “antropologia della storia” incentrato sulla relazione tra l’Occidente e l’“alterità”, piuttosto che un’antropologia della cultura con i suoi universali, come nel programma levi-straussiano».
E non c’è collisione fra i dispositivi salvifici delle società arcaiche e la prospettiva storicistica di progresso. È vero, come avverte l’autore, che «Il tempo ciclico è tempo della prevedibilità e della sicurezza: il suo modello è offerto dal ciclo astronomico e stagionale». Ed è vero anche che «nell’ambito della storia umana questa tendenza della natura diventa un rischio, perché la storia umana è proprio ciò che non deve ripetersi e non deve tornare, essendo questo ripetersi e questo tornare la catastrofe della irreversibilità valorizzatrice. Il tempo della prevedibilità e della sicurezza è per la storia il tempo della pigrizia, il rischio della naturalizzazione della cultura». Ma il tempo ciclico del mito non si oppone alla storia. La reversibilità del tempo e il ritorno dell’uguale, modi che segnano il tramonto e il risorgere dei mondi culturali nella concezione della fine come evento storicamente determinato, a fronte della fine come rischio antropologico permanente, sono solo un modo per “stare nella storia come se non ci si stesse”, proteggono la “storicità del divenire”, e preparano a un recupero valorizzante nella storicità di ciò che in un primo momento deve essere temporaneamente destorificato, sottratto nella dimensione mitica alla responsabilità e decisione umana.
De Martino ha cercato la difficile unificazione di saperi diversi in un vasto orizzonte di riflessioni che collega l’individuo al mondo, entro la cornice di un trascendimento di sé come possibilità morale e senso ulteriore rispetto alla trascendenza e alla sponda del sacro. Sempre entro la cornice delle possibilità dell’umano, ci ha mostrato che razionalità e irrazionalità non si contrappongono ma si integrano in magia e miti, forze e strutture capaci di creare realtà ulteriori rispetto a quella storica immediata. Come osservano Charuty e Massenzio, De Martino «sovverte l’opposizione fra individuale e collettivo, psicologico e sociologico, per legare insieme le trasformazioni della società e quelle dell’economia psichica come in Michel Foucault, come in Marcel Gauchet, quando analizza la crisi dell’individuo», e come in Norbert Elias quando si interroga sui processi di decivilizzazione».
La sua posizione rimane equidistante fra razionalismo e irrazionalismo, fra rielaborazioni laiche e religiose. Come rileva Cesare Cases nella sua introduzione a Il mondo magico, De Martino ha crocianamente considerato “l’importanza dell’individuo come una fonte di innovazione spirituale”; mentre il suo modo di correlare crisi e cultura lo ha avvicinato non a Freud, rimasto chiuso nella dannazione della coazione a ripetere, ma a Jung per aver questi mostrato il dinamismo del simbolo, che rompe l’isolamento del sintomo e apre la crisi alla reintegrazione attraverso il contatto col mondo dei valori culturali.
Non troviamo in De Martino semplificazioni pronte all’uso sul da farsi e sul nostro destino, ma un cosmo in cui muoversi in tutte le direzioni, in cui sono scardinati certezze e il tempo stesso come siamo abituati a pensarlo, e siamo chiamati alla consapevolezza dei nostri valori e limiti per costruire un mondo nuovo.
E allora dovremmo forse riflettere sulle parole ancora di Cases, quando sostiene che la fine del mondo non è nella fine, che paventiamo, della nostra civiltà occidentale, “nella forma del capitalismo e dei valori cristiano-borghesi da esso propugnati”, ma nella sua “spasmodica conservazione”, e che la sua fine soltanto, invece, “può rendere possibile la sopravvivenza e il dispiegamento dell’umanità”. L’apocalisse allora rappresenterebbe la rivelazione del nulla sul cui bordo già siamo, in attesa di un nuovo inizio.
Nota: Ho affrontato questi temi anche in “Rivista Sperimentale di Freniatria”, Vol. CXXIX, N. 2/2005, Psicopatologia e cultura nel pensiero di Ernesto de Martino, saggi di E. De Martino: Crisi della presenza e reintegrazione religiosa, e Il problema della fine del mondo; saggi di: Clara Gallini, Marcello Massenzio, Bruno Callieri e Mauro Maldonato, Roberto Beneduce. Numero monografico (con mio Editoriale).