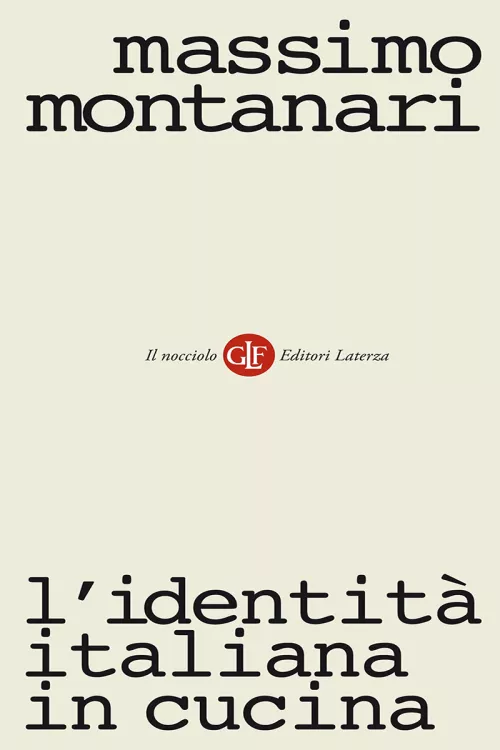L’identità in cucina
Massimo Montanari mette in rilievo nel suo breve libro L’identità italiana in cucina (Laterza 2010) che l’Italia esisteva già prima della sua unità nelle pratiche quotidiane, nei modi di vita, negli atteggiamenti mentali, ovvero che la cultura definisce il nostro Paese ben più dell’unità politica. Prima dell’Italia unita sotto il regno dei Savoia, diventato Regno d’Italia proprio in quel 1861, esiste il “Paese Italia”, come l’aveva definito lo storico Ruggiero Romano, ideatore della Storia d’Italia di Einaudi. Nel suo saggio Montanari sostiene che la koinè alimentare italiana si è formata attraverso l’incontro tra romani e “barbari” (termine romano). Si trattò di un incontro-scontro tra la cultura del pane, del vino e dell’olio (civiltà agricola romana) e la cultura della carne, del latte e del burro (civiltà dei “barbari”), legata più alla foresta che all’agricoltura stanziale.
Lo studioso dell’alimentazione riprende un’immagine attuale per proiettarla sul passato: l’Italia come rete di città: uno spazio materiale; dove circolano modelli di vita e abitudini legate ai territori urbani e limitrofi. In nessun altro paese europeo la realtà delle città, grandi e piccole, è stata così a lungo importante, là dove invece, in Francia, ad esempio, la gerarchia tra capitale e altre città appariva fortissima. Un doppio movimento, che si trasmette anche ai secoli successivi, è tipico del Medioevo, e poi del Rinascimento: centripeto, concentrato sui mercati cittadini che drenano le risorse del contado; e centrifugo, perché il mercato cittadino accoglie cibo e mercanzie provenienti anche da lontano. La campagna produce e la città consuma, uno stile di scambio rimasto intatto sino agli anni Cinquanta del XX secolo.
Montanari segue le vicende dei ricettari di cucina che appaiono in Italia a partire dal XIV secolo: due famiglie principali, una meridionale e una toscana. Il Liber de coquina redatto alla corte angioina di Napoli nel Trecento e poi i ricettari dei palazzi borghesi, sono le due tipologie principali: Palermo, Napoli, Siena, poi anche Bologna, Firenze e Venezia. Ma cosa si cucina e cosa si mangia? Pasta, prima di tutto, anche se non si tratta di un piatto esclusivamente italiano, come ha mostrato Franco La Cecla in La pasta e la pizza (il Mulino 2002), ma che in Italia conosce una varietà straordinaria di cui oggi gli scaffali dei supermercati registrano solo una pallida memoria: lunga, corta, forata, ecc.
Al Sud la gastronomia è rurale, al centro-nord invece urbana; così che nella seconda c’è una sottovalutazione degli ortaggi, inadatti alla mensa signorile (aglio e cipolla sono prodotti esclusivamente contadini per lungo tempo). Anche se poi, alla fine, e più di altre civiltà europee, quella italiana risulta dall’integrazione di cultura popolare e cultura d’élite. Da tutto questo emerge che la cultura alimentare appare socialmente diffusa tanto da far dire allo studioso che esiste da molti secoli un patrimonio gastronomico nazionale, dal momento che i ricettari, prodotto delle classi dirigenti, riflettono l’integrazione tra città e campagna, cibi del popolo e cucina d’élite. Uno dei tratti di unità tra alto e basso, popolare e aristocratico sono le conserve, di cui il patrimonio industriale del nostro Paese ha raccolto la memoria negli ultimi cent’anni.
Nel suo libro lo storico dell’alimentazione scrive una cosa che dovrebbe farci riflettere quando parla di cucina, ovvero di quelle che ogni italiano considera le imprescindibili origini e tradizioni, insieme al dialetto: “la ricerca delle proprie radici finisce sempre per essere la scoperta dell’altro che è in noi”. Una frase su cui vale la pena di soffermarsi, se si pensa poi ai divieti di alcuni sindaci del Nord Est valsi a impedire la diffusione di cibi “altri”, della tradizione orientale e islamica. Le identità culturali si creano nel tempo e attraverso l’osmosi e lo scambio con gli “altri”. Non c’è niente di autoctono e assoluto a tavola, ma un continuo cambiamento, a partire da quella integrazione tra burro e olio, barbari e romani. Il campanilismo italiano, anche in cucina, è l’altra faccia di questo movimento di ibridazione continua (“mangiarape”, “mangiafagioli”, “mangiapolenta”, ecc.).
Tutto è cambiato con l’avvento del governo spagnolo a Napoli, a partire dalla metà del Cinquecento. L’inefficienza del mercato e la diminuzione delle risorse, come ci ha spiegato lo storico del paesaggio Emilio Sereni, porta all’avvento della pasta che sostituì nella dieta popolare carne e verdura, soprattutto cavoli. Una vicenda che ha influenzato fortemente anche la tavola e i piatti del Nord a seguire. Da lì comincia l’accoppiata vincente pasta-formaggio, con l’aggiunta del pomodoro nell’Ottocento ,che prese il sopravvento sulla coppia cavolo-carne. Una soluzione geniale dal punto di vista nutritivo su cui si istituisce una identità italiana dopo la spedizione dei Mille. Il 7 settembre 1861 Garibaldi entra a Napoli e Cavour in un linguaggio non troppo cifrato scrive: “I maccheroni sono cotti e noi li mangeremo”. Il Nord mangia il Sud? Certo, ma è anche il segno di una integrazione alimentare, forma della nuova unità raggiunta dalle camicie rosse e dalla loro impresa. Nel suo libro La Cecla scrive che la coperta mediterranea è tirata a nord e di questo i maccheroni sono una delle componenti essenziali. Per arrivare a una sintesi che vale anche sul piano geopolitico, possiamo dire che in cucina le tradizioni locali, i dialetti alimentari, non si oppongono all’italiano, bensì lo completano. L’identità del paese appare, anche vista sotto quest’aspetto, come locale e insieme cittadina, regionale eppure anche nazionale.
Seguendo il tracciato descritto da Montanari riguardo l’identità geografica del cibo, si scopre che il metodo applicato da Artusi al suo ricettario, opera collettiva redatta da un solo autore, è fondato su una triade regionale: Romagna, Emilia e Toscana; e per quanto riguarda i condimenti al burro e all’olio (Lombardia e Toscana), cui si aggiunge il lardo (Emilia). I destinatari del libro non sono più le corti principesche o i maggiorenti delle città, bensì la nuova piccola e media borghesia. Artusi introduce un sistema gastronomico fondato sulla “minestra”, che è non solo quella in brodo, ma anche la pastasciutta. Insomma, quello che nel secolo seguente, e ancora oggi, si chiama “il primo” e “il secondo”, superando la cultura del “piatto unico”. Il pubblico borghese si siede a tavola e apparecchia sia il primo che il secondo; le classi popolari usano la pasta come primo e anche come piatto unico. Questo modello gastronomico definisce una identità italiana negli anni a seguire e istituisce anche la “cucina moderna”, così che i manuali seguenti, dal Talismano della felicità di Ada Boni del 1925, per passare dal Cucchiaio d’argento, curato da Clelia D’Onofrio, sino ad arrivare Cotto e mangiato di Benedetta Parodi, best seller contemporaneo, saranno una derivazione o deviazione dall’Artusi, modello insuperato per scrittura letteraria e capacità di sintesi culinaria.
Un mito che bisognerebbe dissipare è quello legato ai confini geografici: l’invenzione delle cucine regionali. Le regioni vengono istituite in una cartografia postunitaria assai complessa, legata a problemi storici e locali di cui la Romagna, descritta da Roberto Balzani nel suo La Romagna (il Mulino 2001), è un esempio perfetto: una regione dai confini mobili e spesso inventati. Vito Teti ha scritto che la cucina delle regioni italiane è un’invenzione postmoderna, dove confluiscono “elementi disparati, frammentari, disomogenei, provenienti da diverse località di una stessa regione e spesso da altre regioni”.
Per datare il regionalismo culinario, bisogna arrivare al 1928, quando, ci ricorda Montanari, in una riunione del Rotary Club di Milano, alla presenza del sottosegretario fascista, Arturo Marescalchi, si decide di fare un inventario del patrimonio alimentare italiano. Il Touring Club lo realizza con una Guida gastronomica d’Italia (1931) che suddivide prodotti e ricette per regioni e poi, all’interno di ciascuna regione, per provincie. Una scelta ambigua, dicono gli storici dell’alimentazione, che fa riferimento alle ripartizioni amministrative dello stato (questo sono le Provincie e le Regioni), che poi entreranno nella Costituzione del 1946 per essere attuate solo nel 1970. Un’identità creata a posteriori che definisce unità culturali, storiche e geografiche differenti. Nei sussidiari delle scuole, a partire dalla metà degli anni Trenta, per arrivare agli anni Settanta, e anche oltre, ci sono sempre state delle tavole che affidavano i piatti e i prodotti tipici a questa o a quella regione, comprese le specialità gastronomiche (ad esempio, la mortadella al nord di Bologna). In questo modo “la cultura gastronomica italiana risulta polverizzata, irriducibile a spazi ‘politicamente’ determinati come quelli delle provincie e delle regioni”.
Si vuol far calare, anche per l’alimentazione, l’Italia policentrica dentro una gabbia forzando la realtà storica con la geografia ricreata ad hoc, così da creare equivoci e fraintendimenti, anche se senza dubbio risulta una linea vincente perché più facile da gestire e da comunicare. Una vittoria di Pirro dell’identità italiana, destinata sul lungo periodo a mostrare la corda, oltre che un retaggio del Fascismo e della sua volontà di ridurre le identità possibili a una sola, o solo a quelle marchiabili con il logo delle singole Regioni. Possiamo concludere che l’indole dialettale della cucina italiana non è mai venuta a meno; e se nella storia letteraria e linguistica del Bel Paese hanno vinto i toscani della terna sacra (Dante, Boccaccio, Petrarca) grazie agli auspici della Accademia della Crusca,, la storia della cucina non ha conosciuto nessun Dante né accademia unificatrice, e anche nel caso dell’Artusi, il lessico alimentare non schiaccia le identità, ma le avvicina e le unifica senza eliderle.
Così oggi l’Italia con le sue mille identità di campanile, paese, città, con le sue forme municipalistiche, a volte rissose o bizzarre, si trova nella felice posizione di chi può vantare un modello culinario e alimentare più funzionale per accogliere, come è accaduto ai nostri predecessori, la sfida del glocale, che sembra il destino comune a noi come a tutte le nazioni e paesi dell’Europa, e non solo. Tra geografia terrestre e geografia umana - quella alimentare, in particolare - possiamo sostenere che noi italiani siamo uniti, ma sempre nella diversità.