Pensiero, Politica, Poesia / Martin Heidegger e i Quaderni Neri
“Tutti parlano, nessuno ascolta. Ognuno scrive, nessuno pensa”, scriveva Heidegger nei suoi Quaderni Neri, Note I-V.
A qualche anno dalla lettura in traduzione italiana dei primi tre volumi (Riflessioni) e a qualche giorno dall’ultima pagina del quarto (Note I-V), in attesa del prossimo quinto tomo dei Quaderni Neri di Martin Heidegger, si può tentare un’impressione (o una tempesta di impressioni) su questo lascito enorme (quantitativamente e qualitativamente enorme) del “mago di Messkirch”? La risposta è, obbligatoriamente, nel segno del dubbio. Si può, si deve, con cautela ed entusiasmo insieme.
Innanzitutto, però, il lettore italiano dovrà render grazie a chi (editore e traduttrice) gli ha reso possibile la lettura: il coraggio della casa editrice Bompiani nell’affrontare una pubblicazione che richiederà anni di impegno (che è facile prevedere non verrà compensato in termini economici), il coraggio della traduttrice Alessandra Iadicicco che da sola si è assunta l’onere dell’impresa e l’ha condotta con tutta l’attenzione immaginabile agli abissi linguistici dell’originale.
Ed anche, preliminarmente, andrà sgombrato il campo dai dubbi sulla necessità della pubblicazione in tedesco e di conseguenza in traduzione dell’opera, da prese di posizione per cui l’edizione dei cosiddetti Quaderni Neri sarebbe una semplice operazione di marketing intesa a riaprire querelles ormai superate sull’autore, sul suo pensiero, sul suo peso politico dagli anni Trenta in poi. Basta in verità la lettura di qualche pagina per intuire la rilevanza di quei quaderni dalla copertina nera, per volontà dell’autore rimasti segreti per decenni ma – sempre per volontà espressa dell’autore – da pubblicarsi dopo la sua morte: altro che testi superflui che nulla aggiungerebbero a quanto già si conosceva (e a quanto conta) nell’opera del filosofo; il pericolo qui, se mai, è la sovrabbondanza degli stimoli offerti in cui il lettore – anche il più sagace – rischia di smarrirsi. Perché naturalmente ancora più arduo sarebbe affrontare con successo lo studio di questi testi senza una adeguata mappa del pensiero heideggeriano con le svolte e i sentieri interrotti e le contraddizioni che lo incidono dai primi scritti fino a quelli dell’avanzata maturità. I Quaderni – con la loro tonalità “privata” (a tratti quasi diaristica), con l’impressione di confidenze in assenza di confidenti – non solo supportano la conoscenza delle opere pubblicate e a loro coeve ma – per circa quarant’anni, dal 1931 in avanti – chiariscono di una luce a tratti accecante il tortuoso percorso di un pensiero centrale per tutto il Novecento. Con questi testi (e con ogni probabilità, con quelli ancora inediti della sua opera titanica), Heidegger si conferma davvero se non un pozzo senza fondo, certo un pozzo filosofico abissale con cui è impossibile non “fare i conti”.
Di fronte a testi che, per loro natura, non si lasciano riassumere (quale testo davvero grande può essere riassunto?), possiamo tentare di disporre una serie di opposizioni su cui l’estensore di questi manoscritti circolarmente (ossessivamente) ritorna con variazioni – riprese, aggiunte, sottrazioni – durate decenni e tutte segnate da accadimenti (pubblici, privati) che ne tatuano le direzioni di senso. Tra le numerosissime coppie di opposti che costituiscono l’impalcatura dei Quaderni, eccone alcune, veri e propri nuclei tematici che prendono sviluppo nelle migliaia di pagine del testo: essere(Sein)/ente semplicemente presente; storia/storiografia; pensiero/macchinazione; silenzio/chiacchiericcio; i pochi/i più; pensare e poetare/filosofia e letteratura; il superfluo/il calcolo; il gratuito (la gratitudine)/ l’utilizzabile; la grandezza/il colossale; l’iniziale/il moderno; l’essenziale/ciò che dà nell’occhio; la poesia/la metafisica; Hölderlin/Goethe; pensiero incalcolante /prestazione; impronunciato/convenzionale; la natura/la tecnica; il destinale/la moda; solitudine/ pubblicità; pensiero/giornalismo(assoluto); pensare/sapere; raro/abbondante; invisibile/pubblicizzato; qualità/quantità; originale/imitazione; Essere(Seyn)/Nulla; poeta/profeta; radura(Lichtung)/adombramento(Beschattung); montagna(Todtnauberg)/città(Berlino); nobili/calcolatori e, naturalmente, Heidegger/Jaspers… Opposizioni in cui, appare evidente, il primo termine è sempre sotto il segno dell’autenticità e il secondo gli si oppone nel segno dell’inautentico; in altri termini, Heidegger elabora un universo di pensiero in cui l’esercizio del pensiero è sempre un pòlemos per il quale è in gioco la sorte stessa del mondo (occidentale e poi, sempre più, globale). In questo lavoro – insieme sotterraneo ed evidente – Heidegger ribattezza molti loci della filosofia, accoglie parole antiche attribuendo loro direzioni semantiche inedite o addirittura opposte rispetto alla tradizione, si esercita in quel vocabolario inconfondibile che sempre più gli sarà proprio.
Il caso più clamoroso di questo lavorio sulla lingua è quello riguardante il termine sovrano della filosofia, quello di “metafisica” che, come è noto, in Heidegger designerà sempre più convintamente tutta la tradizione filosofica occidentale (da Socrate in poi, Nietzsche compreso!) allargando di molto la connotazione ristretta legata alla sua origine storica e all’opera aristotelica, al punto da divenire l’equivalente di “corso vincente della tradizione filosofica occidentale”, inglobando modernità e tecnica, e lasciando fuori solo i pensatori “iniziali”: i Presocratici, appunto. Dominio “metafisico” di scienza-tecnica (la “Machenschaft”) e domanda essenziale (la “Seinsfrage”, la domanda dell’essere) ingaggiano allora una lotta mortale che non ha più il suo luogo di elezione nella decisione del singolo (come in Essere e Tempo) ma nella storia stessa del mondo. La progressiva e plurimillenaria dimenticanza dell’essere potrà riuscire a un nuovo imprevedibile inizio dopo quel “primo inizio” che fu proprio dei Greci all’epoca di Eraclito e Parmenide. Ecco posta la questione suprema ed estrema che potrà essere tentata solo nella solitudine e nel silenzio dei “pochi” (“una stirpe di nascosti guardiani del silenzio”) perché solo nel tacere e nell’estrema riservatezza potranno darsi l’apertura e la radura dell’ascolto (non cercato e mai intenzionale) dell’essere:
“L’inizio non è il frutto della grazia di questi pensatori (Anassimandro, Parmenide ed Eraclito, n.d.a.), con cui essi operano in questo o quel modo, al contrario: l’inizio è ciò che fa iniziare in questi pensatori qualcosa, poiché li reclama in un modo tale da esigere da loro un arretramento estremo di fronte all’essere.” (da Parmenide, semestre invernale 1942-’43, trad. it. di Giovanni Gurisatti, Milano, 1999, p.41) .
Come nei lavori coevi degli anni ’30-’40 e, se mai, in modo ancora più compulsivo, nei Quaderni Neri pare delinearsi una straordinaria “Fenomenologia dell’Impensato” per la quale la lingua filosofica dominante, impostasi in duemilacinquecento anni di storia occidentale, non pare attrezzata. Da qui, nei Quaderni, la conquista di una lingua altra, sempre più restia al vocabolario della “metafisica” e sempre più vicina alla lingua essenziale e originaria dei frammenti di quei primi pensatori.
Insieme a questa esigenza di dire in una lingua “nuova” perché antichissima, troviamo però in questi scritti anche una pulsione – di direzione apparentemente opposta – verso la cronaca più immediata, i fatti politici, sociali, culturali, militari, addirittura verso le novità quotidiane dei giorni in cui l’autore stende le sue riflessioni, con una tendenza – caratteristica di Heidegger – ad accostare (a far cortocircuitare) macrostoria del pensiero ontologico e microstoria dell’attualità (tedesca, mondiale) che il filosofo sta vivendo. Storia dell’essere e notizie di cronaca collidono e si interpretano a vicenda con esiti talvolta paradossali: si vedano le spiegazioni “ontostoriche” sull’andamento della guerra, sui discorsi dei politici, sugli articoli dei giornali, sulla catastrofe della Germania tra ’44 e ’45… Il pensatore non si trattiene da arditi accostamenti che, se paiono incongrui ed irrazionali, spiegano anche la fascinazione che esercita un pensiero per sua natura totalizzante che non accetta la comprensione “iuxta propria principia” di fatti abitualmente vissuti come “non pertinenti le discipline filosofiche”(!) ma che tutto deve far rientrare in una visione onnicomprensiva del reale. Si legge, ad esempio, in una “riflessione” del 1939 in cui si tratta del soggettivismo da Cartesio a Spengler:
“…solo nel xx secolo comincia il completo e concluso dispiegamento essenziale della modernità – l’intima conseguenza di esso sono le ‘guerre mondiali’ – come la gara di coloro che sono divenuti ‘liberi’ ‘soggetti’ del mero voler ‘vivere’” (Q.N. 1938-1939, p.542)
e in una “nota” scritta a guerra conclusa:
“Per quanto tremende da sopportare siano la distruzione e la devastazione che adesso sopraggiungono sui tedeschi e sulla loro terra natia, tutto questo non raggiungerà mai l’autoannientamento che ora, nel tradimento al pensiero, minaccia l’esserci” (Q.N., Note I-V, p. 112).
E qui si innesca il respiro anche politico dei Quaderni che tante polemiche ha generato e che rischia di ridurre quest’opera monumentale a una serie di passaggi da analizzare al microscopio delle convinzioni ideologiche dell’autore per eventuali condanne senza appello o, nel campo avversario, per le arringhe di altrettanto convinti innocentisti. Il rischio è cioè quello di assistere, con la progressiva pubblicazione di questi volumi, a una riedizione più o meno corretta di ciò che già è accaduto nell’immediato dopoguerra e non solo per il filosofo tedesco ma per più di uno scrittore europeo (il caso Céline tuttora aperto ne rappresenta la punta plateale con disfide “intellettuali” che di intelligente hanno davvero poco). Il rischio – già in corso – è che Heidegger torni a essere terreno di caccia dei “profeti al contrario”, quelli che giudicano il passato (complicato) alla luce del presente (anch’esso complicato) con il facile giochetto del dito facilmente puntato.
La conseguenza nefasta sarebbe che – come per l’opera céliniana – “tutti” fossero a conoscenza dell’iniziale adesione al nazionalsocialismo di Heidegger senza aver mai letto una riga del filosofo, avendo trovato – con la scusa del “politically correct” – un buon motivo per non affrontare un pensiero arduo e intellettualmente assai impegnativo. Una cosa, quindi, guadagna a essere chiarita: Heidegger e la sua filosofia non possono essere confusi con un qualsiasi pronunciamento ideologico di un qualsiasi ideologo degli anni ’30-’40: chi lo fa o è in malafede (causa ideologia) o in stato di non conoscenza di un’opera vastissima e notoriamente “non facile” (causa pigrizia mentale). Le condanne tanto sbrigative quanto sommarie sembrano desiderare, per Heidegger, uno specialissimo tribunale di Norimberga dove, al posto dei giudici nominati dalle potenze vincitrici, ci fossero altrettanti filosofi sedicenti democratici.
A evitare sceneggiate di questo genere, c’è un solo rimedio: leggere leggere leggere e studiare studiare studiare…
L’accusa è a volte vaga a volte precisa (anche troppo precisa), a volte singolare a volte plurale.
Heidegger sarebbe colpevole di aver aderito al nazionalsocialismo con il suo Discorso di Rettorato del ’33-’34? Questa operetta (L’autoaffermazione dell’università tedesca) è – come ebbe a dire il suo allievo Karl Löwith – “un discorso di alto tenore filosofico e di grandi pretese, un piccolo capolavoro nella formulazione e nella composizione. Alla luce della filosofia è un’opera straordinariamente ambigua… e chi lo ascolta alla fine non sa se deve prendere in mano la silloge dei presocratici curata da Diels o marciare con le S.A.”; chi conosce questo Discorso non può non apprezzare la puntualità (anche ironica) della definizione di Löwith: al termine della lettura, non sai se acquistare i frammenti dei presocratici nella più vicina libreria o unirti ad un corteo delle Sturmabteilungen… Ci troviamo nella fase politicamente entusiastica del rapporto con il neonato regime che Heidegger carica di illusioni tutte filosofiche e tutte heideggeriane, illusioni che lo abbandonano quasi subito tanto da spingerlo a lasciare ben presto la responsabilità di rettore dell’Università di Friburgo:
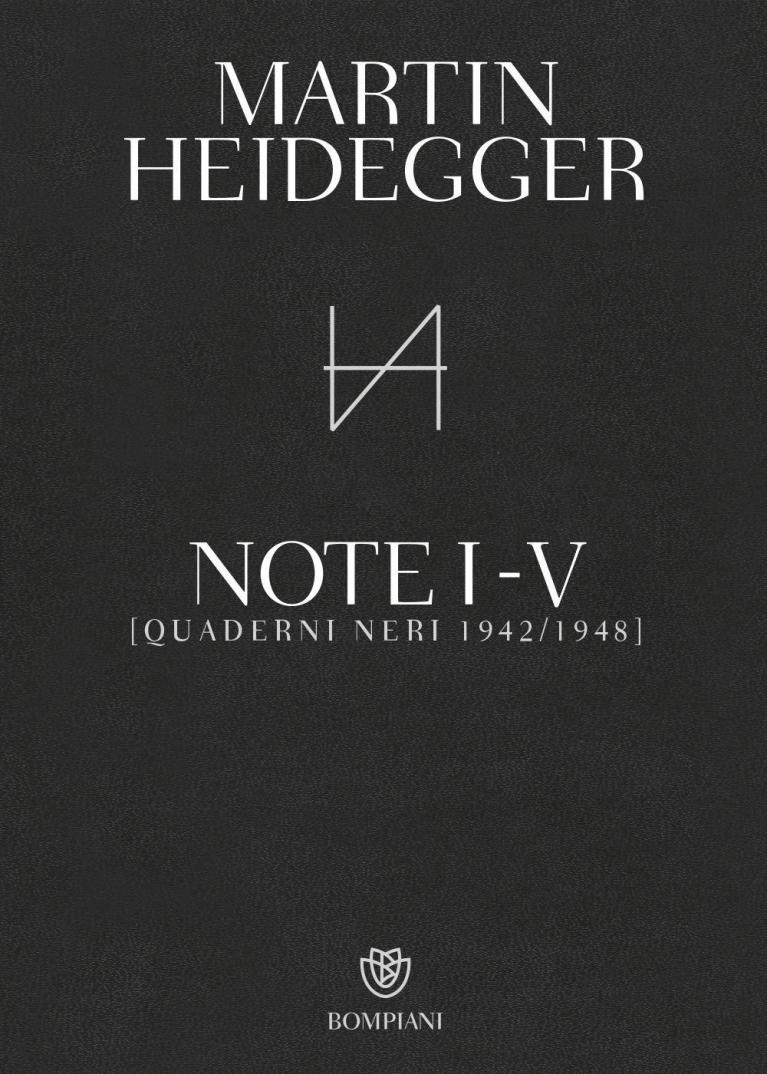
“L’autentico errore del ‘Rettorato del 1933’ non fu tanto che io, come altri più furbi, non riconobbi ‘Hitler’ nella sua ‘essenza’ e nell’epoca che seguì me ne stetti da parte brontolando nell’ambito della mancanza di volontà – vale a dire nello stesso ambito dei volenti –, bensì che credetti fosse arrivato il tempo di diventare, non con Hitler ma con un risveglio del popolo nel suo destino occidentale, iniziali-storici.” (Q.N., Note I-V, p. 149);
“L’errore del 1933 consisté nel fatto che non si riconobbe quanto poco preparate potevano essere le forze, quanto poco storicamente appropriate, quanto poco libere nonostante il necessario dogmatismo” (Ivi, p. 197).
Oppure Heidegger sarebbe colpevole di non aver condannato il regime fra il ’34 e il ’45? L’accusa “tiene” se aggiungiamo l’avverbio “pubblicamente” perché “privatamente” (nei Quaderni, appunto) scopriamo un pensatore spesso critico (a tratti anche sarcastico) nei confronti del nazionalsocialismo e dei suoi miti (il “colossale” in ogni campo da Heidegger considerato segno di piccineria e non di grandezza; gli scritti del teorico di regime Alfred Rosenberg; il razzismo nella sua versione biologistica; il culto di Wagner; i discorsi del capo della gioventù hitleriana Baldur Von Schirach che “non si prendono nemmeno più sul serio”; l’incomprensione del pensiero di Friedrich Nietzsche; l’entusiasmo per la mitologia eroica di Jünger…).
O, infine, colpevole di non aver riconosciuto il suo “errore” politico dopo il ’45? Su questo punto, l’ultimo volume dei Quaderni Neri finora tradotti in italiano è particolarmente eloquente: il libro – come si è detto – interessa anche gli anni dell’immediato dopoguerra e ogni volta che accenna al discorso della “nuova Germania”, quella uscita disastrata e divisa dal conflitto, Heidegger “scandalosamente” parla di sostanziale continuità col regime precedente: collocandosi da un punto di vista “alto”, quello del pensiero dalle lunghe campate, attento a scorgere anche nell’attualità l’arco maestoso della storia dell’essere, egli accosta i due sistemi politici (hitleriano e democratico) sottolineando se mai la maggiore rozzezza del primo e la maggiore ipocrisia del secondo:
“Non abbiamo bisogno di ‘ideali’ né democratici né fascisti; non abbiamo affatto bisogno di alcun ideale politico, meno che mai però ci servono l’influenza morale e l’educazione politica di altri” (Ivi, p.59);
“Gli antifascisti sono gli infiniti schiavi del grande fascismo in arrivo. Quello che in America e in Russia si chiama democrazia” (Ivi, p.332).
È proprio in nome della sua freddezza nei confronti del regime a partire dal 1934 che Heidegger si sente autorizzato, nei suoi quaderni, ad apparire (se non altro di fronte a se stesso) come lineare oppositore della “nuova” Germania uscita dalla guerra.
Coerentemente Heidegger non credette mai nella democrazia, né prima del ’33 né dopo il ’45; la definì sempre come “inganno” e inganno mondiale, causa ed effetto di Modernità e di Tecnica, concretizzazione storica dell’“oblio dell’essere”, corrispettivo politico dell’affermarsi dell’“ente semplicemente presente”. “Io non sono un democratico, e unicamente per la ragione che non posso esserlo” avrebbe potuto scrivere di sé ricalcando quanto scrisse del suo non-cristianesimo: “Io non sono un cristiano, e unicamente per la ragione che non posso esserlo” (Ivi., p. 266).
Inestricabilmente associato alle sue convinzioni “politiche” ma ancor più inestricabilmente incuneato (diremmo “incastrato”) nella sua ontologia, è il particolarissimo modo in cui Heidegger partecipa dell’antisemitismo tedesco. Oggi il lettore italiano può disporre di un libro che costituisce un aiuto nell’indagine di questo aspetto della vita e del pensiero (e della fama e del rigetto) del filosofo di Messkirch. Si tratta di Heidegger e gli ebrei di Donatella Di Cesare (Torino, 2014 e 2016) tutto incentrato – come il titolo dice – sui rapporti (personali e filosofici) che il pensatore intrattenne con gli ebrei (nei più diversi ruoli di allievo, di maestro, di amico, di amante, di avversario), con la tradizione ebraica, con il posto occupato dall’ebraismo nella storia tedesca ed occidentale. Sulla vexata, anzi vexatissima quaestio, l’autrice, partendo proprio dai Quaderni Neri, ci conduce in un periplo attorno al continente dell’“antisemitismo filosofico” a suo modo specifico rispetto all’antisemitismo teologico (Lutero!), a quello delle credenze popolari e a quello più strettamente politico (Mein Kampf). Da Kant a Nietzsche passando per Hegel la filosofia tedesca ha diversamente trovato nella figura dell’ebreo e nelle vicende della diaspora la propria pietra d’inciampo e l’ha diversamente collocata all’interno dei propri sistemi di pensiero. Tappa finale di questa vicenda storico-ideologica, in Heidegger l’ebreo viene ad assumere i tratti “figurali” dell’uomo sradicato (senza suolo e senza mondo), incapace di ascoltare l’essere perché tutto immerso nell’avventura dell’“ente semplicemente presente” che è poi l’universo della modernità, della scienza, della tecnica, del pensiero calcolante. La colpa per eccellenza del popolo tedesco non è per l’Heidegger del “dopo Auschwitz” quella della persecuzione e della volontà di annientamento degli ebrei e dell’ebraismo, ma il misconoscimento del proprio destino ontostorico:
“Non sarebbe, forse, ad esempio, il misconoscimento di questo destino – che non ci apparteneva, e non sarebbe forse il discredito della volontà del mondo – se pensato in base al destino, una ‘colpa’ ancora più essenziale e per giunta una ‘colpa collettiva’, la cui grandezza, nell’essenza, non può nemmeno essere misurata sull’orrore delle ‘camere a gas’ –; una colpa più inquietante di tutti i ‘crimini’ pubblicamente ‘stigmatizzabili’ – che certo in futuro nessuno potrà mai scusare? ‘Si’ ha un’idea del fatto che ora il popolo e la nazione tedesca sono un unico campo di concentramento – come ‘il mondo’ comunque non l’ha ancora mai ‘visto’ e che ‘il mondo’ non vuole nemmeno vedere – questo non volere, ancora più volente della nostra mancanza di volontà contro l’imbarbarimento del nazionalsocialismo. Quale potrebbe essere la conseguenza? Che da una parte gli uni ricadano nel tempo che precede il 1932 e gli altri si intendano di nuovo sul nazionalsocialismo, credendo che esso abbia ‘certo avuto ragione’” (Ivi, p.134).
Nel groviglio di sciagura nazionale e di sciagura personale (l’allontanamento dalla cattedra e il successivo pensionamento da lui vissuti come punizione per reati mai commessi) Heidegger accosta colpe per noi inaccostabili: quella storica dei campi e quella ontostorica del misconoscimento dell’essenza destinale del proprio popolo.
Infine, la Poesia. Si infittiscono, negli anni dei Quaderni, le citazioni e le riflessioni sui poeti e gli scrittori più frequentati ed amati: oltre ai classici greci (Pindaro, Eschilo), i tedeschi Hölderlin ovviamente ma anche Trakl e Rilke, perfino Melville, e, negli anni ’40, Adalbert Stifter). I passi che li riguardano non sono mai fini a se stessi né semplice indice di preferenze stilistiche o tematiche ma muovono dal progressivo convincimento che è nella lingua dei poeti che l’essere in qualche modo traluce e – eracliteamente – “semàinei” (dà segni).
C’è, nei Quaderni, un progressivo dire in versi ciò che non può essere detto nel linguaggio della metafisica, ciò che, nel tempo della dimenticanza dell’essere, solo i poeti hanno potuto custodire e tramandare.
D’altra parte la nostalgia (termine non heideggeriano) per il pensiero aurorale dei grandi presocratici (anch’essi in fondo avvertiti come poeti) conduce naturalmente alla poesia, in particolare a quella poesia che pensa cantando, e proprio Hölderlin è qui chiamato “cantore pensante”. È all’opera una convinzione sulla comune radice di canto e di pensiero (e sulla possibilità di una poesia filosofica) che per noi italiani porta il nome di Giacomo Leopardi (il ricordo va al bel saggio di Antonio Prete Il pensiero poetante del 1980 dedicato appunto al poeta-pensatore dei Canti e dello Zibaldone). Non è alla “Poesie” che va l’entusiasmo di Heidegger ma appunto alla “Dichtung”:
“Inutilmente oggi noi cerchiamo la poesia (Dichtung) nella poesia (Poesie) e in ciò che vale per essa. Si crede che l’abile esercizio dei giochi di parole con i versi e le rime sia lirica. Si crede che l’aspetto colossale del romanzo colga il reale. Si crede che l’elemento azzeccato dei drammi teatrali sia nella raffigurazione degli avvenimenti del tempo. Forse il poetare dovrà solo vagare per lungo tempo attraverso un pensiero che a sua volta è la peregrinazione (Wanderschaft) nello stesso” (Ivi, p.366)
e, a conferma:
“Ho la sensazione che siano ancora necessari cento anni di nascondimento fino a che si abbia idea di che cosa sia in attesa nella poesia di Hölderlin” (Ivi, p.94)
oppure:
“È meraviglioso che sia un poeta a portare il cognome Stifter, ‘fondatore’ sicché egli si chiama con il nome di quel che è” (Ivi, p. 9).
La cosa qui delineata si fa convinzione al punto che il pensatore stesso tenta la sua Dichtung:
“Nocciolo e grano
stella e sorgente
accennare il sentiero
per raccolta e semina
di luce e pane
componimento e morte” (Ivi, p.352)
oppure:
“Le spighe mature oscillano con suprema bellezza sui lunghi steli nell’aria della sera. Perché non dovrebbe anche un pensiero tardivo oscillare – nell’enigma?” (Ivi, p.380).
E con ironia ed autoironia:
“Si va ora raccontando che Heidegger sarebbe un cattivo poeta, ma non un filosofo. Quelli che parlano così sono buoni filosofi. (…) Un cattivo poeta è comunque un poeta. E se il pensiero opportuno che cerca di pensare l’Essere fosse un poetare? (…) Che ne è allora di un cattivo poeta? Egli potrebbe quanto meno essere forse in cammino verso il pensiero.” (Ivi, p.265).
Davanti a una Natura che è insieme silenzio bellezza e accenno, nel solitario tacere dei pochi pensanti, compagno dei grandi accennanti l’Essere, lontano dal frastuono della città e dell’accademia, della polis e dei conflitti, l’Heidegger dell’immediato dopoguerra “prova” la sua resistenza e l’affida a questi quaderni da scolaro offeso ma orgoglioso del suo sguardo altro ed alto: “Forse il pensiero che io tento resterà ancora per lungo tempo come una meridiana nell’ombra” (Ivi, p 189), “Allora il pensiero sarebbe il mestiere del tacere?” (Ivi, p.105).
Testo indefinibile (appunti di un diario filosofico? periodico fare i conti con il pensiero? allegra ma onanistica vendetta dell’uomo sconfitto? spunti per libri futuri? osservazioni pubblicamente indicibili? trucioli di una grande opera da costruire ma incostruibile? panoplia di personali smarrimenti? dialogo senza fine con le grandi ombre? interminabile colloquio con se stesso?) i Quaderni Neri stanno infine a nostra disposizione. Per cosa, dipende da noi. Per farne pretesto infinito ad infinite contrapposizioni? Per usarli a favore o contro un’idea di filosofia, un’idea di mondo, un’idea di società? L’aria di sfida che dai Quaderni sale ci permette tutto e il contrario di tutto. “E soprattutto non prendetemi per un altro!” pare provocatoriamente invitarci l’Heidegger finalmente pubblicato e tradotto, facendo eco all’ultimo Nietzsche.
Su una cosa però ci si potrebbe accordare: in tempi di omologazione universale in cui davvero pare che tutti i luoghi del pianeta convergano verso un identico “destino” facilmente riconoscibile come dominio universale di tecnoscienza, in cui ogni regime (economico, politico, sociale) è sempre più (inconsapevolmente) piegato ad un pensiero unico e sottratto all’umana possibilità di controllo, in clima di manifesta mediocrazia e allorché l’“autoannientamento” della Terra rischia di non essere più solo una pittoresca metafora, difficile non leggere nell’opera tutta di Heidegger e in questi Quaderni in particolare – tra mille altre suggestioni – anche l’annuncio di una lungimirante distopia. Un pensatore che affida all’“attualità” del silenzio e alla loro avventurosa navigazione postuma i suoi scritti, merita, già per questo, una lettura attenta, intensa, spregiudicata, appassionata. Ai pochi coraggiosi che la intraprenderanno, auguri, dunque, di un buono anche se periglioso viaggio.







