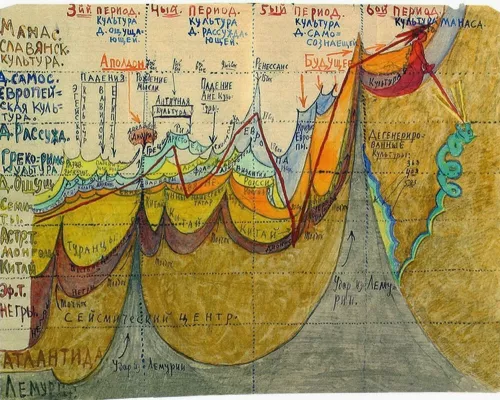Viaggio a San Pietroburgo
Erano gli anni Settanta sovietici quando lo studioso russo Vladimir Toporov iniziò lo studio che lo avrebbe portato a determinare il concetto di “testo pietroburghese” della cultura russa. Tentativo di morfologizzare le caratteristiche di stili e topoi specifiche per quella città nelle composizioni letterarie. A cominciare dai simboli e dai miti che ne caratterizzarono, nel bene e nel male, l’esistenza fin dalla sua fondazione nel 1703 per procedere con folclore urbano, arte, indizi apocalittici, demonizzazione, mistero, politica e storia. Puškin, Gogol’, Dostoevskij prima di ogni altro, fornirono segnali e spunti irrinunciabili per tracciare il quadro, a cui seguirono poeti, prosatori, pittori, grafici con contributi continui sulla “città che ha cambiato nome”, per dirla con Iosif Brodksij. Generazioni di studiosi si stanno ancora cimentando con interpretazioni e letture del mito della capitale del nord, tra condanna e celebrazione, esecrazioni poetiche del suo abominevole clima e apologie intellettuali delle sue atmosfere ambigue mentre artisti, registi cinematografici, scrittori continuano, anche nella Russia post-sovietica, a riprendere e integrare quello che oggi sarebbe più corretto definire l’iper-testo di Pietroburgo.

Di questo fa prepotentemente parte un romanzo composito e impegnativo, prodotto d’eccellenza di quello che i russi hanno sempre chiamato il secolo d’argento, l’età del simbolismo. Erano gli anni in cui i Ballets russes di Djagilev e le creazioni del Mir Iskusstva (Mondo dell’arte) incantavano e scandalizzavano l’Europa, gli anni immediatamente successivi a quelli in cui la Sconosciuta di Aleksandr Blok si aggirava per le fumose periferie simboliste di Pietrogrado:
Lentamente, passando fra gli ubriachi,
sempre senza compagni, sempre sola,
in una scia di nebbie e di profumi
si va a sedere accanto alla finestra.
Gli anni che seguirono la sanguinosa rivoluzione del 1905 e che videro la pubblicazione delle prime raccolte poetiche di Majakovskij. In quei tempi, tra il 1912 e il 1913, Boris Bugaev pubblicò con lo pseudonimo di Andrej Belyj la prima versione del romanzo Peterburg (Pietroburgo). Era il 1961, un anno dopo la pubblicazione del Mito di Pietroburgo di Ettore Lo Gatto, quando in Italia ne uscì per Einaudi la strepitosa traduzione di Angelo Maria Ripellino che oggi viene riproposta, sempre corredata dalla travolgente introduzione che l’aveva accompagnata in origine, per i tipi di Adelphi (384 pp., 22 euro).
È una storia rocambolesca e fantasmagorica, per restare nell’universo lessicale di Belyj tanto congeniale al suo traduttore italiano, che mette in scena un tentativo di parricidio legato alla rivoluzione del 1905. Un intricato intreccio che combina un gruppo di terroristi e l’illustre famiglia degli Ableuchov, Nikolaj Apollonovič che dovrebbe, in nome di una vaga promessa fatta a un gruppo di rivoluzionari, attentare alla vita del padre, il senatore Apollon Apollonovič, e che si dipana sullo sfondo, in realtà ruolo da vera protagonista, della città. La minaccia della rivolta, tutta la narrazione è dominata dalla sensazione apocalittica della fine di un’epoca, si incarna nel minaccioso segno fonico di un persistente “uuuuuuuu” che arriva dalle isole, territorio proletario e operaio e si espande nell’inquietante quarta dimensione, risultato degli interessi dell’autore per le geometrie non euclidee, di cui sono costituiti gli spazi vitali dell’uomo di stato. I rettilinei corridoi della sua abitazione, che trovano riscontro se non addirittura origine nelle circonvoluzioni del suo cervello, sono invece tra gli esiti delle passioni antroposofiche di Belyj.
L’ossessione per i cubi e i quadrati, portatori di lucidità e distensione, che dominano nella residenza del senatore si oppone al caos sfrenato delle isole, al di là del fiume, dove il rivoluzionario Dudkin risiede in un tugurio in cima a una scala che rimanda alla stanza-armadio del Raskol’nikov dostoevskiano. La città del senatore è pure rettilinea e bidimensionale, trionfo di silhouette di fuliggine e sagome che testimoniano della mancanza della terza dimensione in quell’universo. “Pietroburgo non esiste”, scrive Belyj, “dietro Pietroburgo non c’è nulla”. E la metropoli, in conformità con la lettura che ne darà il semiologo Jurij Lotman, è quella in cui acqua e terra si sono scambiate i ruoli: l’elemento liquido è dominante e invasivo mentre il suolo, invece di connotarsi come solido e affidabile, è scivoloso e insicuro. Le acque di fiumi e canali sono verdognole e traboccanti di bacilli, i lungofiume fradici e sdrucciolosi. Le nebbie sono giallognole, di un colore che ha del chimico. “Evanescente tessuto di brume e di miasmi”, nel commento di Ripellino. Sui ponti e negli androni, territori di transito caratteristici del testo pietroburghese, balena la figura allarmante del domino di raso rosso, di cui si veste Nikolaj durante le sue peregrinazioni in incognito per la città. Folle immani si trascinano sotto la pioggia battente e gli essere umani si scompongono gogolianamente in singole parti isolate e staccate dal corpo che scompaiono nel mondo delle ombre. La minaccia pan mongolica, residuo della guerra russo-giapponese, occhieggia costantemente in forma di “berretti di Manciuria” dilaganti per la città. Si rinnova nell’intérieur domestico di Sof’ja Petrovna Lichutina, la donna che ha rifiutato l’amore di Nikolaj spingendolo nelle spire del terrorismo, uscito da una serie di stampe di Hokusai rivisitate dalla moda delle giapponeserie.
Su queste immagini si innestano i giochi fonici delle molteplici cacofonie e allitterazioni: Apollon Apollonovič Ableuchov (con il rimando nel nome e patronimico al nietzscheanesimo che imperversava nella Russia simbolista) opposto all’elemento dionisiaco di cui è portatore il figlio e, foneticamente, al suo diretto avversario, il terrorista Lippančenko. Le divagazioni tra quest’ultimo e il nichilista Dudkin sui suoni “i” e “y”, la maschera fonica di Pepp Peppovič Pepp si sovrappongono ad altri giochi sonori ispirati dalla zaum’, la lingua transmentale dei cubo-futuristi che dilaga in puro delirio fonetico non senza rimandi semantici al sogno oppressivo e all’incombente fine. Non manca un’incursione del Cavaliere di Bronzo, il monumento a Pietro il Grande già macchina meccanica che si era animata in precedenti pagine di letteratura pietroburghese e responsabile del “testo” della città, con il suo carico di responsabilità per aver tentato di “europeizzare” la Russia a inizio Settecento e preteso, contro natura e razionalità, che si edificasse una città capitale fondata sulle paludi.

La bomba con cui il figlio avrebbe dovuto assassinare il padre verrà recapitata, significativamente, in una scatola di sardine e scoppierà accidentalmente nella stanza di Nikolaj creando confusione ma senza mietere vittime. In seguito a questa fatalità la famiglia si smembrerà. Il figlio partirà per l’Egitto e farà ritorno in patria dopo una sorta di conversione spirituale, solo dopo la scomparsa dei genitori, per studiare Kant e Skovoroda (nativo di Kiev), uno dei pochi filosofi autenticamente russi, viandante e religioso nel Paese del XVIII secolo.
Pietroburgo di Belyj è un libro visionario, non facile, godibile, grazie alla stupefacente versione di Ripellino, anche per la sua struttura ritmica (punteggiatura e tipografia) che rimanda a Joyce e al suo Ulisse, per le immagini fantasmagoriche, per l’originalità della lettura storica, per le ardite soluzioni narrative. Da leggere con calma e lentezza, da gustare in ogni sua componente. Non ultima la possibilità di collegamento al dibattito contemporaneo che torna a far discutere sul secolare e conflittuale rapporto tra Europa e Russia, Asia e occidente, forze filo e anti-governative, reazione e rivoluzione. E poi Pietroburgo è tornata a chiamarsi così, dopo decenni di Leningrado. “Pietroburgo, o San Pietroburgo o Piter. È lo stesso”, scriveva Belyj nel 1913. Un’ottima occasione per documentarsi.