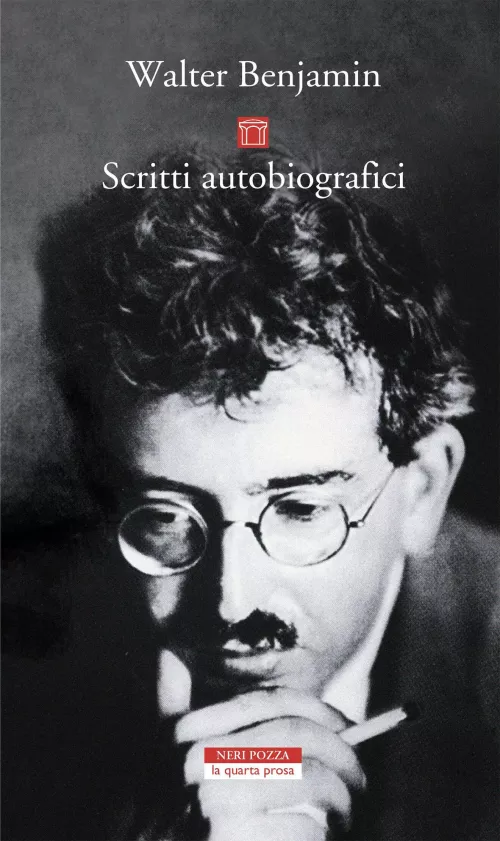Scritti autobiografici / Walter Benjamin e la scrittura generosa
Di fronte a un’autobiografia il tracciato delle nostre attese di lettori segue una direzione piuttosto convenzionale. Ci aspettiamo una struttura dai tratti – almeno in parte – codificati: innanzitutto la distanza critica e cronologica dell’autore dall’oggetto del racconto, il proprio io, che viene inserito in una cornice, all’interno della quale i fatti sono disposti in maniera scrupolosamente lineare. Ci aspettiamo, poi, quel momento cruciale e rivelatore che consente all’autore di rileggere sotto una luce del tutto peculiare le proprie vicende di vita: il momento – o i pochi momenti –– di una rivoluzione interiore, di un capovolgimento: la crisi e la svolta. Tutto questo fa parte dell’interesse giustificato di un lettore di autobiografie.
Nondimeno, il volume pubblicato quest’anno da Neri Pozza, gli Scritti autobiografici di Walter Benjamin, invita il lettore a rimodulare il proprio orizzonte di attesa già a partire dal titolo. L’allusione esplicita alla pluralità degli scritti denota una scrittura all’insegna della frammentarietà, che non si compie in un progetto. Si tratta, infatti, di una silloge di testi dal sapore autobiografico, ossia di diari, appunti di viaggio e frammenti, che i curatori tedeschi dell’Opera completa hanno raccolto in un unico volume.
Benjamin è sempre stato un autore generoso, non solo in ragione del numero di scritti straordinari che ci ha consegnato, ma soprattutto in virtù della naturalezza con la quale è stato in grado di confinare il proprio ego oltre la frontiera della scrittura. Dietro lo scrivere si cela quasi sempre anche uno scriversi, ma, per Benjamin, l’aspetto pronominale sembra ripiegarsi perlopiù sulla superficie della scrittura stessa, sulla necessità vibrante di un atto capace di esorcizzare il peso ingombrante dell’io. Infatti, nella Cronaca berlinese, materiale preparatorio per la più nota Infanzia, Benjamin ammette che, se lui scrive “in un tedesco migliore della maggior parte degli scrittori della sua generazione, è dovuto in gran parte alla ventennale osservanza di un’unica piccola regola. Essa dice: non usare mai la parola ‘io’ tranne che nelle lettere” (p. 319). Allora cosa succede quando la scrittura si rivolge finalmente al soggetto? Benjamin è incerto e prende delle precauzioni per non liquidare con leggerezza ciò che è riuscito a conservare gelosamente: se stesso.
La precauzione che viene esplicitata nella Cronaca può valere come chiave di lettura per tutti i testi di questo volume: “I ricordi, anche i più estesi, non sempre costituiscono un’autobiografia. E questa di certo non lo è, nemmeno per quanto riguarda gli anni berlinesi, di cui qui solo mi occupo. Infatti, un’autobiografia ha a che fare con il tempo, con una sequenza, e con ciò che costituisce il flusso continuo della vita. Qui invece in questione c’è uno spazio, ci sono momenti e discontinuità” (p. 332). In questione, quindi, c’è lo spazio, ci sono gli spazi e i luoghi vissuti: Berlino, Capri, Parigi, Mosca, Ibiza sono tutti nodi dell’individualissima costellazione ‘Benjamin’, dispersa più nello spazio che nel tempo. Il profilo biografico e intellettuale dell’autore spicca nel collegamento di queste coordinate spaziali, che, tuttavia, non mettono con facilità i ricordi a disposizione di chi li cerca. Il passato è rinserrato in questi luoghi e chi scrive e tenta di recuperarli deve comportarsi come un archeologo, come uno scavatore capace di sicuri colpi di vanga.
Di tutti gli scritti raccolti, però, solo la Cronaca e l’Infanzia possono rivendicare a pieno titolo un intento archeologico, dal momento che cercano di riattivare la carica elettrica che stringe il luogo al tempo passato. Invece, i diari di viaggio (il viaggio in Italia, il diario moscovita, il diario spagnolo), che sono quasi sempre redatti da Benjamin nel corso del viaggio stesso, ricalcano i passi dell’autore là dove le tracce sono ancora fresche, in un’attività di raccolta che è pericolosamente vicina al presente, che rincorre l’attimo dell’impressione già quasi inghiottita. In questi tratti, la scrittura sembra solcare i percorsi abbozzati dall’osservazione curiosa di Benjamin, che attraversa in maniera discontinua una galleria di dettagli e di frammenti. Il senso della ricerca immanente di “deboli forze messianiche”, momento centrale di alcune delle più ricche riflessioni teoriche dell’autore, sembra essere stato anche il frutto di un’esperienza biografica decennale.

I torsi simbolici abbandonati negli angoli delle città, ai margini di un paesaggio o nei racconti che nessuno è più capace di ascoltare, costeggiano le riflessioni di viaggio dalla giovinezza alla maturità. In qualche modo, si potrebbero considerare tutti questi momenti alla stregua di minute e quasi impercettibili conversioni che accompagnano l’autore in una vita che non è segnata da grandi rivoluzioni interiori, ma, piuttosto, dalle momentanee interruzioni della continuità individuale. E, d’altra parte, Benjamin raccoglie ciò che semina, poiché negli appunti e nelle considerazioni di questi scritti si intravedono già i motivi principali delle riflessioni successive: il collezionismo, i giocattoli, la moda, i pensieri sulla storia e sulla memoria. Tutto ciò non fa che rafforzare l’impressione di un pensiero cresciuto in affinità con l’esperienza vissuta, di un pensiero rappreso e non sospeso.
L’attenzione nei confronti dei dettagli marginali, che talvolta diventa quasi una ricorrenza ossessiva, si concilia con alcuni pensieri sulla storia che vengono registrati già a partire dal 1931. In occasione di una conversazione con un paio di amici, per esempio, Benjamin riporta alcuni pensieri su di una metodologia storica alternativa, che prevede la sostituzione del concetto evoluzionistico di ‘sviluppo’, metaforicamente identificato con il flusso continuo di un fiume, con l’immagine del vortice. Il vortice, infatti, porta con sé il segno dell’origine e anche quello dell’annullamento (“della pre- e della post-storia”, p. 281), è la figura dinamica e leggera che accompagna l’acqua nella sua corsa disordinata. Questa traccia mnestica, che nella storia collettiva diventa il sigillo di “certi immutabili status di tipo concettuale e percettivo” (ibid.), nella storia individuale di Benjamin sprigiona una forza simbolica non meno evidente. La passione per i cortili e per le logge, per esempio, può essere facilmente sovrapposta alla forma del vortice, dove la cavità che rosicchia il tessuto metropolitano si configura sia come nicchia familiare, rifugio originario, sia come vuoto vero e proprio, sospensione di ogni attività. Lo stesso principio vale per il sogno, spazio virtuale indeterminato, che interrompe la continuità del vissuto cosciente e che porta in superficie qualcosa di sommerso. Almeno in questi scritti, Benjamin non si dedica a un’interpretazione dei sogni che racconta, ma sembra godere di queste temporanee sospensioni della regola.
I pochi sogni menzionati nei diari assumono il valore eccezionale di tappe di un cammino iniziatico, che, tuttavia, comincia e finisce all’interno del sogno stesso. È piuttosto singolare che l’elemento ricorrente di questa dimensione onirica sia costituito, oltre che dalle figure delle donne amate, dalle lettere dell’alfabeto, dalla lettura e dalla scrittura. Nel 1939, nel raccontare uno di questi particolarissimi sogni a Gretel Adorno, Benjamin commenta scrivendo che si tratta di uno “di quei sogni che faccio ogni cinque anni e che si intessono intorno al tema ‘leggere’” (p. 503). In questo caso, il protagonista del sogno si trova in un labirinto di caratteri tipografici, che si piegano, ripetendo i movimenti del dorso delle montagne circostanti. Un’interpretazione forse azzardata, ma che collima con alcune conclusioni che si possono trarre da questi scritti, è che la scrittura e la lettura rappresentino per Benjamin il medium attraverso il quale questi riesce a penetrare nella selva labirintica della realtà che lo circonda. In effetti, le descrizioni minuziose dei paesaggi naturali e urbani, delle emozioni, così come le considerazioni critiche in campo estetico e sociologico, non appaiono mai come trascrizioni mimetiche, bensì come gli unici strumenti che siano in grado di cogliere gli aspetti più effimeri della realtà. La scrittura, come scrive Benjamin a proposito di Hemingway, non segue il pensiero, ma lo plasma. Scrivere ciò che si pensa significa innanzitutto pensare.
La raccolta di questi testi, quindi, più che un percorso di vita lineare, sembra ripercorrere l’itinerario di un pensiero inquieto e in costante attività, che prende forma nella scrittura. Anche la riabilitazione dell’io, in fondo, più che motivo di un’opera di introspezione, è un pretesto per poter adottare un punto di vista soggettivo sulle cose. Accade, però, che il punto di vista si ribalti e che la realtà osservata si rovesci con irruenza sull’osservatore. È in questo margine di possibilità che, ancora una volta, risiede la generosità di Walter Benjamin: nel lasciar defluire i messaggi che il mondo rilascia, senza cercare di imprigionarli in una gabbia prospettica. Un’impostazione che ancora oggi ci dà da riflettere, se confrontata con quel narcisismo privativo, che preclude l’esperienza di un contatto autentico con la realtà. Lo slancio verso il mondo, peraltro, non elide l’individualità, ma l’accentua, estende la sua potenzialità, riconducendo al soggetto della scrittura un mondo che “nasce e muore con lui” (p. 246).