Conversando con i bambini
Il rapporto fra adulti e bambini è segnato da una condizione implicita: quella fisica, legata al corpo, alle dimensioni. Adulti e bambini sono, infatti, i ‘grandi’ e i ‘piccoli’. Non si tratta di misure assolute, ma relative, che si danno, specificamente, in questa relazione. Per l’adulto il bambino è sottodimensionato; per il bambino l’adulto è sovradimensionato. Il bambino percepisce sé come piccolo in relazione al percepire l’adulto come gigante. L’adulto percepisce sé come gigante in relazione al percepire il bambino come minuscolo (in diversi dialetti e nel parlato spesso il bambino è ‘nano’). È una situazione tipicamente fiabesca. Nelle fiabe sono molti i protagonisti infantili che hanno dimensioni minuscole, più piccoli dei già piccoli bambini. Così come molti giganti (e orchi) abitano il fiabesco, e si potrebbero definire degli adulti abnormi. Forse si tratta di un espediente fantastico, un modo che fiabe e racconti hanno per sottolineare una sproporzione, un disequilibrio che è alla base della relazione bambino/adulto, inquietante perché mette in luce la responsabilità del primo e la dipendenza del secondo.
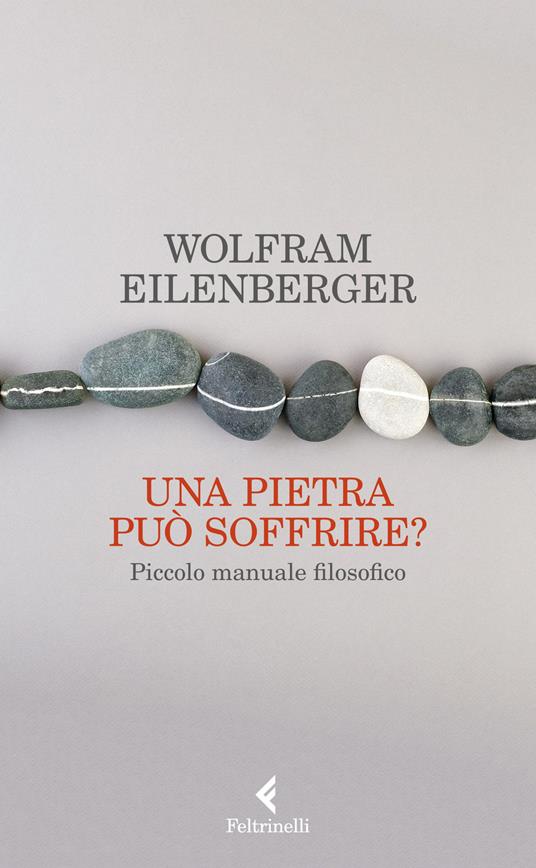

Ho pensato a questo mentre leggevo Una pietra può soffrire? (Feltrinelli 2022), libro che l’editore in copertina definisce “Piccolo manuale filosofico” ovvero i dialoghi del filosofo tedesco Wolfram Eilenberger con una bambina di cinque anni, sua figlia, che riflette sugli innumerevoli casi della propria vita. Man mano che leggevo il libro con divertimento (questa bambina, indomita e traboccante di intelligenza ed energia, è irresistibile) mi sono resa conto di visualizzare un padre enorme e una bambina minuscola. Nel leggere, mi sono resa conto anche di un'altra cosa, e cioè che da nessuna parte l’autore del libro spiega come siano avvenuti questi dialoghi: se li abbia registrati e poi sbobinati; o invece fissati in presa diretta, prendendo appunti; oppure ricostruiti a memoria…
Ci ho pensato perché saperlo non mi pare secondario, se lo scopo è farci conoscere il pensiero infantile. Ma è poi davvero questo lo scopo del libro? A stare al risvolto di copertina, sì: dato che per recuperare la filosofia come “meraviglia e scoperta del mondo” si è invitati a “guardare il mondo con gli occhi di un bambino”. In questo senso, se il padre in queste pagine fa da mediatore fra la bambina e il lettore, spiegare le circostanze di questa mediazione, le sue modalità, mi pare importante. Fra l’altro, Eilenberger, scrivendo, non si rivolge al lettore, come potrebbe parere naturale, bensì alla bambina stessa. Non riporta solo i dialoghi con lei, ma le rivolge riflessioni su temi piccoli e grandi evocati dalle sue stesse parole, parole che, attraverso la propria scienza, il padre lega a quelle di grandi filosofi del passato – Socrate, Nietzsche, Locke, Kant…. Dunque la bambina è presente nel libro oltre che come ‘personaggio’, anche in veste di lettore implicito per usare un termine della narratologia. Tuttavia, il lettore reale di Una pietra può soffrire? siamo noi, non lei.
Tutto ciò per dire: questa cinquenne avrà saputo che i suoi dialoghi con il papà sono entrati in un libro che probabilmente potrà leggere solo quando sarà grande? Conoscerà le riflessioni che il papà le ha rivolto in prima persona? Quello dei mediatori (e della loro cancellazione) è un tema cardine di questo momento storico e ci si chiede, dunque, anche in questo specifico ambito, come, quando e se avvenga una mediazione e quali conseguenze possa avere l’atteggiamento che si assume nei suoi confronti. Alison Gopnik, scienziata e filosofa, nel saggio Essere genitori non è un mestiere. Cosa dice la scienza sulle relazioni tra genitori e figli (Bollati Boringhieri 2017) scrive che uno dei più sensazionali sviluppi scientifici recenti viene dall’epigenetica e riguarda un ambito definito “espressione genica”. In sostanza, durante l’infanzia i geni possono essere attivati o disattivati dalle cure parentali che si ricevono e dal contesto in cui si cresce. Esperienze e geni interagiscono fra loro, ma non solo: alcuni fattori genetici rendono i bambini più o meno sensibili al proprio ambiente. Dunque, per quanto ci si possa dare o meno pensiero riguardo al proprio ruolo di mediatori, il suo effettivo operare è indiscutibile.

“Una pietra può soffrire?” mi ha fatto ripensare a due libri dei quali il primo è Venti giorni con Julian di Nathaniel Hawthorne (Adelphi 2004). Come spiega Paul Auster nella bella prefazione al libro, si tratta di un testo tratto dai diari dello scrittore americano il quale dedicò ai suoi figli piccoli numerose riflessioni e osservazioni (come, oltre oceano, fece Charles Darwin). Nel 1851, Sophia, la moglie di Hawthorne, insieme a Rosebud e a Una, le figlie piccole, si dovettero allontanare da casa per una visita ai genitori di lei e il padre rimase a casa con il figlio minore, Julian, di cinque anni, di cui dovette occuparsi quotidianamente. Come scrive Auster: “Senza altra intenzione che quella di registrare le vicende domestiche in assenza della moglie, si era inavvertitamente imbarcato in una impresa mai tentata prima da uno scrittore: il resoconto puntuale e meticoloso di un uomo che da solo si prende cura di un bambino piccolo.» A sentire l’opinione di Julian, ormai adulto, si trattò di venti giorni di pura beatitudine. Fu lui, fra l’altro, a dare il permesso di pubblicare i brani del diario che lo riguardavano, che finirono nella settima sezione dell’edizione dei Taccuini americani del padre. Hawthorne era molto riservato e non avrebbe mai pubblicato quelle pagine in vita, pagine che non erano state scritte con questa idea.

La bambina di neve, Topipittori, 2007, illustrazione di Kiyoko Sakata
La bambina di neve, Topipittori, 2007, illustrazione di Kiyoko SakataQuegli appunti sui suoi bambini rispondevano a una profonda esigenza privata, come ben sapeva la moglie. (Una e Julian furono il modello per Violet e Peony, i protagonisti di quel racconto meraviglioso che è The Snow-Image. A Childish Miracle ovvero La bambina di neve. Miracolo infantile” (Topipittori 2007) in cui un bravo padre di famiglia causa la scomparsa dell’immaginaria amica di giochi dei figli). Quando, infatti, dopo la morte dello scrittore, l’editore di “Atlantic Monthly” chiese alla vedova il permesso di pubblicare quella parte di diario che poi sarebbe stata intitolata Venti giorni con Julian, lei, dopo alcuni tentennamenti, lo negò, spiegando che Nathaniel «non avrebbe mai voluto rendere pubblica una storia così intima e familiare, e mi stupisco di me stessa anche solo per averci pensato.»

Una e Julian Hawthorne c. 1850
Nei Taccuini le pagine dedicate ai figli sono circa una trentina in cui, insieme a lunghe descrizioni dei comportamenti dei figli piccoli, sono accuratamente riportati i loro dialoghi spesso del tutto surreali come è tipico della dimensione infantile, dimensione verso la quale i genitori nutrivano grande curiosità e attenzione. I figli, peraltro, ritenevano che il tempo trascorso dal padre a scrivere fosse sprecato rispetto a quello dedicato al gioco con loro (che era cospicuo, perché, come riporta Sophia, Hawthorne per i figli era un compagno magnifico). Venti giorni con Julian è una cronaca onesta e puntuale di giornate passate insieme da un padre e da un figlio di cinque anni, un resoconto che dà conto di fatiche, seccature, soddisfazioni, sorprese, riflessioni, divertimenti, arrabbiature, moti di noia e di gioia, con tutta la parata delle minuzie quotidiane a cui la presenza di un bambino costringe a fare attenzione. Ed è precisamente questo aspetto, così vivace e prosaico, spontaneo e riflessivo, ma senza alcuna enfasi, a essere irresistibile in queste pagine.

La qualità surreale delle riflessioni infantili, la loro originalità, la logica specifica che i bambini applicano alle cose della vita – messe tutte sullo stesso piano: da faccende da niente a imponenti questioni filosofiche –, sono anche al centro del secondo libro che mi è tornato alla mente: Conversando con i miei bambini (Einaudi 2000) che raccoglie i dialoghi dello psichiatra Ronald G. Laing con Natasha e Adam, due dei suoi dieci figli, allora al termine della prima infanzia, pubblicati nel 1978.
Laing firma una introduzione al volume veramente bellissima che così comincia: «Ho riportato queste conversazioni, che coprono un periodo di sei anni, nel mio diario. Le ho trascritte tutte a memoria. Non ho mai usato un registratore. Le ho annotate quasi tutte nella stessa giornata in cui si sono svolte. Nessuna è stata strutturata o aggiustata. Tutte, senza eccezione, fanno parte del flusso naturale di avvenimenti che accadono nella vita familiare. I bambini sono abituati a vedermi prendere appunti; mi capita spesso di scrivere mentre sono in giro e davanti alla gente, inclusi i bambini. Non credo che il fatto di aver trascritto i loro discorsi abbia influito in modo significativo sul loro carattere.»
Più avanti Laing spiega al lettore anche altre cose importanti: che ha preferito non far precedere le conversazioni da un proprio saggio teorico e non spiegarle in nota, così che fossero lette in base “al minor numero possibile di presupposti teorici”. Laing specifica anche che nessuna di queste conversazioni è stata da lui inventata (come qualcuno, sopraffatto dallo stupore per questi dialoghi, gli aveva chiesto). Puntualizza di non avere aggiunto nulla, ma di avere omesso qualcosa e, questo, per rispetto verso aspetti unicamente concernenti la vita familiare: “Ci sono intimità nella vita di una famiglia che un uomo all’antica come me trova sconveniente pubblicizzare». E, anzi, a questo proposito, racconta di aver esitato alcuni anni a rendere pubbliche, cioè a pubblicare, queste scene di vita di famiglia e di essersi risolto a farlo solo dopo aver chiesto il parere dei figli e della moglie Jutta (che a volte interviene nei dialoghi).
Questa premessa mi ha colpito. Non solo per la delicatezza nei confronti sia della propria famiglia sia dei lettori, ma perché, oggi, siamo abituati a pensare che la nostra vita privata faccia parte dell’inesauribile flusso mediatico quotidiano che porta con sé le immagini di milioni di bambini e bambine e delle loro famiglie, in tutto il mondo. Forse per questo, oggi, molti adulti ritengono che non vi sia necessità di contestualizzare il proprio ruolo di mediatori. Probabilmente tale ruolo non è avvertito nemmeno come tale. La consuetudine a ‘pubblicare’ lo ha reso invisibile al punto da cancellarne l’evidenza.
Nel 2001, quando Berlusconi in campagna elettorale pubblicò le proprie foto di famiglia (i figli piccoli, la moglie eccetera) nella rivista creata ad hoc intitolata Una storia italiana promossa dallo slogan “La mia biografia in tutte le famiglie italiane”, la cosa pareva ancora una discutibile operazione e suscitò un certo dibattito (si invadeva la vita privata delle famiglie italiane con il racconto della propria a scopo promozionale). Oggi milioni di persone fanno la stessa cosa, quotidianamente, senza che questo susciti dubbi nei più, forse anche intimoriti all’idea di passare da attempati reazionari retrogradi legati a un’idea di riserbo piccolo borghese. Ma qui l’età anagrafica c’entra poco perché il problema della sproporzione fra grande e piccolo che dicevo all’inizio, permane, oggi come ieri: è fisiologica, in qualsiasi modo i diversi contesti culturali ne elaborino i termini. Se il bambino è sempre esposto di fronte all’adulto, chi decide i termini della relazione è sempre quest’ultimo. Lo sapeva bene Laing, attento studioso della comunicazione, nello specifico di quella deformata o assente tipica dei contesti patologici (soprattutto famiglie e ospedali psichiatrici), contrassegnata da uno squilibrio di potere, in cui il dialogo si fa mortifero, confuso, soffocante, manipolatore.
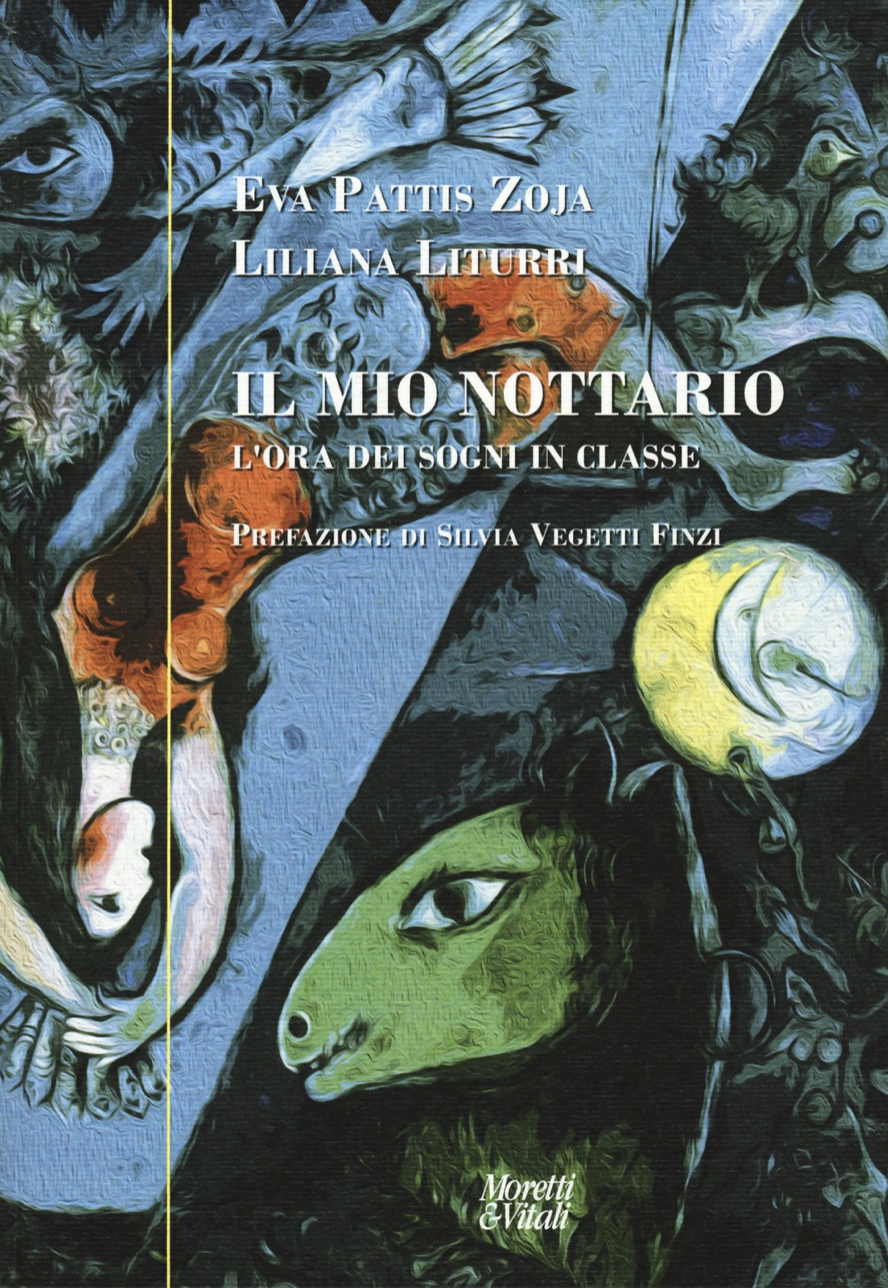
Nel bel libro di Eva Pattis Zoja Il mio Nottario. L’ora dei sogni in classe (Moretti & Vitali 2015) in cui si racconta una interessante sperimentazione relativa ai sogni dei bambini condotta in una scuola primaria della provincia di Bari, viene riportata una frase della pediatra e psicoanalista infantile Françoise Dolto: “Si parla molto dei bambini, ma poco con i bambini”.
La frase si riferisce alla constatazione di come le esigenze degli adulti – insegnanti, genitori, scuola, famiglia – tendano costantemente a sopravanzare quelle dei piccoli, togliendo loro spazi e tempi dedicati all’apprendimento di un linguaggio adeguato alle esperienze. Scrive Eva Pattis: «il nostro lessico persegue l’efficienza, non la profondità, la spiegazione razionale, la comprensione emotiva.» E più avanti racconta come uno degli scopi della sperimentazione sia stato restituire la parola ai bambini, ascoltandoli con lealtà in uno spazio protetto di cui si possano fidare, senza sovrainterpretare le loro parole e i loro disegni, nella speranza di riconsegnarli a se stessi e, insieme, di restituire anima all’educazione.


Sopra, The Bear, Raymond Briggs 1994.
Sotto, L'ospite sgradito, Edward Gorey, 1957
Qualche tempo fa una persona mi raccontava di aver avuto, durante la propria infanzia, un’amica immaginaria. Con questa amica invisibile trascorreva del tempo. Si tratta di un’esperienza diffusissima fra i bambini, un tempo rubricata come patologia, da diversi anni interpretata, invece, come ingegnosa costruzione psicologica che la mente infantile mette in atto per superare autonomamente, con risorse proprie, momenti di difficoltà e situazioni complesse. Questa persona mi disse che un giorno le arrivò una lettera firmata dalla propria amica immaginaria, scritta da un familiare impegnato nel maldestro tentativo di entrare in questa privatissima relazione. In un baleno, l’amica immaginaria (come la bambina di neve di Hawthorne), si volatilizzò.
Ci ho ripensato, leggendo “Anche tu hai un amico così?”, primo dialogo di Una pietra può soffrire?, in cui il padre dialoga con la figlia a proposito di Maja, la sua amica immaginaria, apparentandola, in modo devo dire affascinante, con la voce interiore che abita in ogni essere umano, quella che Socrate chiama daimon e Nietszche genio.
È interessante riflettere sul fatto che alla base di questa messa a fuoco del pensiero filosofico adulto possa esserci un’esperienza infantile (probabilmente non solo quella degli amici immaginari). Tuttavia per un bambino non cambia nulla saperlo, ovvero l’intensità della propria esperienza non acquista valore per il fatto di essere imparentata con due colossi del pensiero occidentale. La ricchezza psicologica ed emotiva acquisita grazie a questa esperienza è importante, forte, efficace, solo grazie alla pratica che se ne fa ed è precisamente essa a risultare straordinaria e a conferire valore all’esperienza. Non è, in poche parole, la cultura infantile a giovarsi di questa riflessione, ma quella adulta che rassicura se stessa riconoscendo un proprio valore, la filosofia, all’infanzia.


Sopra, Zero Calcare e la sua coscienza Sotto,
Harvey, regia di Henry Costner, 1950
È molto importante parlare con i bambini, anziché di bambini, come segnala Dolto. Oggi, questa pratica che ai tempi di Hawthorne e persino di Laing, quando praticata da padri, costituiva una rarità e un’eccezione, entra nell’esperienza con maggior frequenza, ed è, indiscutibilmente, un bene con tutti gli errori che può comportare e che inevitabilmente si possono commettere.
Nella sua introduzione Laing sottolinea che se studiare il dialogo patologico, definito una “divisione dell’inferno”, è importante per la cura delle malattie psichiatriche, lo è altrettanto per il benessere del mondo adulto portare alla luce «il dialogo felice tra esseri intelligenti che si è evoluto fino a uno stupefacente grado di complessità. […] area libera e aperta tra di noi dove insieme [con i bambini] possiamo giocare con la realtà, dove formuliamo domande e risposte, indaghiamo se le cose stanno così o in quell’altro modo, per il semplice piacere di farlo.» E, aggiunge: «Gli schemi di reciprocità che emergono da questa attività sono per me, nel loro aspetto diacronico e sincronico, rappresentati nel modo più succinto dal contrappunto in musica e dall’intreccio di forme in termini visivi.» Che si parli di reciprocità in termini estetici a proposito di dialoghi con i bambini non è scontato e dal mio punto di vista costituisce, a tutt’oggi, un’acquisizione rivoluzionaria.
Sempre a proposito di reciprocità, poco più avanti Laing spiega «…che è tanto utile per gli adulti essere in contatto con i bambini quanto per i bambini essere in contatto con gli adulti. Le cose sui bambini le impariamo soltanto dai bambini. La nostra comprensione di noi stessi è enormemente impoverita se non siamo in contatto con l’infanzia. Gli adulti possono soffrire della deprivazione dei bambini nella loro vita, come viceversa. Sospetto che i bambini abbiano una parte altrettanto grande nella crescita e nello sviluppo degli adulti come noi l’abbiamo nella loro. Io non passo tanto tempo con i bambini perché devo farlo o perché penso che sia utile, ma semplicemente perché voglio farlo.»
Forse è ciò che a tutti noi dovrebbe più interessare.







