21 dicembre 1934 / Conversazione con Giulia Niccolai
“Trasformare questa mia difficile vita in fiaba” è il titolo dato alla mia tesi, tratto da un passo di Esoterico biliardo in cui si chiede, a proposito delle visioni avute in meditazione: «forse il dono di leggere e trasformare questa mia difficile vita in fiaba?».
Sì, ne parlo anche in Foto & Frisbee, a p. 78, cito Kazantzakis – il suo libro più noto è Zorba il greco – ma in El Greco e lo sguardo cretese, scrive: «Esiste qualcosa di più vero della verità? Sì, la favola; è la favola che dà un senso immortale all’effimera verità». Le trame delle favole raccontano sempre una serie di passaggi e di avvenimenti per i quali raggiungere la verità diviene una conquista. Si arriva alla verità dopo una lunga serie di vicissitudini che hanno o sembrano avere lo scopo di allontanarcene. Giorgio Celli, poeta, scrittore, entomologo dell’Università di Bologna, ha scritto: «Ogni vita nel suo inseguirsi e nel suo raggiungersi aspira al compimento di una favola». Questa dinamica ha a che fare col destino. Nel libro cinese degli esagrammi, I Ching, nel quale ogni esagramma è associato a un numero e ogni numero è associato a una situazione, consultandolo (e se ci si crede), il numero che viene da consultare, ha a che fare con qualcosa che ci riguarda in modo particolare, in quel momento. Il numero 50 ha titolo Il crogiolo (pura alchimia), e dice: «Quando si riesce ad assegnare alla propria vita e al destino le loro giuste proporzioni, consolidiamo il destino, e ne risulta allora la compenetrazione della vita col destino». Mi capitò proprio questo che però sottintende (almeno nel mio caso), una grande sofferenza, si tratta di una prova durissima: la discesa agli inferi. Dante stesso l’ha confessato di sé, così come diversi altri scrittori ne hanno parlato, perché scrivono, raccontano, ma sicuramente succede a contadini, persone apparentemente semplici, a impiegati o scienziati ecc. che però lo tengono per sé. Secondo la mia esperienza, la cosa è successa perché non ho tradito me stessa, non ho mai imbastito o architettato cose… falsità ecc. per raggiungere quelle mete che mi ero prefissa, comunque, la discesa agli inferi è un’esperienza tremenda della quale senti di non poter parlare con nessuno perché, sai, sai con assoluta certezza, che nessuno potrebbe aiutarti, non sai cosa ti stia capitando, ma sai che solo qualcuno a cui è già capitato potrebbe capirti, ma a chi è capitata una cosa simile? Ci si sente come in un aereo che abbia perso i controlli e che precipita a vite sempre più velocemente per sfracellarsi a terra. Non riesci in alcun modo a fermare o frenare una simile dinamica, mossa da una sua forza sconosciuta che nel mio caso è durata per ben due anni. In più, all’esterno, nella vita di ogni giorno, qualsiasi cosa facessi, venivo fraintesa, insultata, umiliata…
Pensa davvero, quindi, che la sua vita abbia avuto un intreccio fiabesco? E come riesce tutti i giorni a trasformare la sua vita in una fiaba?
Il concetto dell’intreccio fiabesco mi è venuto come conseguenza della discesa agli inferi! Dopo che quell’inferno, sperimentato da viva (dunque un correlativo della purificazione talmente duro da essere definito “infernale” e non “purgatoriale”) è finalmente terminato, e io ho trovato la strada del Cammino spirituale buddhista, ho lentamente iniziato a pensare e provare emozioni in modo più vasto e aperto verso gli altri. Ne parlo già nel mio libro in prosa del 2001, Esoterico biliardo, nel quale ricordo di essermi sentita una nave – e tale mi visualizzavo – erano in ferro e ruggine certi lastroni che si staccavano dallo scafo e “spanciavano” con fracasso in mare… durante un ritiro di quel mio primo viaggio in India. Fulcanelli, autore che ha scritto molto di esoterismo, cita il concetto della “nave”, la nave è tale perché si trova nell’oceano dove può capitare che non veda per lungo tempo alcun punto di riferimento; si tratta di una nave, proprio per questa ragione: sei alla mercé dell’acqua e del vento, non esiste l’elemento terra, quello sul quale poggi i piedi! Dunque una nave si viene a trovare in un altro spazio/tempo, dove sei costretto a capire l’essenza delle cose in maniera più ampia di quanto non avessi fatto prima. In maniera meno centrata sull’Ego. Lo dico perché sono convinta che se non avessi trovato un cammino spirituale al quale ho potuto aderire con tutta me stessa, non sarei sopravvissuta. Avendo invece trovato la continuazione del mio procedere nel cammino spirituale buddhista, tutto ciò che ho vissuto prima, ha poi avuto le qualità propedeutiche delle vicende delle fiabe. Di conseguenza ciò che succede dopo, e cioè la “compenetrazione della vita col destino” effettivamente avvenuta, non può che essere “fiaba che dà un senso immortale all’effimera verità”. E se Kazantzakis l’ha scritto, non può che averlo vissuto lui stesso, in prima persona. Lo stesso è vero per un altro grande scrittore: Giorgio Manganelli, che nel suo libro, Discorso dell’ombra e dello stemma consiglia la sconfitta con queste parole: «E questo, questo appunto è il gran gioco, ove chi perde vince. Ma il difficile è perdere. Estremamente difficile e necessario. L’inferno è vincere».
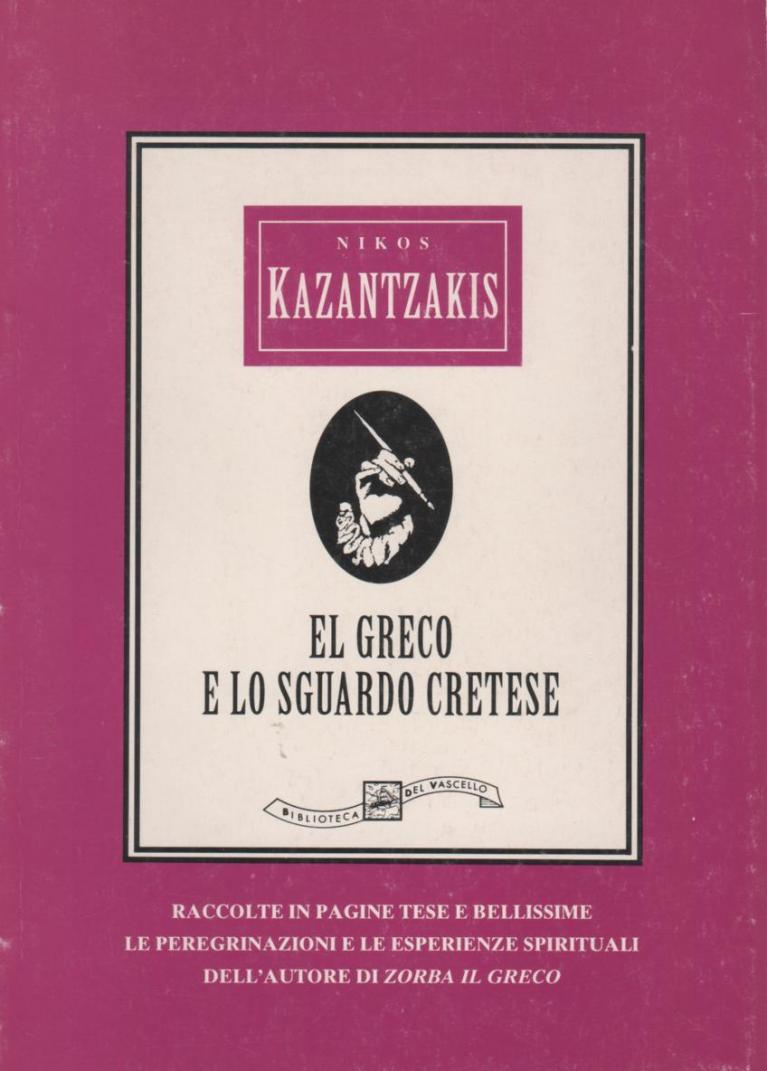
Nella tesi si è seguito il filo biografico, partiamo quindi dall’inizio, infanzia e genitori. Potrebbe tracciare dei brevi ritratti di sua madre e di suo padre?
Ho sempre scritto pochissimo di loro perché sono avvenute esperienze, anche gravi, con conseguenze che sono poi durate tutta la vita e che mi hanno impedito di continuare a provare per loro un vero amore filiale. So che devo loro la vita e un aiuto finanziario che mi ha reso libera, ma ciò a livello profondo, e per onestà da parte mia, nel confessarlo, non mi impedisce di aver molto sofferto come loro figlia. Per cominciare mia madre era americana, un’americana che non ha mai voluto imparare l’italiano e che durante la Seconda guerra mondiale (essendo gli Stati Uniti una nazione nemica dell’Italia), ha fatto sì che la mia maestra delle elementari di Menaggio, sul lago di Como, dove eravamo sfollate, mi abbia fatto il vuoto attorno in classe, dalla seconda alla quinta, ripetendo sempre questa frase quando mi interrogava: “Ma tanto non saprai rispondere perché sei anglosassone”. Il 25 aprile, quando i partigiani scesero in paese, la raparono in piazza assieme ad altre donne notoriamente fasciste. Non provai alcun senso di vendetta per fortuna mia, ma era un giorno di gran vento e tutti quei ricci, che vorticavano come mulinelli, mi fecero provare il senso fisico della nausea. Nel gennaio, sempre del 1945, mia madre stava andando a Bellagio con la sua migliore amica e il battello sul quale si trovavano venne mitragliato. La grande amica di mia madre morì e mia madre venne ferita al braccio destro che non riuscì più ad aprirsi e a piegarsi come prima. Anche la sua mente non fu più la stessa e nel 1946, un anno più tardi, quando lei e io, a 11 anni, andammo negli Stati Uniti per la prima volta dopo la guerra, con un Constellation da Parigi, mi trovai a dover organizzare molte cose, strada facendo, perché lei era troppo “persa” per farlo. Questa responsabilità per me, che a causa della guerra non conoscevo ancora nemmeno il telefono, fu troppo e comunque dovetti poi sempre fare ogni cosa per lei, come una sorella piuttosto che una figlia. Quanto a mio padre, ingegnere elettrotecnico (che lavorava per la SIRTI della Pirelli), con il quale c’era stato vero affetto e complicità, quando gli chiesi se non fosse il caso che mia madre vedesse un medico per i suoi problemi nervosi, anche se non l’aveva mai fatto prima, mi diede una sberla. Non poteva ammettere che ci fosse qualcosa che non funzionasse in lei mentalmente. Il suo comportamento mi lasciò senza parole. A 14 anni mi accorsi che mio zio, fratello di mio padre, di 15 anni più giovane di lui, era omosessuale. Ne parlai con mia madre che fu della mia stessa idea. Mio padre venne a saperlo solo quando aveva 65 anni, a causa di un piccolo scandalo che riguardava mio zio, avvocato, e un suo compagno nella Società farmaceutica dove lavoravano. Mio padre ne fu talmente scandalizzato che si rifiutò di vederlo per il resto della sua vita. Mio padre aveva 41 anni quando nacqui e mia madre 36. In rapporto ai genitori degli altri compagni di classe, erano quasi dei nonni, e questa differenza di mentalità delle diverse generazioni, certo non aiutò le cose tra noi, anche se, nel mio caso, come genitori, mi avevano sempre lasciato molta libertà.
Lei ha esordito come fotografa, come si è avvicinata alla fotografia?
Il merito è di mia madre che si era portata da Milano a Menaggio una pila di Life Magazine alla quale era abbonata. Life era una rivista senza uguali in Europa che dava grande importanza alla fotografia, mentre da noi il vero interesse per la fotografia si manifestò solo dopo la Seconda guerra mondiale. Probabilmente in terza elementare, a 8 anni, cominciai a sfogliare le copie di Life, ne rimasi affascinata e fu come seguire una grande scuola di fotografia. Sapevo parlare l’inglese ma imparai anche a leggerlo (malgrado le difficoltà dello spelling) e comunque come prova della concentrazione e della passione che ci mettevo. A 10 anni ero già sicura che volevo fare la fotografa. Il farlo mi permise poi di stare fuori casa per molto tempo alla volta. Appena finito il liceo, una Società importante mi diede il compito di fare per loro il libro strenna, Borghi e Città d’Italia, quattro regioni per volta, foto e testo, non dei comuni più importanti, ad esempio in Toscana, non Firenze, bensì Arezzo, e fu così che in cinque o sei anni visitai e conobbi in buona parte, tutta l’Italia, facendomi anche le ossa per poi lavorare all’estero.
Invece il passaggio fotografia-scrittura avviene più avanti, dopo i reportage in America.
Esatto, avevo avuto delle grandi e importanti avventure in Egitto per due mesi, dicembre ‘59 e gennaio ’60 e poi negli Stati Uniti dove rimasi un anno, dal marzo 1960 a quello del ’61. A Natale venne a trovarmi il mio compagno di sei o sette anni, Jacques Mc Morrow, sempre vissuto in Italia ma nato in Costa Rica, sangue misto (era ciò che ci legava profondamente), e poiché mi capitò di dirgli che a Milano non mi sarei mai sposata perché, senza prendere in considerazione il matrimonio in chiesa, io comunque non ammettevo di sposarmi con la famiglia, le famiglie presenti… decidemmo di colpo, di sposarci a New York. Mi pareva un impegno meno gravoso, quasi come se fosse un’“altra” a sposarsi… testimone fu Auro Rosselli, inviato del Giorno (a New York lavoravo con diversi giornalisti italiani, compreso Furio Colombo della Olivetti), mio marito tornò a Milano dopo l’Epifania, io rimasi lì ancora tre mesi per lavoro, tornai a marzo, lo dicemmo alle famiglie che furono entrambe contente (si conoscevano dai tempi della guerra sul lago di Como) e mio padre fece trascrivere il matrimonio in Italia, cosa alla quale io non avrei mai pensato. Mio marito aveva già avuto un calcolo al rene diversi anni prima, ma iniziò ad ammalarsi di reni policistici nel ’64, allora non esistevano ancora né il trapianto né la dialisi e il suo carattere era totalmente cambiato, tesissimo, irraggiungibile (per nervosismo, aveva un piccolo incidente d’auto alla settimana andando in ufficio)… io cercai di sapere dal suo medico la gravità della malattia, ma allora i medici non dicevano niente, se avevi il cancro, lo dicevano a un familiare, mai all’interessato. Non ce la facevo più e lo lasciai, questa, ovviamente, fu l’azione più negativa della mia vita, per la quale mi sono poi sentita in colpa fino alla scorsa estate quando feci un ritiro durante il quale, l’ultima notte, un sogno (sicuramente mandatomi dal Lama), mi fece capire, con certezza, con assoluta convinzione che la ragione per la quale scappai, abbandonandolo – Jacques morì un anno più tardi, il 6 del 6 del ’66 – era perché non tolleravo la parola “moglie”, essere la “moglie” di qualcuno era inaccettabile per me, essere “moglie” come mia madre lo era di mio padre, essere in questo, come lei, era per me una prigione. Mi è costato molto confessare tutto ciò così direttamente, mentre nei miei libri ho sempre solo accennato a questi fatti, ma avendolo potuto capire, con questo inaudito dettaglio solo a 82 anni, impegnata nel cammino spirituale da più di 30 anni, mi pare importante venire a conoscenza del fatto che, per chi, come me, ha avuto per più di 50 anni la fissazione della scrittura, una parola, una singola parola: “moglie”, “wife”, possa avere avuto un tale impensabile, spropositato significato. Ma anche ciò che può significare a proposito del rapporto con mia madre. Immagino anche che chi mi leggerà, potrà non capirmi, non riuscirà a credermi… Ho poi convissuto con altri due compagni, per 11 anni, sia con l’uno che con l’altro, prima di divenire monaca, e ovviamente senza mai risposarmi. Mio padre era mancato nel ’63, un mio carissimo amico, di un anno più giovane di me, nel ’65, in un incidente d’auto, mio marito nel ’66. Questi lutti mi fecero capire che non ero più quella di prima, non potevo più pensare di girare il mondo, l’avventura non c’entrava più con me, non mi sarei più potuta divertire, sentendomi meravigliosamente libera come nella vita da fotografa. Ciò mi rattristava profondamente, ma non potevo pensare di essere quella di prima. C’era poi anche da dire che le macchine fotografiche, che mi portavo dietro, pesavano più di 10 chili, riuscivo a vedere il mondo solo “incorniciato” nel rettangolino del visore della Leica…la cosa era divenuta un’ossessione, i settimanali davano la piega che volevano alle storie che raccontavo, travisandole, distorcendole… e, per fortuna, anche la letteratura era un mio desiderio da quando avevo 10 anni… Secondo il Buddhismo una cosa la si capisce solo quando ci si è meritati di capirla.
Nel ’66 esce il suo primo romanzo, Il grande angolo, quanto c’è di Giulia Niccolai nella protagonista Ita?
Assolutamente tutto. Ita in latino significa “andata” (Ite, missa est), Ita, la fotografa, non c’è più, se ne è andata, ha cominciato a scrivere … Ita è il nome di una ragazza che conoscevo al Jamaica, molto bella e che mi era anche molto simpatica. Il mio secondo nome è Margherita, per queste diverse ragioni lo scelsi e lo racconto anche nel testo, Foto & Frisbee, dove ricordo i miei anni come fotografa nei fatti personali e storici di quegli anni Cinquanta e Sessanta e non come pensieri o stati d’animo che sono l’essenza della scrittura originale di Il grande angolo… testo, quest’ultimo che, guarda caso, viene ripubblicato nel 2014, grazie all’interessamento di Cecilia Bello Minciacchi, nella collana à rebours che dirige per la casa editrice Oèdipus di Salerno. Cecilia mi chiese di scrivere un pezzo su come vedo ora Il grande angolo, scritto negli anni Sessanta, e questa mia immersione nel commento alla prima edizione, nonché il lavoro che stavo facendo su Foto & Frisbee, pubblicato anch’esso da Oèdipus nel 2016, è sicuramente la causa di una rivelazione che ebbi su una corriera che da Roma mi stava portando a Napoli dove, a Ischia avrei poi incontrato Milli Graffi e Giovanni Anceschi per una cura alle vie respiratorie che facemmo tutti e tre. A Roma, a un festival della poesia dove ero appena stata, le ultime tre poesie che avevo letto e che ricopio, riguardano tutte Omero:
Lo strumento (con sopra disegnato
un omino supino, le ginocchia
piegate, tre pulsanti sopra e tre sotto),
per alzare o abbassare il mio letto
d’ospedale in tre diversi punti,
è costruito dalla società Hill-Rom
(Zingari della collina?)
e ha nome…
ha nome
AvantGuard.
(Dentro mi risuona una risata irresistibile).
È questa la versione contemporanea
degli dei che comunicano coi personaggi
epici? Quelli di Omero, per fare un esempio?
In terza media, fissando
le macchie d’inchiostro
e i buchi dei tarli del mio
vecchio banco di legno,
mi chiedevo: ma come può
Ulisse aver vissuto così
intensamente, così compiutamente
e noi qui, ora, così… così
comuni, ordinari, “predestinati”?
Mi sbagliavo. Non è questione
di tempo. Di duemila anni di
differenza, né di quei particolari
e spesso magici eventi esterni.
Audacia, sofferenza, pazienza
e poi anni di lavoro in miniera
per prendere coscienza di tutto ciò
che si è fatto (di giusto e di sbagliato)
e del perché…
e finalmente, quasi alla fine
vieni accontentato.
Capisci la metafora che Omero
ci ha dato. Il modello epico.
Sempre possibile. Mai cambiato.
Solo da quando
ho ritrovato
me stessa tredicenne,
ho anche capito
che l’Odissea
è il libro più importante
della mia vita.
Sempre mentre ero a Roma avevo ricevuto una telefonata da Franca Mulligan dal Connecticut, dove vive parte dell’anno, che mi raccontava del fatto che il nostro comune Maestro, Thamthog Rinpoche, aveva dormito da lei dopo essere giunto negli Stati Uniti dall’India, per proseguire il giorno successivo a Ithaca nello stato di New York, dove c’è la più importante Università del Buddismo Tibetano degli Stati Uniti. Solo su quella corriera, forse cullata dal ritmo del motore e del movimento, mi resi conto della coincidenza, che non mi aveva mai sfiorato, tra il nome Ita e l’isola di Itaca, con quella “ca” finale che è anche la prima lettera dell’alfabeto tibetano “ka”! Dunque Ita era sì andata, ma era anche tornata!! (Tornata al Buddhismo essendo io ormai certa di essere già stata discepola dei Lama tibetani in vite precedenti). Ecco, questo tipo di epifanie che riescono a collegare tempi lontanissimi tra loro, spazi immensi, si vivono come doni inimmaginabili, coincidenze talmente preziose da trasformare la vita in fiaba!
Continuiamo con gli anni vissuti a Mulino di Bazzano, cosa accadeva in quella cucina-fabbrica di idee e di poesia?
Era il ’68, con molti altri del Gruppo ’63, Spatola era venuto a Roma a un incontro di Quindici, vi era rimasto e stava da me perché ci eravamo messi assieme. Ma non voleva vivere in città. Desiderava un luogo isolato, in campagna, vivere una situazione scelta da lui, l’ideale per la sua poesia e per mandare avanti la piccola casa editrice che aveva fondato con i fratelli per pubblicare testi sperimentali e la fondazione di una rivista che fu poi Tam Tam. Voleva che questo luogo fosse in Emilia, per essere vicino a suo figlio che stava a Bologna. La madre e la zia di Corrado Costa ci affittarono una deliziosa casa contadina nella corte dove abitavano anche loro, appunto a Mulino di Bazzano, a una trentina di chilometri sia da Parma che da Reggio. Con la poesia concreta e visiva, Adriano era in contatto già da anni con coloro che le praticavano in tutto il mondo: Stati Uniti, Sud America, Giappone, Europa. L’aspetto fondamentale di questa poesia è che supera le barriere linguistiche e ci si capisce quasi sempre! Lavorando in questo campo, rivista e casa editrice cominciarono a essere conosciute da piccoli gruppi ovunque. Mettemmo in piedi un laboratorio per stampare in proprio e alle macchine da stampa lavorarono una serie di amici e il fratello minore di Adriano, Tiziano. Non avevamo telefono, ma venivano in molti a trovarci, poeti amici francesi, svizzeri, austriaci, tedeschi e poi americani. Ovviamente poeti e anche molti pittori italiani. Daniela Rossi avrebbe poi coniato per il Mulino, il termine La repubblica dei poeti. Si lavorava tutti assieme, ovviamente anche con Corrado, amico di lunghissima data di Adriano, felici di avere tutti gli stessi interessi, senz’ombra di competitività (ora sembra impossibile), ma non c’era proprio, mai provata! Ricordo quegli anni con lo stesso piacere, la stessa allegria con i quali ricordo gli anni Cinquanta del Jamaica a Milano.

Poi all’improvviso torna a Milano, cos’è successo?
Spatola era un potentissimo leader, riusciva a occupare tutto lo spazio. Aveva orari e abitudini di lavoro stravaganti. Un giorno lavorava per 16 ore, bevendo molto ma sempre in controllo di ogni cosa, il giorno successivo lo passava a letto, per riposare e disintossicarsi. Sembra infattibile – solo eccessi – ma per lui funzionavano perfettamente e riusciva anche a lavorare moltissimo. Io e gli amici ospiti presenti, o il fratello Tiziano che negli ultimi anni è vissuto con noi, dovevamo per forza seguire questa stessa routine, che ci andava anche bene, ma avevo tutta una serie di altre cose da fare: la cuoca, la spesa, guidare l’auto, la segretaria ecc. e avevo veramente pochissimo tempo per me stessa. Quando scrissi il mio primo nonsense geografico, A Marmolada, ottenuto con il semplice articolo “A” in inglese, piuttosto che quello italiano, “Una” Marmolada (il tutto comunque suona sempre come Una marmellata di marmo) … Adriano mi chiese: non vorrai mica scriverne altri? Non feci una piega, e ne feci tanti da poter formare una plaquette. Ma nel ’77 mia madre, che viveva a Firenze, si ammalò di cancro, era accudita, comunque per mesi feci un costante su e giù tra Firenze e Mulino di Bazzano. Mia madre morì nel novembre nel ’78. Restai a Firenze per sistemare ogni cosa, ovviamente per parecchio tempo, tornai a Mulino in auto con le sue ceneri, avendo già appuntamento con i cugini a Cassinetta di Lugagnano, sul Naviglio, a una trentina di chilometri da Milano la mattina successiva per seppellire l’anfora nella cappella della famiglia Negri dove già riposava mio padre. Sull’Appennino, tra Firenze e Bologna, iniziò a nevicare e la cosa mi preoccupò molto per il resto della strada da fare quella sera per raggiungere Mulino, nonché per il viaggio la mattina successiva e poter essere a Cassinetta alle 11. Per fortuna nevicò poco. Arrivo comunque trafelata a Mulino, attorno al tavolo di cucina dove si lavorava sempre, ci sono Tiziano e Adriano, che mi dice, appena seduta: guarda che bella poesia ho fatto oggi! (Si trattava di una poesia concreta). L’avrei fulminato. Solo molti anni più tardi, meditando, meditando, sono riuscita a interpretare in maniera non mostruosamente egoistica quella sua frase. E per lui, che aveva scelto di stare fuori dal mondo il più possibile, è sicuramente l’interpretazione più corretta: Guarda che bella poesia, grazie al fatto che sono rimasto qui, fermo, protetto in questa casa e non in giro per l’Italia dove succede di tutto… Comunque dimenticava il fatto che tutto quel suo poter stare fuori dal mondo era merito mio, che mi occupavo di questo e di quello, mentre lui, con la sua autorità era sempre riuscito a “non esserci per nessuno” … Comunque quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Era impossibile dirgli che per me era tutto finito e me ne andavo. Avremmo discusso per giorni e giorni fino ad avere lui la meglio per sfinimento mio. Quando a dicembre andò a Lugano con Tiziano, nell’auto di quest’ultimo, a presentare i libri Geiger, io colsi l’occasione, feci una vigliaccata, gli scrissi una lettera e scappai a Milano. Si comportò con grandissima correttezza. Cercò di farmi tornare con sé solo un anno più tardi, ma io gli dissi che non me la sentivo più. Rimanemmo amici e lui si sposò dopo due o tre anni con una giovane.
E poi arriva Ian Simpson…
Sì, lo conoscevo già dagli anni Cinquanta, era maltese, figlio di un colonnello inglese, a Milano era stato ingaggiato per giocare nella squadra milanese di rugby, cosa che fece con successo per parecchi anni. Poi lavorò come traduttore dall’italiano in inglese. Anche nel passato ci eravamo piaciuti ma non era successo niente. Ci eravamo poi sposati, lui con una ragazza americana che conoscevo bene e avevano avuto due figli. Ma nel 1980 ci innamorammo veramente, sua moglie venne a saperlo e iniziammo a vivere assieme. Quando incontrai il Buddhismo nel 1985, il nostro amore era finito a causa di una sua scappatella. Dopo che nel ’90 andai in India e divenni monaca, lui giustamente ritrovò una vecchia amica inglese della sua giovinezza, vedova, e si misero assieme. Non l’ho mai incolpato per questo e sono divenuta amica di Sue. Nei suoi riguardi non ho mai avuto il senso di colpa che ho avuto per Jacques. Così però anche, conoscendo bene Spatola, nessun suo amico mi ha mai incolpato d’averlo lasciato. Quando un giorno, un paio di anni fa, dissi al suo grande amico, il poeta americano Paul Vangelisti, che probabilmente mi ero fatta monaca “anche perché” avevo vissuto undici anni con Spatola, Paul (che l’ha sempre ammirato incondizionatamente come poeta), si fece una risata molto, ma molto partecipe e divertita!
Nell’81 esce Harry’s Bar e altre poesie (1969-1980).
Esatto, lì è stato un bel colpo di fortuna, perché un giorno, venuta a Milano per lavoro o per consegnare una traduzione, probabilmente a Rosellina Archinto, mi trovai in Piazza Scala (sarà stato il ’77 o il ’78), mentre stava arrivando un comizio, vidi Porta che lavorava lì vicino, alla Feltrinelli, andammo a rifugiarci in un bar e mi chiese se avevo qualcosa da pubblicare. Certo! risposi, e fu così che decisi in quel momento di riunire tutte le poesie e di chiedere poi l’introduzione a Giorgio Manganelli. Da allora, sento di dovere molto ad Antonio Porta, perché da parte mia, per anni, non sono mai riuscita a farmi pubblicare un testo di poesie…
Cosa direbbe a proposito della sua raccolta Humpty Dumpty?
Verso la fine degli anni Sessanta mi capitò di leggere Alice nel paese delle meraviglie, senza ricordare se mi fosse stato letto da bambina. Ne rimasi incantata e capii subito, a livello profondo, con sicurezza, che quell’umorismo era il tono, lo “spazio” adatto, per la poesia che mi sentivo di scrivere. A questo proposito un Lama una volta diede questa meravigliosa definizione dell’umorismo: trovare spazio dove spazio non c’è. Questa frase la venni a sapere solo dopo il Duemila, ma corrisponde esattamente a ciò che provai io allora! L’avanguardia mi aveva già aiutato moltissimo a fare piazza pulita dei toni e dei ritmi della metrica del passato che non riuscivo a togliermi dalla mente. Prova ne sono i nonsense geografici, ognuno col suo ritmo che, a seconda della lingua nella quale i nonsense sono scritti, imitano la poesia inglese o italiana o francese del passato. (Un’ossessione anche questa, come lo spazio rettangolare dello schermo della Leica del quale ho parlato prima). Humpty Dumpty è un omaggio a Carroll fatto col cuore e con grande gioia.
E per quanto riguarda Greenwich?
Mi pare di aver appena parlato dei Nonsense geografici, così come mi era già capitato anche prima a proposito di A Marmolada. L’ossessione dei ritmi e delle rime della poesia del passato, così come per lo spazio rettangolare dello schermo della Leica mi portano ora fuori tema, permettendomi però di ricordare una particolare cocciutaggine da parte mia nella ricerca in generale, che mi riguarda a fondo, e che ha sempre finito anche col darmi grandi soddisfazioni. Più o meno, da quando avevo una ventina d’anni, mi sono chiesta, mi sono sempre chiesta come mai… per la miseria, come mai, perché la Gioconda fosse il quadro più famoso del mondo? Comprando un giorno a San Polo – dove facevo la spesa – un fustino di detergente per la lavatrice, il droghiere mi regalò un quadro in plastica della Gioconda che mettemmo sopra il caminetto nella cucina di Mulino, proprio di fronte al posto dove mi sedevo sempre io, sia per mangiare che per lavorare. Bene! mi dissi soddisfatta, questa volta riuscirò a capire qualcosa! La Gioconda restò lì, muta, per un paio di anni. Ma una sera, che ero sola in casa, cominciai col rendermi conto della posizione delle sue braccia, come se ci tenesse un bambino sdraiato che però non c’è, dell’abito nero sopra braccia e mani, sul petto, che forma una sorta di vuoto e poi più su, quel suo sorriso e lo sguardo, rivolto a me, direttamente a me e che mi sta dicendo… sta dicendo a me che la guardo: il Bambino sei tu! Fu uno dei momenti più felici della mia vita, più “pieni”, più compiuti, non per quello che dice Monna Lisa (un po’ difficiletto), ma per averla capita e capito la ragione (celata) per la quale è il quadro più famoso del mondo!!! Allo stesso modo, ebbi per tutta la vita la fissazione del “mare color vino”, delle “onde viola” dell’Odissea. L’ho sempre cercato, dovevo assolutamente vederlo, dopo averlo letto in terza media! Non l’ho mai trovato né in Italia, Francia o Spagna. Lo vidi per la prima volta negli anni Novanta su un battello che da Rodi mi portava a Simi (io ne avevo ormai più di settanta) e fu forse proprio in quel momento che riuscii a capire che l’Odissea è il libro più importante della mia vita.
Per quanto riguarda le influenze artistiche, quali sono gli autori che più l’hanno appassionata?
Direi, per cominciare, ai miei vent’anni, gli americani del primo Novecento, Faulkner che ho letto per ultimo dopo Hemingway e Fitzgerald; degli italiani, assolutamente Calvino; dei francesi Queneau, tecnicamente la poesia d’avanguardia, senza la quale non mi sarei mai permessa di scrivere poesia… In senso pratico, Germano Lombardi con il suo Barcelona da Ècole du regard, che mi “diede lo spazio” entro il quale scrivere Il grande angolo. Germano era anche un grande amico. L’Odissea…
I985. anno fondamentale in cui capitano due cose importanti. Sempre nell’85 conosce il buddismo.
Esatto! L’ictus cerebrale a 50 anni che mi toglie la parola: mi sveglio la mattina presto per un colpo di tosse, vado in bagno, il cane tutto contento pensa che stia per portarlo fuori, lo voglio informare: No, Lennie non usciamo ancora… e non mi esce nemmeno una parola, solo suoni inarticolati! Sveglio Ian, gli faccio capire cosa è successo, lui conosce una dottoressa al Besta, la chiama, andiamo da lei con me che guido l’auto, in ospedale non c’è un letto, mi da una pillola per mantenere la liquidità del sangue e vengo poi ricoverata il giorno successivo. Nella settimana che segue i medici notano con sorpresa che ho un paio di libri sul comodino, ne restano sbalorditi (sic), decidono che con la mia frequentazione delle parole non avrò bisogno di logopedia, mi tengono una settimana e dopo tutti gli esami necessari mi mandano a casa. È ovvio che non riuscirò più – chissà per quanto – a leggere poesia in pubblico, mi sento tagliata fuori, una vera batosta, ma solo una settimana più tardi un’amica mi parla dei Lama tibetani, di un insegnamento che ci sarà in una casa privata di Via Romolo. Decido di andarci, ho l’indirizzo, lei e io avremmo dovuto incontrarci a Cadorna, alla linea verde, lei non arriva, ci vado da sola. Gonsar Rinpoche, abate di un monastero in Svizzera, a Mont Pelerin, sopra Vevey, sta parlando dell’iniziazione di Kalachacra (La ruota del tempo) che S.S. il Dalai Lama guiderà a Rikon, in Svizzera, a fine luglio. Mentre Gonsar Rinpoche parla, io faccio diversi pensieri in proposito, e lui, puntualmente, risponde poi a ogni mio pensiero. Ne rimango sbalordita e non so perché ma mi dico anche: non mi dire che qui sto trovando ciò che cerco da una vita??? Il giorno successivo Gonsar Rinpoche indossa occhiali da sole per difendersi dal trapano del mio sguardo ma io sono sempre più felice e incredula. Mi iscrivo subito ai dieci giorni di Rikon. E così inizia il mio cammino spirituale. Dopo che, negli anni, ebbi la certezza di essere già stata tibetana e buddhista in una vita precedente, volli chiedere a Lama Kenrab: ma lei si rende conto di quanto possa essere stato difficile per me vivere per cinquant’anni in Occidente senza buddhismo, essendolo già stata? Certo che lo so, mi rispose. Nell’86 o ’87 nell’Autoantologia degli scrittori italiani, a cura di Felice Piemontese confesso: «Dopo aver trovato il Buddhismo tibetano ho avuto la sensazione di aver combattuto per cinquant’anni nella Legione Straniera e di essere finalmente tornata a casa!»
Più volte lei ha sfiorato l’idea di abbandonare la scrittura.
Beh no, non l’ho mai sfiorata io quell’idea, in pratica me l’hanno proibito i Lama, facendomi lavorare così tanto per loro, dopo averli incontrati nell’85, da non avere il tempo fisico per farlo. Ma nel ’93 l’amico Julien Blaine mi invitò a Marsiglia per stare tre mesi, stipendiata, in un appartamentino per poeti stranieri della Casa della Poesia da lui fondata in quella città. Dovevo solo scrivere qualcosa che loro poi avrebbero pubblicato per documentare il mio soggiorno. Comunque il testo era di mia scelta, qualsiasi argomento andava bene. Chiesi ai Lama se potevo andare e loro se ne dimostrarono entusiasti. Io avevo appena iniziato Esoterico biliardo e mi ero ripromessa di andare avanti con quello, magari anche di finirlo. Ogni mattina mi mettevo alla macchina da scrivere ma non riuscivo a battere una sola parola! Incredula e mortificata, mi mettevo così a meditare per venire a capo di quel mio incomprensibile blocco! Erano otto anni che volevo scrivere e non ne avevo il tempo! Beh, nemmeno lì, con più tempo di quello che potessi volere, non ci riuscii in alcun modo, e dopo due mesi tornai a Milano sconfitta! Mesi più tardi, mi resi conto che dopo Mulino, tornata a Milano nell’Ottanta, avendo iniziato i Frisbees che sentivo veramente miei, come una meta finalmente raggiunta, avendo tentato di farli pubblicare, mi ero trovata invece tutte le porte chiuse in faccia (altro aspetto della Discesa agli inferi), e fu proprio allora che, come conseguenza di ciò, cominciai a desiderare il riconoscimento e il successo (cosa che, come ho già scritto, non mi era mai capitato prima). Desiderio di riconoscimento e di successo? Impensabile secondo la morale buddhista! Avendolo finalmente capito, da allora ho potuto scrivere ciò che ho voluto: ben sei volumi di prosa e frisbees. Favole & Frisbee uscito a maggio di quest’anno da Archinto, dovrebbe essere l’ultimo, perché ora che sono arrivata a un certo livello del cammino spirituale, è bene che non scriva più di buddhismo, come ho invece fatto dal Duemila nei miei ultimi sei testi. In senso spirituale, scrivere è una forma di autocompiacimento. Non posso fingere che non sia vero, e sono disposta a smettere.
Comunque, i Frisbees l’hanno aiutata a staccarsi dalla sofferenza?
I Frisbees sono il risultato di come funziona la mia mente, sempre alla ricerca della “felicità”. Sono sempre stata considerata matta quando lo dicevo, anche prima del buddhismo. Era come se pretendessi qualcosa di impossibile… Eppure… beh, forse è sbagliato chiamarla “felicità”, forse si tratta di serenità, con possibili momenti di gioia (vedi appunto i frisbees che capitano), il fatto di passare anni e anni a “esaminare la vita” e il riuscire, lentamente ad avere una “vita esaminata”, il sapere che ha saputo accordarsi al destino che le è stato prescelto… e per finire, per finire… nel 1990, Adelphi pubblicò una plaquette per gli amici con due lettere che Giorgio Manganelli scrisse alla cognata Angela dopo la morte del suo amato fratello, l’ingegnere Enzo Manganelli. Nella prima di queste lettere, Giorgio dice alla cognata: «l’eterno non è un tempo lunghissimo, inumano, ma l’assenza di tempo…». Conoscendolo bene, ammirandolo incondizionatamente, leggendo questa frase in quel particolare doloroso contesto, pensai subito che Giorgio non potesse solo citare una cosa letta da qualche parte, che dovesse invece saperla, per esperienza, conoscerla in prima persona! Prima di allora non avevo mai pensato all’eternità che mi pareva lontanissima e che perciò non mi riguardava in alcun modo, ma se lui diceva una cosa simile… Mi misi a rileggere i suoi libri e trovai diverse brevi frasi a questo proposito: «L’eternità è essere vicini, vicinissimi», meravigliosa! o quest’altra, più lunga: «Penso al futuro, mia dimora, come a un gigantesco cubo mentale, e tale lo definisco perché non ne scopro il profilo, e ne ignoro le dimensioni, ma non posso non pensare che in quello spazio sia Tutto, e non solo il Tutto quale oggi lo concepite, ma tutti i Tutti del possibile». Morale: Manganelli non poteva non conoscere l’eternità! Proprio in quello spazio deve essere riuscito a comunicare con tutti quei grandi scrittori del passato coi quali riesce a identificarsi e a parlarcene nei suoi straordinari saggi critici come ad esempio, Laboriose inezie. Nell’eternità c’è solo consapevolezza e di conseguenza si prova solo gratitudine. In altre parole: c’è solo f e l i c i t à !
Dei lunghi viaggi in Oriente cosa ricorda?
Ci sono due aspetti ben differenziati dei viaggi in Oriente: lunghi periodi al monastero dei miei Lama, Sera Je, nell’India del Sud e i viaggi che ho fatto con un’amica tedesca, anche lei buddhista, Adrea Wahl, girando l’India, lo Sri Lanka e la Mongolia, anch’essi importanti e molto belli, avventurosi, con bellissime sorprese. Forse questo breve testo riesce a far capire qualcosa del monastero:
Sotto le tante stelle luminose
di quel cielo che appare concavo
e protettivo come una cupola
– per la prossimità all’Equatore –
il monaco che mi accompagna
con la sua pila per i campi
e i sentieri sterrati, non illuminati
del Monastero di Sera Je nel Sud
dell’India, a un certo punto dice
deliziandomi: la traduzione letterale
di “pila” in tibetano è “lucciola per le scarpe”.
Questa è “poesia” pensai tra me allora
e ora che voglio scriverne ricordando
quel buio avvolgente come seta,
so che era lui il poeta, perché chiedendo
conferma ad altri tibetani, nessuno
di loro l’aveva mai sentito dire.
Devo molto a quel monaco e alla sua
“lucciola per le scarpe” che ondeggiando
avanti/indietro come un metronomo
ha illuminato per anni le buche, i sassi,
i dislivelli e i miei stanchi passi titubanti.
Comunque, non erano viaggi leggeri questi in Oriente?
Beh, dipende… Il primo è stato tremendo perché all’aeroporto di Francoforte mi è venuta l’influenza cinese, fortissima. Arrivata a Delhi ero uno straccio. Andammo in un albergo vicino al Terminal e io dormii per 48 ore filate. In tutto ciò c’è anche una sorta di esagerazione che non può non avere a che fare con una gran batosta di purificazione… Quando vidi il Lama, Thamthog Rinpoche, due giorni dopo, mi disse ridendo: «Pensavo fossi morta!». No, ce l’ho fatta… Dopodiché andammo in città, in periferia, in un alberghetto della comunità tibetana, con la federa del cuscino, ad esempio, non veramente pulita… lì mi tennero chiusa in stanza senza poter uscire, mentre Rinpoche, il suo attendente monaco e un discepolo di Taranto se ne andavano in giro. Mi venivano a salutare la mattina e Rinpoche, sapendo benissimo che mi faceva infuriare, diceva: «Noi usciamo, tu resti qui!». Racconto queste cose perché ora mi fanno ridere! Il cammino buddhista non è uno scherzo, è forse la cosa più difficile che si possa fare, ma se è arrivato il tuo momento, non puoi non farlo e ti senti divenire ogni giorno più libera! Più libera, ogni giorno che passa! In quel primo viaggio, la prima volta che Rinpoche mi lasciò uscire dalla stanza (dieci giorni più tardi), per andare con loro in città, sentii l’India attorno a me come qualcosa di assolutamente già conosciuto, già vissuto. Qualcosa di simile lo dice anche Manganelli, quando scrive che l’India è una sorta di scalo ferroviario dove noi tutti siamo già stati. Comunque allora, alla fine degli anni Ottanta, andare in India era come tornare ai tempi della Bibbia quando ad esempio ti capitava di vedere un contadino con un aratro di legno… In tutti gli altri viaggi successivi non ricordo che mi sia mai successo niente di particolarmente difficile, salvo tutta una serie di prove che i Lama fanno passare ai discepoli, che, col tempo, imparano a riconoscere, ne capiscono la ragione e, dopo che sono passate, ci ridiamo sopra tutti assieme, con complicità e “spirito di corpo”.
Oggi di cosa si occupa? Come passa le sue giornate?
Tendo a svegliarmi alle 6, anche perché vado a letto presto. In passato mi alzavo subito, ma ora a 83 anni, con tutti i dolori alle ossa ecc. resto a letto fino alle 8. Non faccio subito la prima colazione perché non ne sento il bisogno, come in passato. Dovrei iniziare subito le preghiere e la meditazione, invece apro il computer. Spesso rispondo e sbrigo ciò che c’è da fare. Faccio la prima colazione verso le 10, un paio di orette di meditazione e solitamente poi salto il pranzo, ma ceno presto la sera, se non esco. Esco solo per andare al cinema con amiche che mi accompagnano in auto. Non vado più a teatro o ai concerti che vanno prenotati perché non so mai se, quella data sera, mi sentirò di uscire. A volte la mattina, ma più spesso nel pomeriggio, dopo le 16 (perché faccio la pennichella), vedo persone: amiche da lungo tempo ma anche giovani (femmine ma anche maschi) che vogliono parlarmi a causa di dubbi, incertezze, sofferenze o problemi. Ne parliamo e ho parecchi amici in questo senso. I Lama non mi hanno mai fatto lavorare alla segreteria del Centro e quest’altra occupazione mi è arrivata subito, appena iniziato il cammino, con un vecchio amico di mio marito. La spesa la faccio sotto casa a un piccolo Carrefour o per computer alla Esselunga. Daria, una carissima nipote di Jacques, mi aiuta in tutto il resto. Mi accompagna in ospedale per gli esami del Coumadin (medicina per la fluidità del sangue), tipo una volta al mese, mi fa delle commissioni, mi aiuta a fare i pagamenti col computer.
Quindi non scrive più.
Sembrerebbe proprio di no. Ultimamente mi sono state chieste cinque presentazioni di libri o recensioni. Le ho accettate perché si tratta più di dovere che di piacere. Così come ho risposto ad altre domande che mi erano state fatte. Ma di mio, del cammino spirituale, non scriverò più. Ed è giusto così.







