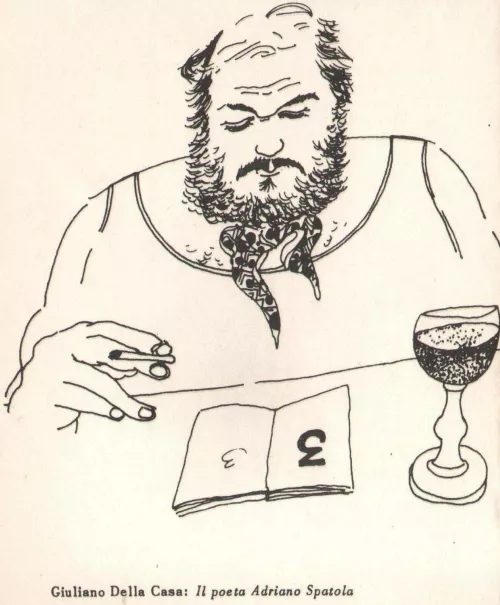Poesia totale / Adriano Spatola: parola incendiaria
«Per il poeta l’eredità è un fatto scontato. [...] Egli si sente in dovere di assumere a tutti i costi il ruolo di manipolatore del fantasma». Queste righe appaiono nel 1969 in un articolo di "Quindici", la rivista del Gruppo 63 che verrà disfatta poco dopo. A pubblicarle è Adriano Spatola (1941-1988), protagonista di quella stagione italiana dove tutto è squassamento, rozza o sottile agitazione dei sedimenti, degli scismi, dei luoghi claustrali della lingua. Inesausto fabbricatore di scritture – tra cui un unico romanzo “parasurrealista” (L’Oblò, Feltrinelli 1964) –, Spatola è stato a sua volta editore e fondatore di riviste come "Malebolge" (1964-1967), trillo inaugurale che fu per Spatola un vero e proprio laboratorio dal quale incominciare il lavoro di paziente incrinatura della letteratura. Sterilità in metamorfosi, poesia inserita nel primo numero e dedicata a Corrado Costa, è quasi un programma sulla radice incendiaria che la parola porterebbe in sé: «Di ciò che stato detto / si sa che è stato detto perché bruci nel mondo.»

Perché tornare a parlare di Adriano Spatola a più di trent’anni dalla sua morte? A che ragione tentare una svelta biografia che finirebbe per esaurirsi in un compendio di silhouette, nell’estinzione di quello che invece era gesto fluviale? L'occasione è data dalla ripubblicazione dell’Opera in versi per la casa editrice [dia•foria, a cura di Giovanni Fontana. Un volume miracoloso, che non indietreggia di fronte all'idea di radunare in un solo "spazio" anche quanto era stato concepito contro l'unità del Libro: “discritture”, “zeroglifici”, “piegature del foglio”, montaggi, manifesti, violazioni compresse da liberare attraversando le pagine – e mai del tutto, come se questa raccolta fosse anche una prima guida per il recupero di opere disseminate in chissà quale vecchia tana o libreria.
Si nota ovunque, persino nel verso più malmesso, il residuo di un’urgenza ancora raccoglibile. Scrive Fontana nella sua introduzione: «poesia come tensione, dunque, e come padronanza, come necessità, come aspirazione a conoscere il senso profondo del reale, come sfida all’intelligenza per giocare a rifare il mondo. Poesia da udire, da leggere, da guardare, poesia da stringere, da palpare, [...] da vivere, da amare, da cantare, ma anche da bere e da mangiare.»

Seconda settimana internazionale della performance, Palazzo dei Congressi, Bologna, 1978.
Un motivo ugualmente urgente per la ripubblicazione delle opere lo indica lo stesso Spatola quando in Majakovskiiiiiiij (Geiger, 1971) afferma: «ma niente di meno accettabile dell’ingiuria del punto fermo.» Continuiamo allora a spanderne il gesto, cercando di sottrare il ritratto al ricovero delle certezze biografiche, perché se vero che Spatola viene sbrigativamente definito poeta “visivo, sonoro, gestuale”, poeta “totale”, come suggerisce il titolo di una delle sue opere teoriche più note (Verso la poesia totale, Rumma, 1969), è ugualmente vero che spesso si tralascia ciò che questa stessa definizione sottende: l’insistenza a sgualcire ogni supporto certo, il gioco delle invenzioni combinatorie, il supplemento intraslabile e dunque il luogo di una perenne inattualità.

Carlo A. Sitta, "L'enigma di Isidore Isou", in "Verso la Poesia Totale".
Con inattualità vorremmo che qui s’intendesse il sopravvivere di un disassestamento che Verso la poesia totale porterebbe sempre con sé come quanto non può accordarsi col presente delle cose, né ora né mai. Siamo chiamati una volta tanto nella regione dello scrimolo, del diastema tra tempi sfasati, tra tempi tagliati di avvenire e reminiscenza. Scrive Georges Didi-Huberman in L’immagine insepolta (Bollati Boringhieri, 2006): «In primo luogo, la sopravvivenza anacronizza il presente: smentisce violentemente le evidenze dello Zeitgeist, quello “spirito del tempo” sul quale si fonda tanto spesso la definizione degli stili artistici.». Il verso del titolo alluderebbe proprio a questa esperienza operativa dell’eccesso, a questa «resistenza al tempo d’epoca» per cui la poesia totale cesserebbe di risuonare soltanto qualora si rassegnasse a uno sviluppo storico: «Il poeta sa che la poesia è qualcosa che lo riguarda sempre meno.».
La poesia è così iniziata al suo rovescio apoetico e inoccludibile. Il fatto che le antologie “iper-sperimentali” create da Spatola insieme ai fratelli (e inizialmente stampate in ciclostile) prendano il nome dal contatore Geiger, esplicita sin da subito l’invito alla contaminazione, alla belligeranza radioattiva, al principio di perenne sforamento. A partire dal 1967, Geiger ospiterà il rotolio di quella trepidazione apoetica che oramai irrompe da ogni dove, e che non conosce più limitazione perché «i reticolati che dividevano i generi artistici, confinandoli nei rispettivi campi e costringendoli all’uso limitato dei soli propri mezzi espressivi, sono caduti o stanno cadendo». A questa avventura mondiale non serviva altro che un’isoletta cartacea dove i cascami del fermento potessero essere pinzati insieme. In un articolo del quadrimestrale "Avanguardia", Maurizio Spatola descrive così la genesi di Geiger (in seguito Edizioni Geiger):
«Il metodo originale per la sua realizzazione consisteva nel richiedere a un certo numero di autori operanti negli spazi artistici e letterari cui eravamo interessati l’invio di 300 copie in formato A4 di un loro lavoro. [...] Si trattava di un vero azzardo, sull’onda del coup de dés mallarmeano, ma la scommessa risultò vincente: quasi tutti gli artisti invitati accettarono, più o meno entusiasti.»

L’importanza di Adriano Spatola è proprio dovuta all’inesauribile rete di incontri che egli seppe organizzare attorno a sé sena mai prendere il potere, rigettando le chiare definizioni, le formule repentine, devitalizzate – favorendo al contrario il versarsi di una forma nell’altra. Proprio attraverso questo scarto tra protocolli linguistici, Spatola ha continuato a ribadire per tutta la sua vita che illeggibilità e indicibilità sono intervalli necessari in cui la lingua torna a visitare il fondo delle sue possibilità non attualizzate. Si prendano ad esempio gli Zeroglifici, schede in cui la mistura o il fraseggio di bianchi e neri annuncia l’avventura di un alfabeto infranto, venuto meno al perimetro significante, al sepolcro della riproducibilità tipografica, e tutto in funzione degli interstizi. Giulia Niccolai, che di Spatola fu compagna e fondamentale collaboratrice, li descrisse come «trascrizione visuale di una musica possibile solo se rigorosamente mentale». Sempre con Niccolai, Spatola inaugurerà nel 1971 la rivista "Tam Tam", che in poco tempo diventerà la fucina operativa di gran parte della nuova sperimentazione poetica (italiana): un avvicendarsi di innesti e vagheggiamenti, di «impulsi extra-letterari, di atteggiamenti reperibili nel campo delle arti figurative, della musica, del teatro, o del cinema underground». Inquieta disobbedienza agli itinerari certi che Spatola trasferirà anche in un personale corpo a corpo con la poesia, impiegando la voce per contro-effettuare il testo, dando così vita a partiture sciolte, rumorismi, acrobazie per fiati e percussioni, come nella celebre Ionisation, performata «a colpi di microfono sul corpo (ventre, cuore, arti)» (Giovanni Fontana).
Due altri esempi, a manifestare l’insufficienza di ogni salda definizione. Il primo è l’evento Parole sui muri (organizzato da Spatola nell’agosto del 1967 insieme con Costa e Parmiggiani), in cui il comune di Fiumalbo si trovò ad accogliere una moltitudine di artisti, diventando una specie di Theatrum Mundi, prima (antichissima) dimostrazione di come l’atto creazionale potesse estendersi a un intero paese attraverso un impeto collettivo di liberazione, di risveglio geografico e animante, di frattura nella continuità domestica. Il secondo è tratto da La composizione del testo (Cooperativa Scrittori, 1978), dove Spatola traccia lo scritto come materia vivente, la lima con la quale forzarsi un varco nella struttura irrigidita della vecchia poesia, fenomeno terminale:
Ma il testo è un oggetto vivente fornito di chiavi
la cruda resezione il suo effetto l’incredibile osmosi
è questo il momento che aspetti cominciare a tagliar
guarda come si tende e si gonfia sta per scoppiare
è l’immaturo anaconda si morde la coda strisciando
odore della palude odore coniato da fiato di fango
un libro un quaderno una penna un desiderio indolore
senza parole

Come dimenticare dunque la fine della poesia? Non più soltanto la fine che c’è già stata, ma anche quella sempre sul punto di venire, di tramutarsi in un eschaton, in buona novella liberale: «la fine della storia ad opera di Dio è diventato il progresso storico dell’umanità» sentenziava già Sergio Quinzio in La croce e il nulla (Adelphi, 1984). Il «perché i poeti in un tempo di povertà?» dovrebbe ora essere riletto diversamente: «perché i poeti in un tempo di povertà destinata a scomparire?», in un tempo cioè di prossima, gioiosa automazione, di accelerazionismo più che di «scientia potentia est». Perché la poesia quando potremmo giocare con le avvenenti vergini del paradiso, come accade nell’Epistola del perdono, classico della letteratura araba dell’XI secolo ove s’immagina il viaggio di Ibn al-Qārih – tessitore di pedanti congetture – attraverso una singolarissima versione dell’aldilà islamico nella quale nessuno sembra più ricordare le opere composte in vita. «Appena ebbi varcato i cancelli del Paradiso non una sola parola delle mie odi mi restò nella memoria» confida uno dei grandi poeti incontrati da Ibn al-Qārih.
Oggi si tratta ancora di confrontarsi (come nel secolo passato) con questa rassegnazione e con questa consolazione, con una certa attitudine a piegarsi agli immaginari correnti. Scavare nel linguaggio una vertigine compressa: ecco il solo resto della poesia che continua a riguardare il poeta, prima – o in vista – di ogni possibile paradiso (terrestre). Da Spatola occorre recuperare soprattutto la percezione della poesia come esercizio di contestazione delle pratiche solidificate e dei grumi di potere fissati nei supporti passivi. Se Ferdinand Kriwet sosteneva che «l’epoca del libro» doveva ancora arrivare (e tutta l’esperienza delle Edizioni Geiger è pregna di questa promessa), noi possiamo dire lo stesso dell’epoca della rete, cercando così di far traboccare dal link un medicamento per la facoltà immaginale. Un modo di pensare per incastri, per efflorescenze; un modo già in qualche maniera prefigurato nell’esperienza antistatica della letteratura di ricerca. Poesie da Montare (1965), che Spatola volle dedicare a Emilio Villa, è in questo senso un primissimo campione di materia in fermento, opera inconcludibile da assemblare per incidenti, e consegnata al lettore come l’offerta di un «modello ambiguo di comportamento, una mimesi volutamente esplicita del processo di ricerca in vitro con il quale bisogna fare i conti, scontato tutto ciò che c’era da scontare, di fronte alla pagina bianca di mallarmeiana memoria.»
L’intelligenza polimaterica e la varietà degli strumenti che hanno caratterizzato il novecento non debbono perciò andare perdute a causa della nuova omogeneità digitale, perché è ben chiaro, mi sembra, che un’indicazione rivoluzionaria su come utilizzare Internet non possa che giungere quando si abbandona la zavorra nostalgica per recuperare dal secolo passato proprio quanto non è ancora trascorso: la potenzialità inconscia e sintomatica, il fare ibrido irriducibile a qualsiasi supporto esclusivo.
Dal secolo passato come da altre antichità: «Agendo all’interno del concetto di poesia totale» esplicita Spatola «risulta dunque possibile recuperare all’attenzione del lettore i prodotti dell’avanguardia storica [...]. Non solo, ma viene anche appianato il compito del critico che intendeva ritrovare nella storia dell’umanità gli esempi che più si prestano alla fondazione della problematica di una poesia sperimentale attuale.»

Puzzle-Poem.
Nonostante la nitidezza semantica guardare dunque allo screpolo, alla tacca, ai segni prima delle lettere riscontrabili nelle tradizioni extraletterarie. Tra i molteplici riferimenti presenti nella sua opera teorica, Spatola rimanda a Dom Sylvester Houédard e alle tecniche mnemoniche pre-pittografiche. Pensiamo a Piero di Cosimo – divinatore degli sputi –, di cui il Vasari racconta: «[...] Fermavasi talora a considerare un muro, dove lungamente fosse sputato da persone malate, e ne cavava battaglie de´cavagli e le più fantastiche città e più gran paesi che si vedesse mai: simil faceva de´nuvoli dell’aria.» Ma pensiamo anche al regno della dissomiglianza, ai segni segnanti, che significano e agiscono senza avere significato; all'Arachnéen – costellazione del ragno –, alla glitch art o alla più recente Enciclopedia Asemica (ikonaliber, 2018) di Marco Giovenale, dove si ipotizza che «una qualche forma di ‘tendenza asemica’ possa forse essere individuata e collocata già addirittura alle origini prime della specie (umana), come modalità e modulazione della tendenza a incidere linee e segni astratti / distratti; a operare senza scopo.»
Insomma: poiché vi sia poesia bisogna non rinunciare a inviluppare i tempi, e del tempo dispiegare gli impliciti, lunghi silenzi. Nell’antifonario di Saint Gall si può osservare San Gregorio Magno nell’atto di farsi dettare i canti da una colomba. Oggi come allora, il lembo di stoffa che doveva velarne il mistero è scostato, ma non v’è nessun volatile da scorgere oltre. Lo spirito tace: poco importa. «È ingenuo chiedere alla poesia di sopravvivere mediante esercizi quotidiani di autolesionismo», ammonisce Spatola nell’articolo di Quindici riportato all’inizio. A noi rimane però la bianchezza di un cero spento da agitare in luogo dell’attesa e il vuoto lasciato dalla stoffa dove i fantasmi seguiteranno a passare per annunciare i loro prodigi, le loro inquiete promesse “totali”. Se le pietre non bastano più per le mura di Tebe, ugualmente – e senza scopo alcuno – le tireremo su col canto, come Anfióne, il mitico re-fondatore della città. Del resto, il titolo della prima raccolta pubblicata da Spatola nel 1961, da lui poi rinnegata, era Le pietre e gli dei. Specchio evidente di un’abdicazione, ogni poesia è un affronto all’intera storia della poesia, e un resto che, malgrado tutto, le sopravvive. Proprio per questo motivo ne tramandiamo qui una traccia:
C’è da rifare, ad esempio, tutto il mio passato,
rivederlo, correggerlo, arginarlo
perché non copra tutta la mia vita.
C’è da rifare, anche, tutto il tuo futuro
Se in qualche modo è vero
Che vogliamo un futuro.