Carnet geoanarchico 10 / Dietro la Grande onda
Bologna a febbraio ha già qualcosa di primaverile. Una primavera silenziosa, come quella di Rachel Carson che, nel remoto 1962, lanciava uno dei primi allarmi ambientali spiegandoci che le molecole di DDT e di altri fitofarmaci erano ormai reperibili in ogni parte del globo. Da qui Silent Spring, una primavera muta, senza più il ronzio degli insetti, senza più uccelli. Camminando per Bologna, tra folle domenicali che approfittano dei primi tepori e negozi spalancati per simulare come in un timido carnevale di Rio la correttezza di intenti del neoliberismo cannibale (quello per cui stiamo letteralmente divorando il nostro futuro), camminando per Bologna, guardando i pochi alberi del centro, noto qualcosa di strano, ad esempio che, a dispetto di un’aria mite e profumata e una insensata atmosfera di festa, i calicanti sono fioriti con due mesi di ritardo e i quattro alberelli del cosiddetto arredo urbano sono già esplosi in una nuvola rosa. Davvero troppo tardi, davvero troppo presto, segnali inequivocabili di un disordine stagionale, ambientale, forse mentale. Mi ha sempre fatto riflettere la volubilità simbolica dei fiori: mentre il ciliegio è qui da noi un’immagine positiva di rinascita primaverile, per il Giapponese è l’occasione di una riflessione luttuosa, un modo per ricordare la bellezza e la caducità delle cose. Ero appunto scivolato in questo sostrato emotivo quando ho acquistato il biglietto della mostra Oltre l’onda. Hokusai e Hiroshige, 250 stampe giapponesi dal Boston Museum of Fine Art, 250 interpretazioni inconsapevoli della fine del mondo.
Ma cominciamo dalla fine, appunto, come fanno i semiologi, in questo caso la fine della visita. Nel bookshop affollatissimo, ormai ipnotizzato da paesaggi, carpe e dame in kimono, cedo alla tentazione di un metonimico souvenir. Un segnalibro di Hiroshige? Un magnete per il frigo? Una cartolina della Grande onda? Tra i libri mi attira invece una copertina cinerea, è La lotta dei tori di Yasushi Inoue, più noto per la raffinata Morte di un maestro del Tè. Si tratta del breve romanzo di esordio, scritto nel 1947 all’età di quarant’anni, con cui l’autore giapponese si aggiudicò l’Akutagawa, il più importante premio letterario nazionale. Il libro è la storia di Tsugami, direttore di un giornale di Osaka, che si gioca ben più della carriera per organizzare un evento di tauromachia, il tōgyū, una specie di sumō tra tori che dovrà svolgersi per tre giorni consecutivi nello stadio cittadino. Ma l’uomo è inquieto, minaccia di piovere, lo spettacolo è a rischio e un sentimento di sconfitta aleggia nell’aria:

Dalla cima dello stadio dove si trovava Tsugami si vedevano campi e risaie perdersi in lontananza fino ai piedi dei monti Rokkō sotto pesanti nuvole di pioggia d’un grigio scuro e, tra campi e risaie, sparsa qua e là, qualche fabbrica, e alcune villette celate nel verde della vegetazione. Era un paesaggio gelido e inanimato come una decorazione su porcellana. Vicino alle vette dei monti Rokkō biancheggiavano ancora alcune striature di neve e con la loro sola presenza davano sollievo all’amarezza di Tsugami. Era come se qualcosa della purezza, totalmente scomparsa dal paese dopo la sconfitta, si fosse salvato e raccolto là, a sussurrare tra sé e sé le proprie storie in serena intimità.
Siamo nel Giappone dell’immediato dopoguerra, un paese in ginocchio, smarrito, sull’orlo della bancarotta, un Giappone glorioso che in questa ekphrasis pittorica sembra rappreso come un insetto preistorico nell’ambra del tempo. Proprio come il “pino dei miracoli” di Fukushima. Unico di una secolare foresta a essere sopravvissuto allo tsunami del 2011, venne curato amorevolmente dalla gente del posto, per poi seccarsi e morire diciotto mesi dopo. Che farne? Venne segato, duplicato con calchi e rimontato sul luogo in cui era vissuto, sorretto da una grande gabbia di carbonio alta 27 metri. Dal 2013 la gente ha anche cominciato a piantare ciliegi attorno al finto pino, qualche migliaio ogni anno, per arrivare a 20.000, proprio come i morti del disastro. A pensarci fa venire i brividi. L’imitazione di un pino imprigionato dentro un’impalcatura, una foresta di anime imprigionate tra i fiori, il senso del macabro che sovrasta come un’onda anomala qualunque retorica della rinascita.
Tra le opere esposte in mostra c’era la Visione degli spettri di Taira no Kiyomori di Hiroshige. Kiyomori sta guardando un paesaggio innevato dal balcone della dimora di una cortigiana e le colline, i cespugli, i singoli ciuffi d’aghi di pino, ovattati dalla neve, sembrano teschi umani, teschi piccoli, grandi, enormi, che compongono quello che Dino Campana avrebbe chiamato il “panorama scheletrico del mondo”. Sono gli spettri dei guerrieri del clan Minamoto, massacrati durante le guerre civili del XII secolo e qui, come per i ciliegi, la neve per noi festosa e rassicurante come in un quadro di Bruegel, il bianco per noi virginale e solitamente positivo, diventano le coordinate materiali e mentali di una grammatica giapponese del lutto, un vasto panorama di morte che scardina le abitudini percettive dell’osservatore occidentale. Questi faux amis dello sguardo, i ciliegi, la neve, ci mettono in guardia dal ridurre le vedute di Hokusai e Hiroshige a un tranquillizzante locus amoenus cartolinesco. Se si guardano le stampe da molto vicino si possono vedere ad esempio dei curiosi errori di esecuzione. Alcuni passaggi del foglio sui blocchi di legno spalmati di colore hanno lasciato le tracce di una pressione troppo forte. I contorni del Fuji, o delle nuvole, o di un pino, o di un’acqua corrente hanno segnato la carta, imprimendo depressioni non ricercate, piccoli rilievi che solo una luce radente può rivelare. Un errore produttivo di bellezza, tanto che alcune stampe ci giocano deliberatamente con il piumaggio degli uccelli, ma che in generale ci ricordano un’altra lezione, cioè che la stratigrafia concettuale del paesaggio è complessa. Una pelle per l’occhio, una profondità conturbante per il dito.
Pago il biglietto, lascio lo zaino nel guardaroba, entro nella prima sala, quella con le Trentasei vedute del Monte Fuji di Hokusai. Non mi era mai capitato di assistere a uno spettacolo simile: la gente faceva la fila dietro la prima stampa, in attesa che chi era davanti cedesse il posto a chi era dietro. Poi chi cedeva il posto passava alla seconda stampa, e chi era davanti alla prima passava a sua volta a destra davanti alla seconda, e così via, per trentasei stampe. La sensazione era quella di essere in fila in una lentissima mensa aziendale. Sotto le stampe c’era perfino un’unica lunga scansia per tutta la parete, proprio come il bancale su cui si fanno scorrere i vassoi, ma al posto dei vassoi c’erano delle grosse placche didascaliche che raccoglievano le briciole essenziali. Il resto delle informazioni passava invece attraverso una specie di cellulare dove tu digitavi il numero dell’opera e una voce che doveva essere quella di tuo marito, della tua fidanzata, della tua mamma, ti raccontava che Hokusai eccetera eccetera. Durante la panoramica via crucis si potevano raccogliere anche i commenti estemporanei dei visitatori salariati, e la costernazione non era per nulla mitigata dalla rarefazione dei contorni dei monti tra le nubi.
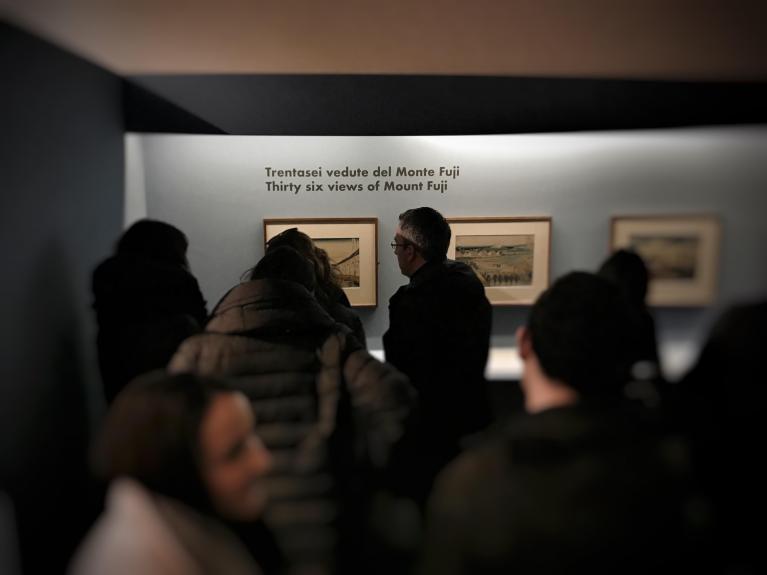
Ma ecco finalmente la Grande onda, all’incirca 10-12 metri d’acqua verticale (a giudicare dalla dimensione delle barche) compressi nei 25 centimetri d’altezza della stampa. Un’equilibratissima rappresentazione del disequilibrio, una ripetizione frattale delle linee curve (specialmente nei riccioli di schiuma, in cui Van Gogh riconobbe degli artigli), un blu di Prussia che tanto piacque in Occidente. Dietro, il Fuji, gli stessi colori del mare, la terra che allude al blu dell’acqua, il bianco delle nevi che alludono ai frangenti, e la spuma volatizzata che simula una nevicata. Ma dietro l’onda che sta per occultare il Fuji che cosa si nasconde? Che cosa c’è dietro al paesaggio? Nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, la Grande onda è in assoluto una delle immagini più virali della storia dell’arte mondiale. Vedere una delle xilografie originali è quasi un gesto eversivo, un atto di resistenza percettiva ed estetica. Ma il paesaggio, dobbiamo ricordarlo, è sempre una trappola, è un cassetto a scomparsa che esiste solo grazie al vuoto che lo riceve, è uno spazio che necessita di un antispazio per palesarsi. Che cosa si nasconde allora dietro la Grande onda?
Il miracoloso pino finto di Fukushima. Milioni di petali di ciliegi a mascherare l’apocalisse radioattiva, come un fallout profumato. I fantasmi dei massacri di guerra sotto la coltre di neve accomodante delle retoriche nazionali. L’arte ridotta a gadget ridotto ad arte. Le 36 vedute del Fuji, le 250 xilografie della mostra non si limitano a rappresentare un mondo di malinconie d’antan e un sistema di ecosistemi completamente estinto. Non sono solo pietre d’inciampo per l’arroganza percettiva dell’occhio occidentale. Non evocano solo spettri di un’estetica ormai svuotata d’ogni spessore antropologico per colpa del copia-incolla mediatico. Dietro la Grande onda c’è la vera massa mancante, quella della Grande cecità, quella dell’incoscienza che, come se niente fosse, spinge la gente a simulare una domenica al museo mentre l’irrimediabile incendio ambientale comincia a ruggire. Non posso non pensare al fatto che impossessarsi di uno spettro di paesaggio orientale dentro una cartolina a 1 euro e 50 sia l’atto ultimo di una negazione privata del disastro: la consolazione delle metafore verdi, la decalcomania voluttuosa del locus amoenus, l’estetizzazione dell’apocalisse.







