Monte Verità: geografie di un’utopia
Il momento migliore di un’utopia è quello che la precede. Appena il suo altrove si traduce in un adesso-qui, il bug autodistruttivo generato da ogni progetto utopico comincia a lavorare verso il disastro o, peggio, verso la normalizzazione. Cose certamente desiderabili come la libertà, l’assenza di conflitti e la conformità a un ideale superiore hanno incistato in sé il fantasma della tirannide libertaria, della pigrizia intellettuale e dell’omogeneità conformista. Così un’utopia è buona da pensare ma, basta aspettare un po’, e diventerà stoppacciosa da mangiare. Rileggiamo le lettere allucinate di Mosè Bertoni dalla colonia Guillermo Tell sulle rive del Paranà, riguardiamo Mosquito Coast di Peter Weir, ascoltiamo Ewan Morrison sulle comunità utopiche di Findhorn, Auroville, Esalen. Quando un progetto si arena, quando l’anticapitalismo degli inizi scende a patti con il neoliberismo, quando l’ideale naturista diventa ossessione salutista, quando il potere è bandito ma anche la democrazia, quando l’autoesclusione dal mondo diventa esclusivismo, quando l’autocritica diventa negazione del fallimento, quando madri fondatrici e padri fondatori si lasciano bullizzare da bande di bambini usciti da Il signore delle mosche, tocchiamo con mano quella che potremmo chiamare “entropia utopica”, il virus oscuro delle comunità intenzionali. Non sempre, certo. Non deterministicamente, è ovvio. Per questo bisogna leggere Monte Verità. Verità senza poesia (Edizioni Casagrande, 2023) di Ida Hofmann che, nel 1900, fondò con alcuni amici una comunità vegetariano-nudista ad Ascona, nella parte più meridionale del Canton Ticino. Ci passarono Kafka, Duncan, Jung, Remarque, Lawrence, Hesse e molti altre e altri, ma la storia profonda è quella dei primissimi anni raccontati da Hofmann.
Per capire il senso dell’impresa occorre fare una digressione. Nel 2000 Richard Bradley pubblica un libro rivoluzionario, An Archaeology of Natural Places. Si tratta del primo studio organico di siti naturali sostanzialmente non modificati dall’uomo che, soprattutto in età preistorica, erano considerati sacri e dunque erano oggetto di pellegrinaggi e di attività rituali. L’archeologia degli sporadici reperti umani che sono indizio di questi passaggi è irrisoria, quello che invece conta sono le emergenze geologiche, le anomalie paesaggistiche e le peculiarità geografiche che hanno attirato l’attenzione dei primitivi e che, ancora oggi, colpiscono l’osservatore. Qualcuno parla di “geositi culturali”, ma si potrebbe coniare il termine di geofanie, per indicare luoghi straordinari in cui la “potenza” della Terra sembra premere dalle zone ctonie per manifestarsi a chi passa. Ora, a detta di molti, disposti a evocare peculiarità geologiche, geografiche, geomantiche, geognostiche e geopoetiche, Monte Verità, un tempo Monte Monescia, sembra avere qualcosa di così “speciale” da aver chiamato a sé persone altrettanto speciali. Al netto della mitopoiesi, che è comunque molto significativa, quello che conta e che si può dire “senza poesia”, proprio per citare Hofmann, è che Monte Verità è una specie di palinsesto felice, un layer cake dove mondo fisico, biologico, antropologico, culturale e spirituale sembrano interconnessi in maniera così armonica da far apparire ogni altro luogo, vicino e lontano, come scarico e desaturato.
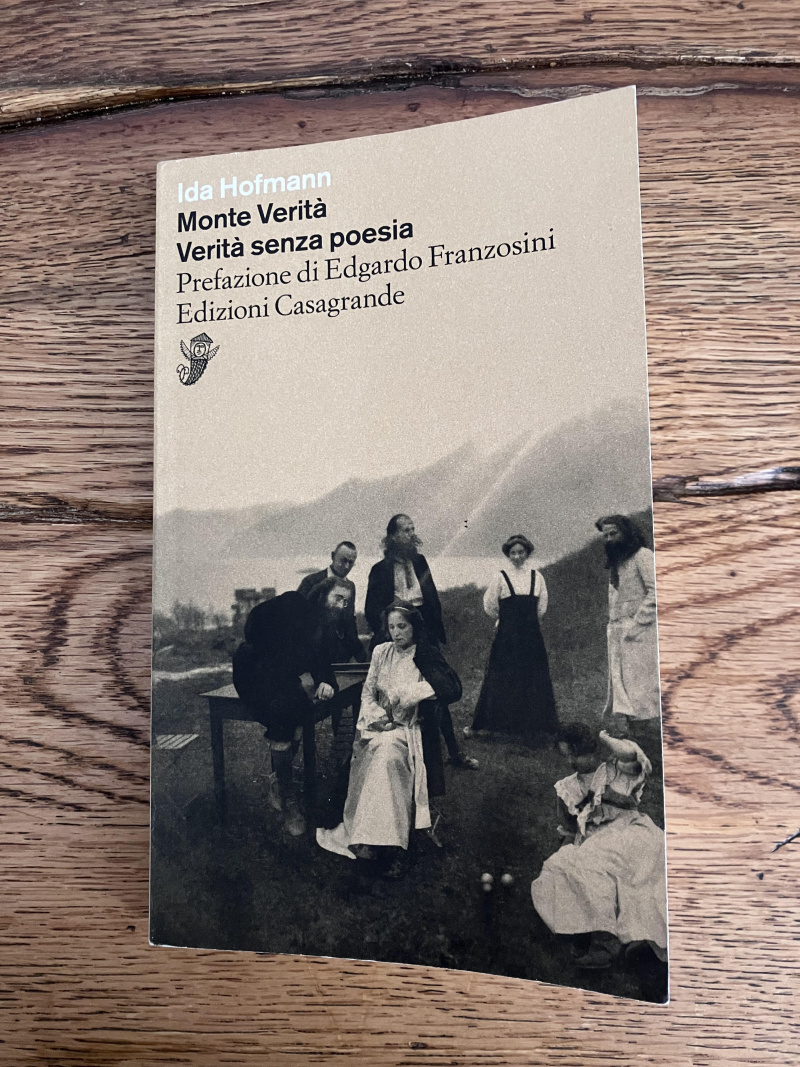
Così, eccoci negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento: in un mondo sempre più grigio e minaccioso, tanto a nord quanto a sud, sia per l’inquinamento industriale sia per quello politico-sociale, Monte Verità, già prima di chiamarsi così, dovette apparire a viaggiatori eretici e irrequieti come una specie di zona salva, un’oasi in cui inventare alternative virtuose al collasso dei tempi. Viaggiatori del genere, molti dei quali artisti, percepivano di vivere in un mondo lacerato da due demoni, la finzione delle convenzioni sociali e un orizzonte economico e del lavoro che tanto il capitalismo quanto il comunismo interpretavano in ottica produttivista. La liberazione tanto ricercata da sovrastrutture culturali, morali, politiche ed economiche portò così alla creazione di una piccola comunità anti-urbana, anti-autoritaria, anti-capitalista. Ida Hofmann racconta la genesi del progetto con tono limpido e sguardo tagliente, come può essere quello governato da un pensiero che ambisce a lucidità e franchezza. Ciò che comunque colpisce fin dal gesto di fondazione è l’attitudine imprenditoriale del gruppo: ciascuno impegna i propri beni mobili per creare un “sanatorio naturista” destinando gli utili derivati da questa attività al progetto utopico-comunitario e alla distribuzione in parti uguali di somme liquide. Anche la scelta del terreno da acquistare fu l’esito di uno scrutinio palmare del territorio. L’analisi qui sarebbe complessa ma, provvisoriamente, si può dire che molte scelte successive e la finale destinazione del luogo mantennero invariato uno spirito che già in partenza era forse dissonante: la libertà ha bisogno di sufficiente denaro per garantirla. Leggiamo infatti cosa dice Ida di Gustav Gräser:
«Camminava a piedi nudi o con semplici sandali, teneva alla cintura un borsino ricolmo di poetiche effusioni e in mano aveva un bastone da pastore. Davanti a lui i bambini si inginocchiavano, pensando che fosse apparso loro il Salvatore. Partendo dal presupposto che la creazione e l’umanità dovessero servire solo al suo sviluppo personale e che possedere denaro fosse un male, si dichiarava privo di bisogni, ma era solo un modo per celare una tendenza ad accattonaggio e pigrizia. Gustav Gräser era troppo pigro per sviluppare il suo innato talento artistico o per mantenersi in qualsiasi altro modo, e così faceva tappa senza scrupoli negli orti dei contadini e li ricompensava per le piccole offerte, il cibo e l’accoglienza con la sua voce tonante e qualche frase sull’amore e la fratellanza; con le sue esibizioni riusciva spesso a ingannare gli animi più semplici. Rispondeva agli sguardi inquisitori con mille cavilli, frutto dei suoi deliri morbosi, e si faceva mettere alla porta con un sorriso compassionevole. Come fosse la nostra ombra, Gustav ci aveva seguiti da Monaco. Con la sua insistenza e il suo tono saccente, che non abbandonava neanche in presenza di anziani, risultava davvero sgradevole a chi gli stava intorno. Era indispensabile porre fine a quella storia e Henri, col mio supporto, gli ordinò con tono perentorio di andarsene. Sorprendentemente Gustav trovò l’appoggio del nostro amico Karl Gräser, ma alla fine i due si arresero e se ne dovette andare. Tuttavia sul Monte Trinità si raccolsero diversi individui della stessa specie. Suscitavano grande scalpore, tanto più che prendevano il sole nudi, incuranti di chi gli stava attorno; molti contadini presentarono proteste formali e così, uno dopo l’altro, furono costretti ad andarsene» (p. 39).

Siamo appena agli inizi, sono le prime pagine del racconto di Hofmann, ma già possiamo leggere in filigrana la duplice tensione di ogni progetto utopico, in bilico vertiginoso tra individualismo libertario e comunità operosa, tra estetica dell’ozio ed etica del lavoro, tra idealismo anti-autoritario e pragmatismo sociale. A soli cinque anni dalla fondazione scoppiano infatti grandi contrasti, si insinuano impostori, aumentano le defezioni, le regole si moltiplicano e si fanno più strette: «Mi divenne sempre più chiaro che Henri, in quanto portatore del principio della bontà, deve utilizzare a volte anche la spada, mentre io, in quanto portatrice del principio intuitivo e gnoseologico, devo consigliare, offrire il mio aiuto e stare al fianco del mio compagno, dotato di entusiasmo giovanile e di uno straordinario ottimismo nella realizzazione dei propri obiettivi. Il gruppo dei nostri collaboratori però si è ristretto. Adesso ne facciamo parte solo Henri, la nostra fedele Klara e io; l’esperienza ci ha infatti insegnato che è necessario avere misure di ammissione più severe. […] Diventa inevitabile ripristinare la categoria dei lavoratori; non posso inoltre che constatare un consapevole recupero di alcune strutture sociali che prima si erano giudicate prive di fondamento e ora vengono invece recuperate migliorandole a poco a poco» (p. 99).
Nel 1920, dopo che Ida e Henri sono emigrati in Brasile senza lasciare traccia di sé, il Barone von der Heydt, banchiere di Guglielmo II e grande collezionista d’arte, acquista l’intera tenuta. Tutto cambia. Nicoletta Mongini, al termine della sua postfazione al libro di Hofmann, scrive: «Oggi Monte Verità è un centro culturale e congressuale, un hotel e un parco pubblico che ospita ancora le capanne aria-luce e ciò che è rimasto dei primi anni del sanatorio. La natura, l’architettura e le attività che vi si svolgono annualmente continuano a mantenerne viva la narrazione, che si è dimostrata, per la sua stessa essenza, straordinariamente attuale, e prefigura nuovi capitoli» (p. 127). Dicevo all’inizio che il momento migliore di un’utopia è quello che la precede. Ida, nelle primissime e più belle pagine del suo memoir, evocando vagabondaggi campestri e locande ospitali in cerca della sede prescelta, scrive: «Dalla piccola trattoria dove avevamo trovato alloggio organizzammo diverse escursioni nella zona; ci guardavamo intorno e ispezionavamo gli appezzamenti in vendita e le costruzioni presenti in essi, verificandone il valore e le potenzialità. Del clima eccellente e dei paesaggi da favola non occorre che dica nulla: tutti ne conoscono il fascino per esperienza diretta o per averne sentito parlare» (p. 32-33). Sappiamo che al cuore del progetto c’era il tentativo di aderire il più possibile alle “leggi della Natura”, ma quale? La Natura non può essere certo ridotta a un “clima eccellente” e a “paesaggi da favola”. Più di un autore, più di un filosofo o antropologo ci direbbe che la Natura non esiste, o che sarebbe meglio andare al di là. Sarebbe meglio parlare di Terra, certo, ma quale Terra, ad Ascona, oltre alla sua geofania montuosa? Forse i nuovi capitoli da scrivere nella lunga, esemplare narrazione di Monte Verità sono da scavare proprio lì, nella territà di un luogo reale che viene prima di ogni storia e di ogni illusione umana.







