Elogio della domanda
Ma è vero che per immaginare e creare ci vogliono un atteggiamento e una condizione di distacco e, addirittura, di indifferenza? In un tempo in cui la più importante preoccupazione è immaginare un mondo che ancora non c’è, perché il presente è fallito, questa domanda ha implicazioni scientifiche e pratiche allo stesso tempo. L’ipotesi è che quello dell’immaginazione non sia uno spazio, un luogo, ma un processo. Non ci aiuta, forse, una visione topologica dell’immaginazione e della creatività. Né una topologia cerebrale, né una topologia contestuale.
Rilke, nelle Lettere a un giovane poeta scrive: “Le persone più dispiaciute sulla terra”, scrisse la poetessa Mary Oliver contemplando il compito dell’artista e l’impegno centrale della vita creativa, “sono coloro che hanno sentito la chiamata al lavoro creativo, che hanno sentito il proprio potere creativo irrequieto e insorgente, e non gli hanno dato né potere né tempo””.
Inquietudine, potere e tempo descrivono abbastanza bene le condizioni generative di quella disposizione originaria alla creatività che è frutto della nostra immaginazione.
Lo spazio dell’immaginazione è sottile e profondo; ambiguo e inaudito; angusto e agevole, ma è soprattutto originario, proprio nella sua ambiguità. Prima di affrontare il percorso di Ian McEwan, in Lo spazio dell’immaginazione [Einaudi, Torino 2022], che è improntato primariamente sulla responsabilità di chi crea letteratura e arte utilizzando l’immaginazione, conviene andare a vedere qualcosa riguardo alle origini e alle espressioni dell’immaginazione nella nostra esperienza. Per non perdersi c’è qualche pista che può essere utile seguire.
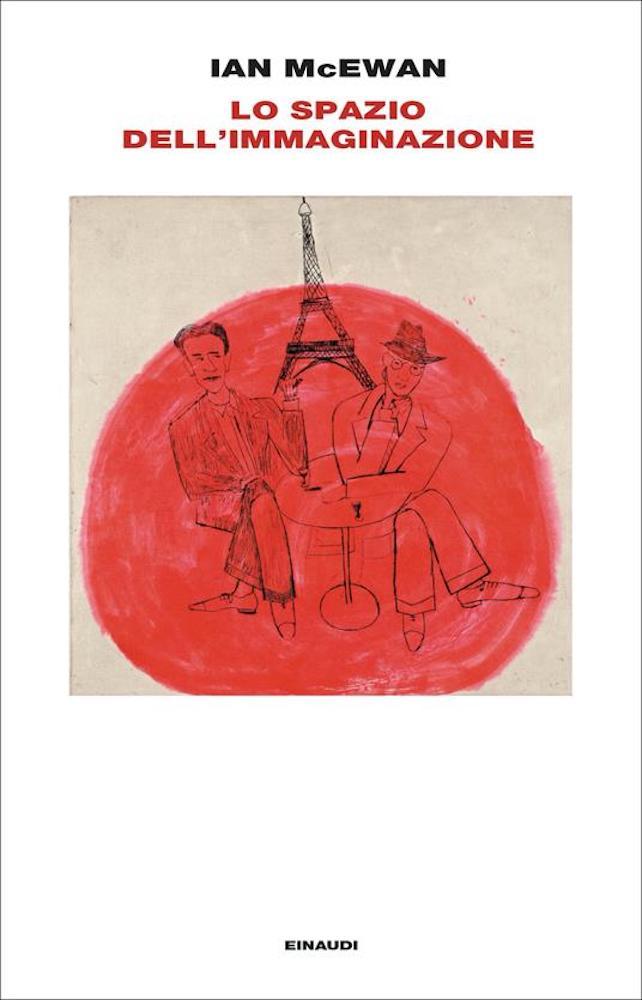
La prima riguarda l’origine stessa della nostra individuazione. È a quel livello, e nei primissimi tempi della nostra vita, che la capacità immaginativa, nel suo stesso formarsi, svolge una funzione costitutiva. La distinzione tra sé e non-sé si genera mediante illusione e finzione. Il rapporto tra gioco e realtà, tra pieno e vuoto, tra presenza e mancanza, crea un movimento che diviene la fonte dell’immaginazione ed è a sua volta originato dall’immaginazione. Il cervello motorio e i sistemi sensorimotori acquisiscono sempre più rilevanza, alla luce della ricerca, per comprendere le nostre capacità immaginative e creative e la stessa conoscenza. Allora non è tanto all’ente che bisogna guardare, cioè al solo mondo interno o al solo mondo esterno, per cercare di comprendere l’immaginazione, la creatività e l’esperienza estetica, ma al movimento tra gli enti e alla loro relazione.
Quando, per richiamare un riferimento essenziale, Winnicott parla della “distruzione della madre” da parte della bambina e del bambino, non sta parlando né solo del bambino né solo della madre, e tantomeno di una distruzione nel senso dell’annientamento. Sta parlando di una bambina e di un bambino che mentre possono godere dell’affidamento a una base sicura, la madre, grazie anche ai modi di muoversi e porsi di lei, riescono progressivamente a individuarsi riconoscendosi e affermando la propria autonomia, non contro la madre ma con lei.
Quello spazio intermedio prima ancora di essere una topologia esteriore è una contingenza ambigua e relazionale: apre estensioni di sé nella bambina, nel bambino e nella madre, che senza quella contingenza relazionale non si aprirebbero. Perché quella contingenza è ambigua? Lo è in quanto è irriducibile a uno degli enti: senza l’et-et non si verificherebbe e quando prevale l’aut-aut di solito finisce male o non tanto bene. È stato Vladimir Jankélévitch a sostenere che si può vivere senza ironia e senza amore ma mica tanto bene.
La contingenza di cui stiamo parlando non è una riduzione del determinismo degli eventi ad opera del caso. No, è piuttosto la situazione che emerge dal toccarsi insieme di tutte le componenti che in una certa relazione situata concorrono coevolutivamente all’emergere della vita, dell’individuazione, e dell’esperienza estetica e creativa, che dell’elaborazione di quel legame sono il frutto creaturale.
Ogni possibilità emerge quindi dall’immaginazione che in quella contingenza si sprigiona e la stessa immaginazione produce le condizioni della sua manifestazione. Una circolarità ricorsiva che se persistiamo a ragionare in termini, oserei dire, newtoniani, stentiamo a cogliere. Quando McEwan scrive, a p. 34, “ogni atto creativo contiene questo aspetto contingente”, sembra utilizzare la contingenza con un significato che richiama qualcosa di occasionale, secondario, passeggero. La contingenza che sottende ai processi evolutivi e all’emergere dell’immaginazione e della creatività richiede, per cercare di comprenderla, un’altra epistemologia.
Emilia Margoni ha recentemente fornito un’indicazione epistemologica di particolare importanza in questa direzione, quando, cerca di descrivere l’entanglement nei fenomeni fisici:
“…in un linguaggio insensibile al giustificato biasimo di tecnici ed esperti, (l’entanglement) si potrebbe descrivere come il fenomeno secondo cui due stati fisici, una volta sovrapposti, non si districano più l’uno dall’altro, e rimangono profondamente connessi a dispetto della mutua distanza: il loro comportamento mostrerà sorprendenti correlazioni, tali da violare gli interdetti della fisica classica e della concezione ordinaria di come funziona il mondo.
E così verrebbe la voglia di celebrare questo intreccio di enti avviluppati in relazioni reticolari, questo groviglio impartibile che sembra mettere in mora, una volta per tutte, l’idea miserrima e recentissima che il soggetto umano sia conchiuso nel perimetro del proprio corpo, dacché ogni sua particella è legata in modo insospettato a chissà quante particelle disposte nell’universo, se in fondo l’entanglement non rimanesse ancora un mistero.” [Nobel: fisica e azioni a distanza, 6 ottobre 2022]
Pur se l’entanglement rimane ancora un mistero, per la disperazione di Einstein e per la nostra, e ci pone ancora una volta di fronte ai limiti e alla fragilità del nostro sistema cervello-mente, pur senza voler creare improprie sovrapposizioni tra il comportamento elementare della materia e noi organismi di una diversa complessità, – fosse anche solo per via analogica e metaforica –, abbiamo un’indicazione epistemologica per cambiare paradigma interpretativo su come siamo fatti e come funzioniamo.
Ecco: se c’è una considerazione critica da fare riguardo al breve e prezioso testo di McEwan, questa riguarda un certo dualismo che sottende alla narrazione, mentre l’autore cerca di affrontare, insieme, i temi dell’immaginazione creativa e della responsabilità di chi scrive e produce opere d’arte.
Per tutto il testo è come se lo scrittore o l’artista dovessero scegliere tra stare chiusi in sé stessi e in un luogo che Orwell, molto considerato da McEwan, definisce Nel ventre della balena, o stare nel mondo e vedere la propria ispirazione e creatività asservite a qualche causa. Da un lato ci sarebbe l’impegno politico, dall’altro l’integrità estetica. Ma esiste un essere umano così? E l’esperienza estetica può essere ridotta all’individuale?
Sono domande enormi. Solo l’attrito della vita, come recita il titolo del libro che Lorenza Foschini ha dedicato a Renato Caccioppoli edito da La nave di Teseo, può in una certa misura dare conto dell’emergere dell’immaginazione e degli atti creativi. Un altro grande napoletano quell’attrito lo descrive da par suo, con grande efficacia: “Io so a memoria la miseria, e la miseria è il copione della vera comicità. Non si può far ridere se non si conoscono bene il dolore, la fame, il freddo, l’amore senza speranza, la disperazione della solitudine di certe squallide camerette ammobiliate, alla fine di una recita in un teatrucolo di provincia; e la vergogna dei pantaloni sfondati, il desiderio di un caffelatte, la prepotenza esosa degli impresari, la cattiveria del pubblico senza educazione. Insomma, non si può essere un vero attore comico senza aver fatto la guerra con la vita.” Così scrive il principe Antonio de Curtis, in arte Totò.

Nella scienza come nell’arte della commedia, nella poesia come nella musica, nella letteratura come nelle arti visive, vale quello che scrive Rachel Carlson nel contemplare la solitudine del lavoro creativo, dopo che i suoi libri ineguagliabili sul mare l’hanno resa una delle scrittrici più amate del suo tempo: "Se scrivi ciò che tu stessa pensi, senti e ti interessa sinceramente, creerai l’interesse delle altre persone”.
Non poteva saperlo mentre lo scriveva, ma in Europa un altro visionario stava traendo ispirazione dalla propria solitudine, proprio perché aveva imparato a sopportare la solitudine facendo non pochi progressi sulla strada della saggezza e della sensibilità rispetto al mondo. Era Escher, che ha trascorso la sua vita cercando di sopportare la solitudine del dono creativo, gloriosamente neuro-divergente, vagabondo negli enigmi, afflitto da una mania di associazione. Abitava però non solo la solitudine, Escher, ma un intermezzo o, come direbbe Alfonso M. Iacono, un mondo intermedio: era, secondo i critici, che non hanno quasi mai ragione, in due mondi come un estraneo a entrambi: troppo lirico per la scienza e troppo scientifico per la letteratura.
Proprio da quel luogo intermedio Escher scrive al figlio: “Continua ad essere un fatto profondamente triste e deludente che sto cominciando a parlare una lingua in questi giorni che solo pochissimi capiscono. Non fa che aumentare sempre di più la mia solitudine” [M. C. Escher’s, Letters to Canada, 1958-1972, ABC Art Books Canada Distribution, 2014].
La solitudine, insomma, può essere un esito, non una condizione o una premessa, nell’esperienza creativa. Come ha scritto Aldo Giorgio Gargani nell’incipit di Sguardo e destino, si scrive sempre a qualcuno e per un altro, e l’altro non è solo un destinatario, ma l’origine stessa e la fonte stessa della narrazione. Semplicemente perché siamo esseri intersoggettivi che nell’altro trovano l’altra metà del proprio cielo.
Nonostante tutta la sua solitudine, Escher lo riconosceva e si considerava anche incaricato di “stupore”.
Scrive Wislawa Szymborska: «è dallo stupore / che sorge il bisogno di parole/ e perciò ogni poesia/ si chiama Stupore».
Lo stupore, però, esige la presenza del mondo e di un altro che ci stupisce o si stupisce. Una violazione della presunta solitudine come alveo dell’esperienza creativa. Ciò non esclude la pura gioia che il lavoro creativo concede a chi riconosce nel proprio lavoro di essere sulla strada giusta. Così come, ancora una volta, non si tratta di scegliere tra passione ed esattezza quando si vuole cercare di comprendere l’emergere dell’immaginazione e della creatività.
Escher, nonostante tutta la sorprendente precisione matematica delle sue stampe, aveva combattuto con la matematica da giovane studente alla Scuola di ingegneria civile e arti decorative di Haarlem. Fu solo quando ascoltò le Variazioni Goldberg di Bach che la sua mente riconobbe il break-down del proprio dono: dare significato attraverso la forma. "Padre Bach", lo chiamò. Colpito dalla meraviglia della musica di Bach, dalle sue figure matematiche e dai motivi che si ripetono circolarmente, dalla maestosità di “un ritmo avvincente, una cadenza, alla ricerca di una certa interminabilità”, Escher sentiva in essa una coinvolgente affinità tra il canone nella musica polifonica e la divisione regolare di un piano in figure e forme identiche.
L’ibridazione di codici si propone come un’altra fonte generativa dell’immaginazione. Come è chiaramente documentato, nell’esperienza di Escher, quello che lo ha principalmente coinvolto in Bach è stata "l'infinita variazione di onde e ondulazioni" nella sua musica: parlava a qualcosa nella sua stessa anima che non si era ancora risvegliata. Di ibridazione in ibridazione, mentre un giorno viaggiava per l’Italia, ascoltando sua moglie che si spazzolava i capelli, a Escher venne in mente il rumore delle onde e fu improvvisamente sopraffatto da un intenso desiderio del mare.
L’atto di creazione non è un atto inerte ma frutto di un’intensificazione: quell’atto è sempre un atto di resistenza, come sostiene Deleuze. La creazione non ci compete: ci compete l’atto poetico, che libera una potenza. Quella potenza ha tutte le connotazioni dell’originario. In quella scena l’atto poetico, il fare creativo, a livello interiore, è una “potenza di” e una “potenza di non”. È avendo a che fare con le resistenze interiori e con l’elaborazione di un campo interiore in cui si può fare e non fare, è elaborando quel campo di tensione che può emergere l’atto poetico e creativo. Creare è portare dentro la possibilità di fare anche la possibilità di non fare, rispondendo alla tensione e all’urgenza di fare.
Erwin Schrödinger ha sostenuto che: “Il compito è… non tanto di vedere ciò che nessuno ha ancora visto; quanto di pensare ciò che nessuno ha ancora pensato, su ciò che tutti vedono”.
Escher e il mare ne sono una prova. In seguito a un viaggio dopo l'altro a bordo di navi mercantili, incantato dalle scie fluttuanti che la nave lasciava sull’acqua, disse al figlio: "Non incontri mai (o molto raramente) persone simili sulla terraferma". Fu proprio quella crescente ossessione a portare Escher verso The Sea Around Us di Rachel Carson, il libro lirico che le aveva fatto vincere il National Book Award nel 1951. Coinvolto dalla meraviglia per la sua scrittura, Escher scrive al figlio:
“Descrive quell’elemento liquido, con una panoramica di tutte le sue sfaccettature e problemi associati, in un modo così avvincente, con precisione e poesia, che mi sta facendo impazzire. Questo è esattamente il tipo di materiale di lettura di cui ho più bisogno, con l’avanzare degli anni: uno stimolo dalla nostra madre terra per la mia immaginazione spaziale... Sta accendendo in me un’intensa ispirazione per creare una nuova stampa”.
La scrittura poetica ma scientificamente deliziosa di Carson rendeva comprensibile la meraviglia del mare, dando a Escher un nuovo modo di pensare alla natura tridimensionale dello spazio che aveva sempre animato il suo lavoro e facendogli riflettere per la prima volta la quarta dimensione del tempo. Come Carson, che ha guardato l’oceano e ha visto in esso una lente sull’eternità e sul significato della vita, ora vedeva l’oceano come un antidoto alla caducità che segna le nostre vite: un balsamo incessante per la nostra terrorizzante incomprensione della finitezza del tempo, che è sempre in fondo un terrore della nostra stessa finitezza. Una generazione dopo che Virginia Woolf aveva contemplato la relazione tra solitudine e creatività, Carson le ha fatto eco: “Scrivere è nel migliore dei casi un’occupazione solitaria. Naturalmente ci sono relazioni stimolanti e persino felici con amici e colleghi, ma durante il vero lavoro di creazione lo scrittore si stacca da tutti gli altri e affronta il suo soggetto da solo. Si trasferisce in un regno dove non è mai stato prima, forse dove nessuno è mai stato. È un luogo solitario, anche un po’ spaventoso”.
In un sentimento che richiama alla mente il concetto di "insoddisfazione divina" della coreografa Martha Graham, che guida tutto il lavoro creativo, Carson aggiunge: “Nessuno scrittore può stare fermo. Continua a creare o muore. Ogni attività completata comporta il proprio obbligo di passare a qualcosa di nuovo”. E aggiunge: “I venti, il mare e le maree in movimento sono quello che sono. Se in essi c’è meraviglia, bellezza e maestosità, la scienza scoprirà queste qualità. Se non ci sono, la scienza non può crearli. Se c’è della poesia nel mio libro sul mare, non è perché l’ho messa lì apposta, ma perché nessuno potrebbe scrivere sinceramente sul mare e tralasciare la poesia” [Always, Rachel: The Letters of Rachel Carson and Dorothy Freeman, 1952-1964 - The Story of a Remarkable Friendship, Concord Library, Concord MA, 1996].
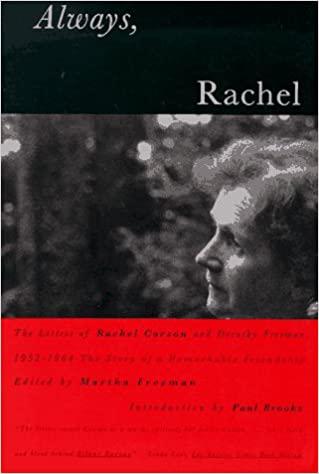
Come appare evidente, le “categorie del dentro e del fuori” nel processo immaginativo e creativo, come le definisce McEwan, sono circolari e possono anche invertirsi, ma si propone come poroso il posto dell’immaginazione in cui “rifugiarsi per dettare le proprie condizioni e creare nuove forme di bellezza, nuove visioni, nuove rotture” [McEwan, p. 44]. Quella porosità lo stesso McEwan la riconosce quando scrive che “trarre piacere dal suono di una rana che si tuffa in uno stagno non significa negare (corsivo nel testo) che la rana è a rischio di estinzione o che lo stagno potrebbe prosciugarsi con la prossima siccità o sparire sotto l’aggressione di colture chimiche industriali” [p. 45].
Nel suo fitto dialogo con Orwell, James, Camus, Calvino e molti altri convocati nel confronto, McEwan, pur non risolvendo e non volendo risolvere una questione in fondo indecidibile, finisce per riconoscere la circolarità ambigua da cui si sprigiona il processo immaginativo e creativo. Emerge che chi crea non dovrebbe mai tentare di imporsi sul proprio soggetto. Non dovrebbe cercare di modellarlo secondo ciò che crede che i suoi lettori, editori o fruitori vogliono. Il suo compito iniziale è quello di conoscere intimamente la sua materia, di comprenderne ogni aspetto, di lasciarsi riempire la mente. Allo stesso tempo e coevolutivamente chi crea prende il comando e dà vita al vero atto della creazione...
La disciplina di chi crea è imparare a stare fermo e ascoltare ciò che il soggetto ha da dirgli. Al centro del processo immaginativo e creativo sta forse una complessità che riguarda l’essere, colei o colui che crea: quasi solo uno strumento attraverso il quale succede qualcosa, che ha, in fondo, poco a che fare con il creatore stesso. La solitudine di quest’ultimo è alleviata dall’amore per l’oggetto della creazione in una misura indefinibile, mentre si muove tra l’obbligo e il dettato che sente dentro, il proprio idealismo implacabile e il realismo più potente.







