Sfidare il linguaggio / Clarice Lispector. La parola materica
“È con un’allegria così profonda. È un tale alleluia” (9). L’inizio è allegro, e il canale aperto è quello del desiderio, in un perimetro senza tempo né forma: c’è solo la materia, quella ruvida del tocco, dello slittamento, dell’attraversamento di faglie scoscese. Il libro di Clarice Lispector, Acqua Viva (1973), tradotto in italiano e pubblicato per la prima volta da Adelphi nel 2017, incede per movimenti progressivi che sgretolano la funzione significante della parola e celebrano l’eulogia del suo effetto materico. Acqua Viva è un corpo a corpo con la parola, da una posizione sofferta e obliqua, che della parola mostra la relazione con il corpo e il tatto, anziché il segno e il significato. È per questo che, in una delle prime mosse audaci di questa lotta energica, Lispector sconfessa il rapporto di privilegio tra parola e udito: “Mi accorgo che non ti ho mai detto come ascolto la musica… appoggio leggermente la mano sul giradischi e la mano vibra trasmettendo onde a tutto il corpo” (11). L’udito, creduto a lungo il destinatario d’elezione della parola, è la prima delle vittime designate, che lascia il passo a un sentire tutto corporeo – un corpo che è campo di vibrazioni, “sostrato ultimo nel dominio della realtà” (11).
Sin dalle prime righe, Acqua viva rifiuta ogni inclinazione narrativa e ci guida per sentieri, interrotti di continuo, in cui ciò che si legge è “pura vibrazione senza significato se non quello di ogni sillaba sillabante” (11). Il significato germoglia e si consuma per intero nell’allitterazione dei “si”: non c’è altro dietro la parola se non l’effetto materiale sul corpo di chi, toccando, ascolta ed è toccato. È come se in un passaggio di due righe Lispector intendesse chiudere la gigantomachia tra la filosofia del Novecento, figlia di quella “svolta linguistica” per cui il mondo non è se non per come è detto attraverso il linguaggio umano, e più antiche filosofie della materia, che le autrici del nuovo materialismo, come ad esempio Jane Bennett e Karen Barad, collegano a una genealogia incerta e frammentaria, in cui figurano Lucrezio, Spinoza eThoreau.
Ma l’intransigenza di Lispector è ammirevole e la sua integrità teorica spiazzante: ella sa che non può usare la parola per dire senza con ciò cadere nella contraddizione tipica di chi crede di poter mettere in mora il linguaggio attraverso il linguaggio. Piuttosto, Lispector si sottrae in diagonale alla trappola della contraddizione: “Non è confortevole ciò che ti scrivo. Non faccio confidenze. Piuttosto mi metallizzo. […] la mia parola schiocca nello spazio del giorno” (17). La parola è quindi “puro presente”, suono istantaneo e metallico, che non vuole sedimentarsi, non cerca veicoli, non si incarna in segni. È quel che c’è ora e che vive di una relazione d’indifferenza con passato e futuro: “Che io dica ‘ho vissuto’ o ‘vivrò’, è presente perché lo dico adesso” (19).
La parola di Lispector, però, non è mai insipida. Ha un “gusto”: ci invita a un’esperienza aptica, umida, visiva. La persona che nel libro parla, la cui identità non ci è nota, dice di aver scelto la parola perché il suo interlocutore la sua pittura non l’ha mai capita. S’è quindi risoluta a un mezzo – la parola appunto – apparentemente meno ambiguo. Tuttavia, colei che parla non rinuncia all’inclinazione materica della pittrice che sceglie i colori con gli occhi, le dita, il naso: tratta la parola come incisione su tela, la composizione tra parole come improvvisazione jazz, i suoi effetti come intrichi di gambe e braccia, i suoi tempi come il tic tac dell’orologio che condensa passato e futuro nell’istante. E allora il percorso che riconduce la parola alla materia è compiuto: i segni sono “più un gesto che una voce”, in un esercizio che non dice ciò che accade, ma semplicemente accade. Non è compito facile: si avverte l’affanno e il polso accelerato di chi parla dinanzi allo sforzo titanico che si richiede per affrancare la parola dal suo asservimento alla voce e al significato: “Capiscimi: ti scrivo un’onomatopea, convulsione del linguaggio. Ti trasmetto non una storia ma soltanto parole che vivono del suono” (27). Il compito non è facile non solo perché Lispector si avventura per la rotta obliqua di un parlare che sfida il linguaggio, ma per i costi che tale scelta comporta: se la parola è evento colorato, vibrante, corporeo, essa non ammette ripensamenti: “Non mi piace quello che ho appena scritto… ma sono obbligata ad accettare tutto il brano perché mi è accaduto” (29). Eppure solo questa presa d’atto consente il movimento sussultorio del ripiegamento che sfida la natura non riflessiva del verbo essere e ne rivendica pieno possesso: “Mi sono” (30).
Sorprende la forza teorica della posizione – appunto obliqua e resistente – da cui Lispector opera un taglio così radicale con la concezione convenzionale della parola. Nella prefazione alla versione inglese, Hélène Cixous mette in risalto l’insoddisfazione di Lispector riguardo dell’“impossibilità che il linguaggio sia adeguato all’oggetto” (xv). Mentre Gertrude Stein, scrive Cixous, reagisce a tale impossibilità attraverso un iperlinguismo ossessivo (“a rose is a rose is a rose is a rose”), Lispector s’inerpica per un tracciato più angusto e macchinoso: descrivere tutto, descrivere la rosa, descrivere ogni rosa. Ha ragione Cixous; eppure non poteva cogliere la forza anticipatrice della soluzione di Lispector: un materialismo vibrante e tattile, che ricorda da vicino quel chein filosofia sociale va oggi sotto il nome di “ontologia materialista”(in un filo di derivazione che porta da Bruno Latour a Ian Bogost) e che, come Lispector, prende atto senza reticenze dell’impossibilità che linguaggio sia adeguato al mondo.
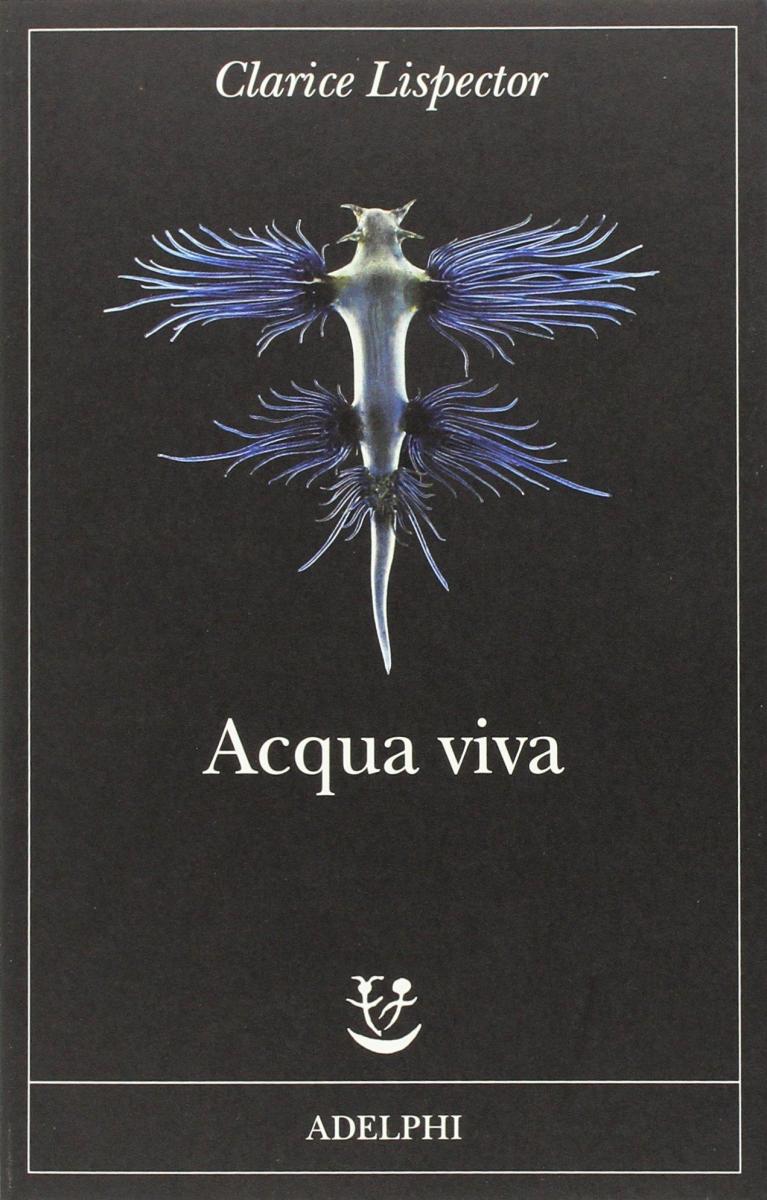
I tratti di unione con l’ontologia materialista sono evidenti: questa prende le mosse dall’idea che il linguaggio umano non fa da filtro al mondo, che il secondo è indipendente dal primo, che tutte le cose (animate e inanimate) sono connesse tra loro e al contempo indipendenti le une dalle altre, che le cose, connesse e indipendenti, si uniscono in “qui e ora” transitori (quelli che Latour, seguendo Deleuze, chiama “assemblaggi”). L’ontologia materialista, quale attitudine filosofica, si auto-attribuisce il compito di mostrare che l’essere umano (forse in tal caso sarebbe più appropriato dire “l’uomo”), che a lungo ha creduto di avere primazia sul mondo quale detentore del potere magico-rituale di attribuire parole alle cose, non è che parte degli assemblaggi caotici che il linguaggio umano non può mai abbracciare in descrizioni complete (se non a prezzo di travisamenti e semplificazioni). La realtà si compone di “eventi”, scrive Bennett, “incontri tra attanti ontologicamente diversi, alcuni umani, altri no, quantunque tutti pienamente materiali” (xiv). Pertanto il linguaggio, nell’ontologia materialista, non può che rinunciare alla sua tendenza definitoria e alla sua sete di proprietà sulle cose. L’invito è quello a rimettere al centro le cose in forza dell’effetto di sottrazione implicito nella rinuncia al dominio linguistico sul mondo: “[G]li essere umani sono elementi” – scrive Bogost – in un quadro in cui “tutto esiste allo stesso modo – idraulici, cotone, bonobo, DVD players, arenaria” (6).
È come se l’ontologia materialista trovasse espressione anticipatoria nel corpo a corpo con la parola mediante cui Lispector si sottrae all’inadeguatezza del linguaggio. L’intera ontologia materialista può infatti condensarsi in tre slittamenti, che si ritrovano nelle pagine di Acqua viva. Primo slittamento: la parola non dice né racconta, ma si dà come cosa che esiste tra le cose: “Ciò che ti scrivo non è da leggere… è da essere” (37). Lispector entra “in modo furtivo” (47) in contatto con cose che non trovano corrispondenza in pensieri e parole che conferiscano loro identità riconoscibili. Per quanto la parola stabilizzi il significato delle cose, queste rifuggono ogni esercizio di stabilità. È per questo che, in fin dei conti, la parola è l’effetto di realtà che si determina nella contingenza sensuale dell’incontro tra suono e vibrazione. Secondo slittamento: la realtà, che sempre sfugge alla parola, non se ne sta inerte nell’opaco del non-detto, ma trasuda vita: “Come respira l’ostrica nuda? Se respira, non lo vedo. Quel che non vedo non esiste? La cosa che mi emoziona è che ciò che non vedo esiste lo stesso. Perché così ho ai miei piedi tutto un mondo sconosciuto che esiste pieno e denso di ricca saliva”. Terzo slittamento: l’accesso al mondo richiede descrizioni minuziose, ed è per questo che il mondo di Acqua viva è un transito incessante di attori d’ogni fatta: aria, stalattiti, fossili, pietre, nebbie, ragni lanuginosi e neri, scarafaggi, cavalli bradi, alba azzurrata che viene col ventre pieno di uccellini, frutti rosicchiati da vermi, farfalle, fiori di campo nati senza essere stati piantati e api che se ne occupano, garofani, margherite, orchidee, tulipani, angelica, gelsomino, strelitzie, belle di notte: un tripudio di attori che compongono scene mai ricomposte in totalità ordinate. Il mondo si dà come “storia di istanti che fuggono come i sentieri in fuga che si vedono dal finestrino del treno” (73).
Stupisce assai poco, quindi, che Lispector ricalchi, anticipandolo, il monito metodologico di Latour. L’unica via d’accesso al mondo è la scienza del particolare: offrire un ritratto dei dettagli minuti che si ottengono seguendo i movimenti, anch’essi minuti, degli attori animati e inanimati che lo compongono, e farlo con umiltà, come una formica (“ant” in inglese, termine con cui Latour allude alla disposizione etnografica dell’Actor-Network Theory). Scrive Lispector: “Registrare l’ovvio fa parte del lavoro. Nella piccola formica è contenuto tutto un mondo che mi sfugge se non me ne prendo cura” (61). Occorre prendersi cura dei particolari seguendone le tracce, accostandovisi, senza pretendere di dire cosa siano e perché fanno quel che fanno: “La parola pesca quel che non è parola. Quando la non-parola – quello che è fra le righe – abbocca, qualcosa è stato scritto. Una volta che si è pescato quel che è fra le righe, ci si potrebbe sbarazzare con sollievo della parola. Ma lì finisce l’analogia: la non-parola, abboccando, ha incorporato l’esca. L’unica soluzione allora è scrivere distrattamente” (21-22).
Qui il trionfo dell’oggetto sulla parola: questa, che porta a sé l’oggetto, ne viene divorata; sicché non si può che rinunciare alla parola come strumento di dominio, e intendere lo scritto come un esercizio forzato e cosciente di serendipità: lasciarsi incuriosire dalle cose, per venire presto distratti da altre, prima che l’oggetto si appropri del nostro dire e se ne ricavi una ferita incurabile.
Nota di lettura
La felice traduzione italiana di Acqua viva è di Roberto Francavilla. Il riferimento a Cixous è dalla sua Foreword all’edizione inglese del testo di Lispector, The Stream of Life (University of Minnesota Press, 1989). La citazione di Bennett si riferisce a VibrantMatter (Duke University Press, 2010); quella di Bogost a Alien Phenomenology, or What It’s Like to Be a Thing (University of Minnesota Press, 2010). La migliore introduzione all’Actor-Network Theory è forse proprio il libro di Latour Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford University Press, 2005). Oltre a Cixous (cfr. ad esempio “Coming to Writing” and Other Essays, Harvard University Press, 1991), autrici come Rosi Braidotti (cfr. In metamorfosi: verso una teoria materialista del divenire, tr. it. M. Nadotti, Feltrinelli, 2002), Adriana Cavarero (cfr. A più voci: filosofia dell’espressione vocale, Feltrinelli 2003) e Luisa Muraro (Tre Lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, Orthotes 2011) hanno trovato in Lispector una forma di scrittura che transita per il corpo e su esso si esercita con effetti che eccedono la parola. Oltre ad Acqua viva, autrici e autori interessati a questi aspetti guardano in particolare a La passione secondo G.H. (tr. it. A. Aletti, Feltrinelli, 1991). Una lettura dello stile di Lispector che si avvicina a quello offerto in questo scritto si trova in Mattia Kärrholm, The Animistic Moment: Clarice Lispector, Louis Kahn and the Reassembling of Materialities, “Lo Squaderno”, 39, 2016, pp. 71-77.







