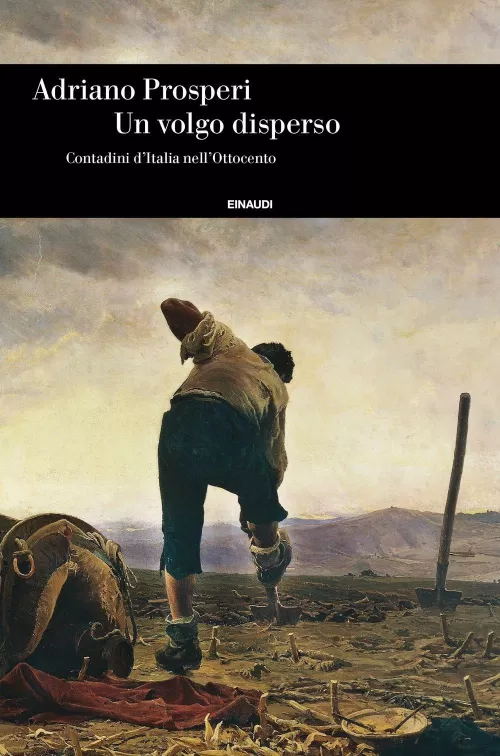Un volgo disperso / Contadini
Ho letto il libro di Adriano Prosperi (Un volgo disperso, Einaudi 2019, pp. 324) impiegandoci molto tempo perché ogni pagina mi sembrava degna di sottolineature, ogni citazione dalle relazioni dei medici, statistici o antropologi degna di nota, e soprattutto mi mettevo a ricordare. Il mezzadro che viveva nella casa accanto alla mia: aveva al piano terra la cucina in cui ovviamente c'era il focolare, una madia dove si faceva all'occorrenza la pasta per il pane e comunque si riponevano i cibi, e la macchina da cucire alla quale lavorava la figlia che faceva impermeabili per una ditta di confezioni di Empoli. (Aveva anche un figlio che rimase allettato per molto tempo per una malattia che fu diagnosticata come leucemia, e che io ho visto forse due volte.) Dalla cucina si andava in una cantina, sempre al piano terra, dove era depositata una parte degli attrezzi di uso più comune più il trinciaforaggi per le due mucche che stavano nella stalla, sempre sul retro. Due camere erano al piano superiore della casa. Le due mucche stavano distese sulla paglia che veniva presa da un pagliaio posto una trentina di metri dietro la casa. Lo sterco delle mucche misto alla paglia veniva accumulato vicino al pagliaio e il cumulo si chiamava “concio”, cioè concime, che veniva caricato nei momenti opportuni sul carro e sparso nei campi. A una trentina di metri dalla casa c'era il pozzo al quale attingevano – e questo è già un segno di precarie condizioni igieniche – quattro famiglie compresa la mia. Davanti alla casa c'erano quattro orti, fra cui quello del mezzadro e il nostro. Sul dietro c'era un fienile che al piano basso aveva: il trogolo (così si chiamava), cioè una bassissima costruzione per il maiale, una stanza che fungeva da cantina con la botte in cui il mezzadro metteva il vino che gli spettava dopo la ripartizione col padrone (cioè sei padroni, ma tutto per la nostra povertà veniva lasciato a mio padre e alla nonna dagli altri suoi fratelli), il ricovero per il carro e, al primo piano, il fienile. La tinaia, dove l'uva veniva spremuta, faceva corpo con la casa padronale.
Il gabinetto del mezzadro era, come quello di tutti gli abitanti, una minuscola costruzione aggettante dove c'era soltanto il WC. Non c'erano condutture d'acqua in nessuna casa, e per lavarsi c'era la catinella in camera e il bidé, entrambi di metallo smaltato, e tutti si lavavano con l'acqua tirata su col secchio dal pozzo comune. Gli escrementi andavano attraverso un tubo in un serbatoio chiuso (di mattoni? di cemento?) che si apriva al piano terra, che era ovviamente sempre chiuso e che, quando era colmo, veniva “ricavato”; non ricordo più da chi, né che fine facesse (sparso nei campi?). Ogni casa – quattro erano attaccate l'una all'altra – aveva il suo deposito escrementizio. Anche il pozzo veniva, ogni certo numero di anni, ricavato: si toglieva tutta l'acqua, si tiravano su le pietre scurite e sporche che giacevano sul fondo, le si lavavano con l'acqua estratta prima e poi erano calate ancora sul fondo del pozzo. Dalla falda l'acqua cominciava lentamente a riempirlo.
Il contadino vendeva tutto il vino che era suo e beveva in sostituzione l'acquetta. Questo ci porta alle ricerche di Prosperi: acquetta, acquerella e simili sono i termini usati in varie parti d'Italia per questo prodotto. Lo si produceva versando acqua nelle vinacce, cioè in quello che restava nello strettoio dopo la spremitura dell'uva. Dopo non so quanto tempo, forse quello che bastava al liquido per calare al fondo, il contadino lo attingeva e lo beveva. Era un liquido di colore rosa, cattivo e malsano perché la vinaccia era diventata acida, e faceva male allo stomaco. Nell'Ottocento, secolo del quale si occupa Prosperi, in varie parti d'Italia i contadini la bevevano, in molti luoghi bevevano acqua malsana soltanto; erano rari i casi di chi si poteva concedere di bere il vino. Siamo il paese del vino e dell’olio. Il vino, come si è visto, il mezzadro non lo beveva perché lo vendeva.

La sua casa – mi riferisco agli anni quaranta e cinquanta naturalmente del Novecento – era una reggia se confrontata con quelle dei contadini dell’Ottocento di cui Prosperi si occupa. Contadini è un termine che risulta anche generico data la grande varietà di lavoratori agricoli: mezzadri, ma anche bovari fittavoli braccianti, salariati in vario modo e così via. La casa, dicevo, era comunque abitabile. L’orrore viene da quanto Prosperi ci offre traendolo dalle relazioni di medici e vari esploratori (è il caso di usare questo termine) nel continente tremendo dell’Italia agricola. Sia a nord che a sud le case erano fatte spesso di fango e paglia, non avevano pavimento ma solo si calpestava nuda terra, non avevano finestre, né impannate, e uomini e donne vivevano tutti insieme – adulti e bambini – in compagnia degli animali: polli, conigli, maiale se c’era, e così via. Si dormiva, come si diceva anche noi, “da capo e da piedi”, cioè alternativamente uno con la testa su un punto del giaciglio e quello accanto – per mancanza di spazio – coi piedi all’altezza della sua testa; e il terzo ancora con la testa dove erano i piedi del secondo e così via. La casa (chiamiamola così) a volte era divisa in due parti, in una abitavano gli umani e nell’altra gli animali. La parete era di paglia impastata col fango e in certe zone d’Italia con lo sterco vaccino (e quando le mucche non c’erano?). Nessuno si lavava se non in alcune zone e per le feste. La stanza era invasa da sudiciume e lordure varie: il “succidume”, insieme ai miasmi e all’acqua inquinata, è sempre al primo posto nelle denunce dei medici condotti che conoscevano bene queste realtà. Durante l’inverno si dormiva nella stalla, nel puzzo degli escrementi degli animali per proteggersi dal freddo. E nelle zone fredde questo durava almeno sei mesi.
Un tanfo feroce, un’aria malsana di ambienti chiusi, mai aereati se non quando la stagione lo consentisse, regnavano sovrani. Si defecava e orinava fuori delle abitazioni e vicino ad esse, o si lanciavano le feci fuori dalla finestra tanto più nei villaggi. Nel 1884 il dottor Ledda, sardo, segnalava che le case di Sanluri erano “di modesto aspetto”, ma in generale piuttosto vaste, comode e pulite”. C’erano inoltre quelle dei “poveri” (come fossero un’altra razza!) “senza pavimento di sorta, ma hanno un intonaco formato di sterco di bue, impastato col fior di paglia, che rifanno almeno una volta all’anno” (p. 240). E meno male! Ledda registrava naturalmente la rivolta popolare del 1881 contro le vessazioni fiscali del governo; i carabinieri spararono sulla folla senza avvisare i manifestanti coi tre squilli di tromba prescritti (ironia involontaria). In molte zone del Sud Italia i contadini vivevano in grotte di tufo in compagnia del maiale. Si beveva acqua che non era acqua pura, ma anch’essa malsana che proveniva da scoli, da canali e fossi vicini. E il cibo? Quel grande intellettuale che fu l’abate Melchiorre Gioia s’impegnò ai primi dell’Ottocento nella redazione di una statistica per il Regno italico, ricerca che altri estesero nel Sud murattiano. Basti questo per la zona dell’Adda: i contadini mangiavano “Il fieno selvatico cotto e condito con un poco di sale nella primavera; i semi d’uva triturati e misti al granoturco per fare pane; la pannocchia di grano-turco macinata col grano; la semola ricercata dai paesani agli abitanti de’ borghi per farne pane” (p. 35); e poi molte famiglie usavano una stessa caldaia per cuocere la polenta, ma le lastre d’ardesia erano vendute in aprile per ricavarne qualche soldo; in più le caldaie venivano pignorate, con le catene che le sorreggevano, dai sindaci che non riuscivano a farsi pagare le imposte dai contadini.
In Terra d’Otranto si poteva mangiare bue, vitella, castrato, agnello, capretto, porco, capra e pecora. Bella vita! Solo che non era questo il cibo dei contadini, che si dovevano accontentare di mangiare carne 4 o 5 volte all’anno e per il resto solo pane d’orzo o di frumento. La carne si mangiava se moriva il cavallo che li aiutava nei campi; e si può immaginare con quale danno e disperazione. E siccome siamo il paese non solo del vino ma anche dell’olio, si noterà che i contadini spesso condivano con un orribile e guasto olio di colza o di altri semi; coglievano le spighe del granturco quando non erano ancora mature e poi le conservavano nelle loro case umide e le mangiavano nel corso del tempo quando erano ammuffite. In Lombardia morivano di fame e pellagra, in Sicilia “vivevano quasi come le piante”, come le loro “bestie da soma” (Inchiesta di Agostino Bertani, p. 278). L’inchiesta di Franchetti registra la morte di contadini abruzzesi per fame in strade e piazze della città di Pescara. In alcune prigioni i vivi convivevano per un bel po’ coi morti, come nei campi profughi oggi della Libia.

E in questo elenco tragico si può continuare all’infinito, aggiungendo alla terribile pellagra il tifo, le cicliche epidemie di colera che generalmente seguivano una carestia, la tubercolosi, il rachitismo, la malaria. Da aggiungere che eventuali attacchi di polmoniti e appendicite non lasciavano scampo: in una zona del Padule di Fucecchio poteva capitare (come dovunque) che si morisse del “mal del vorgolo”, cioè un attacco lancinante di appendicite che prima della morte faceva sì che il malato si avvolgesse su se stesso dal dolore. La mortalità infantile era altissima, superiore in numero quella delle femmine a quella dei maschi; frequenti gli aborti e le morti dei neonati, il che fa venire il dubbio che in alcune famiglie si preferisse che le femmine non vivessero. Non che le donne non lavorassero. Anzi! Lo facevano al punto che ne risentivano le gravidanze e loro stesse. Se non aiutavano in casa erano mandate a mendicare, o a servizio. Mia madre, figlia di contadini della zona del Padule di Fucecchio fu mandata a sedici anni (1926) a servizio a Firenze; e di quel periodo mi ricordava soprattutto il suo terribile scarso dormire perché era l’ultima a ritirarsi e la prima ad alzarsi. Aveva fatto la terza elementare, scriveva lettere bellissime con errori d’ortografia ai parenti quando c’era bisogno che ci aiutassero. Sapeva fare le maglie, la rete per catturare i pesci, sapeva cucire bene a mano e a macchina. Come moglie del “padrone” le spettava, ironia del destino, il titolo reverenziale di “padrona”.
Il titolo del libro di Prosperi è manzoniano e lo stesso Manzoni è ricordato per la sua attenzione all’“immensa moltitudine d’uomini […] che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata senza lasciarci traccia”. Se si ricordano gli scrittori e il mondo contadino o anche i poveri dei bassi napoletani i primi non ci fanno bella figura. Prosperi accenna al Fucini di Napoli a occhio nudo che quasi non li vede, mentre Villari li vede eccome nella loro sconfinata miseria. Neanche Carducci ci fa bella figura: la “bionda Maria” di Idillio maremmano, poppe solide e “fianco baldanzoso” che premono da sotto la camicia e leopardianamente reduce dai campi con un mazzo di fiori, è in chiave con la rappresentazione oleografica dei nostri macchiaioli. Né va dimenticato che al suo passare il pavone faceva la ruota, che i due figli gli pendevano dalle poppe e che, una volta cresciuti, saltavano fieri in groppa ai cavalli. Era una rappresentazione dalla parte del vincitore. Ora questo libro, da cui ho attinto qua e là, illustra la rappresentazione dei contadini che fu nell’Ottocento conflittuale fra due tipi di intellettuali: i parroci e i medici condotti. I primi volti sostanzialmente alla cura dell’anima dei disgraziati cercando di render loro accettabile la violenza di questa vita; i secondi attenti a illustrare le loro condizioni, spesso con durezza, sapienza e coraggio. Prosperi fa un sacco di nomi di questi personaggi, attivi sia prima della formazione dello stato unitario che dopo. Io ho ricordato il solo, straordinario, Agostino Bertani, ma il libro esibisce documenti su documenti (cioè relazioni e relazioni) che disegnano in varie epoche la mappa della situazione igienico-sanitaria delle campagne per essere elaborati dalle istituzioni centrali in dati statistici. Ci furono anche letture aberranti: i rachitici, i pellagrosi affetti da cretinismo, i bassi di statura per l’enorme fatica durata e per i pesi trasportati fin da bambini, i lavoratori idiotizzati dalla scarsa alimentazione, i rugosi prima dell’età delle rughe offrirono materiale al Lombroso per definirli tutti complessivamente come una “razza” a sé. Un intellettuale in fondo è contento se può definire credendo di aver conosciuto il suo materiale di lavoro. E la cosa era fatta. Ma nelle campagne, per varie vie che non si sta qui a ricordare ma che Prosperi disegna molto bene, cominciarono a mettersi in testa strane idee da cui i ricchi dovevano difendersi: “La Boje” fu il bel titolo di un giornale socialista del basso Veneto negli anni Ottanta dell’Ottocento. Comunque i contadini furono considerati dalla nostra classe dirigente solo carne da cannone, come si vide nella prima guerra mondiale che fu il più grande macello proletario di tutti i tempi in Italia.
Prosperi è uno dei grandi storici dei nostri tempi perché in tutti i suoi libri rivela delle idee straordinarie, che sono tali quando reinterpretano dati magari in parte già visti da altri. E questo accade quando lo studioso ha un’idea vera su quali siano i diritti degli uomini tutti in una società qualsiasi. Finora gli studi sull’agricoltura dell’Ottocento si erano concentrati soprattutto sugli ammodernamenti delle tecniche agricole, sul rapporto campagna-industria, sulle trasformazioni regionali dei contratti di lavoro. Nel libro di Prosperi invece l’oggetto è l’uomo, chi era, come viveva, quanto viveva (pochissimo), a che età cominciava a lavorare, che cos’era la vendita dei bambini da parte delle famiglie che ne avevano e non potevano sfamarli se non morivano piccoli. E quale fu la rapacità nei loro confronti da parte dei ricchi che continuarono a governare pur nello stato unitario, che li tempestava di tasse e fece in modo che i beni confiscati alla chiesa finissero non in una riforma agraria ma ingrandissero i latifondi.
Il risultato dell’ammodernamento produttivo fu quanto registrava Agostino Bertani nell’Inchiesta da lui promossa e di cui non fece in tempo a vedere i risultati stampati: quanto più «le terre coltivate erano estese, ricche e redditizie, proprio là c’era “maggiore miseria rurale e miseria perfino nell’animo angustiato e avvilito che non sa e non può tentare la risorsa disperata dell’emigrazione”» (p. 289). Di fronte a questa situazione o ci si fa incantare dalle terre “ricche e redditizie” e dal bel paesaggio, o ci si pone il problema di chi vi lavorava. Prosperi segue questa strada dimenticata. Un grazie a lui per avercela raccontata. E se si vedono alla televisione servizi sui migranti africani che raccolgono i pomodori dall’alba al tramonto nel Sud Italia, le mele nel Nord, la frutta nel Centro, e che dormono in capanne che i proprietari del fondo gli affittano detraendo loro qualcosa da una paga miserabile, beh! sono quelli che hanno sostituito i contadini di un tempo.
Leggi anche:
Maurizio Sentieri, I contadini, villani, terroni che siamo stati