Cereda, Parrella, Cappagli / Tre uscite dalla solitudine
Paola Cereda. Quella metà di noi
Matilde Mezzalama è un’ex insegnante in pensione, vedova, con una figlia poco presente, due nipoti che vede solo durante le feste comandate e un segreto che le affatica la parola, le riposa in bocca e toglie forza e decisione al suo parlare.
Il mistero di un peccato indicibile affiora fin dalle prime pagine del romanzo di Paola Cereda e si intuisce che si annidi proprio lì la ragione per cui, dopo una vita passata a scuola, tra lezioni e orto didattico, a far crescere piante e persone, Matilde si ritrovi ad accudire, in qualità di badante, le memorie sconclusionate di un ex dirigente Fiat.
L’ingegner Dutto ha comandato, lavorato e viaggiato a lungo, ha vissuto in India e in Brasile inseguendo affari e seduzioni, adesso l’ictus lo schiaccia su una sedia a rotelle, arreso e solo, con i “fantasmi nella testa e un continuo disordine dei sentimenti”.
In una Torino piena di confini Matilde abita una terra di mezzo, divisa tra lingue, case, decisioni sospese, e nella strada che va dal suo appartamento tra i palazzi di Barriera di Milano e le eleganti stanze dell’ingegnere in pieno centro, fa il conto di ciò che rimane una volta persi sogni e risparmi per un segreto che non si può dire e un desiderio lasciato appassire.
“Come sarebbe bello desiderare come desiderano i bambini” si dice Matilde, ma il desiderio, soprattutto sulle labbra delle donne, ha spesso il sentore insopportabile della colpa, che paralizza e scava un confine bruciato difficile da attraversare.
“Di tutti gli errori quelli più irreversibili c’entrano con le parole non pronunciate”, scrive la Cereda mentre descrive il decorso di una vita che da quel confine fa ritorno, tanto colpevole di aver desiderato quanto di non aver ceduto al desiderio e d’essere infine rimasta incastrata tra due storie, senza errori di cui pentirsi e senza più verità da raccontare.
Senza scelte non ci sono storie, e per ricominciare Matilde diventa badante, entra in una casa sconosciuta e inizia la sua vita da capo. Prendendosi cura della vita disarmata dell’ingegnere impara di nuovo a comunicare, una lingua nuova, un alfabeto di gesti, di corpi, di vuoti, un codice di segnali incerti, che impone di sviluppare una particolare attenzione all’altro, di colmare lacune, di lenire mancanze. Per muoversi senza inciampi nella “geografia antropologica dei lavori di cura” è necessario prendere il passo di chi si accompagna, sostenere la vicinanza dei reciproci corpi, difetti, dolori.
“Quella metà di noi” che si legge tra le pagine del libro, nell’attrito dei rapporti tra i personaggi e nelle loro solitudini scomode, è la parte delle nostre esistenze che non ci appartiene del tutto, che ci tiene in qualche modo legati ad altre vite, quelle altrui e le nostre, che non abbiamo vissuto. E la scrittura della Cereda funziona soprattutto quando indugia sui modi che le persone trovano per fronteggiare la parte di sé che si riflette nell’altro, per raccontarsi la distanza tra la propria vita e il proprio desiderio.
Nella difficoltà del dire a se stessi questo fallimento, prima ancora del trovare le parole per condividerlo, sta forse il punto più interessante del romanzo e forse anche per questo il finale appare meno potente; le aporie e i segreti, una volta detti, perdono forza e possibilità, contaminati dalla banalità delle cose note, delle vite di tutti.

Valeria Parrella. Almarina
Elisabetta Maiorano con la protagonista di Quella metà di noi condivide la professione di insegnante e una vedovanza sofferta e infestata da ricordi e mancanze.
La protagonista di Almarina insegna nel carcere minorile di Nisida, in una Napoli spietata “che sa dare il giusto peso alla morte, quello della vita, cioè quasi nulla”. Nisida però è un mondo a parte, un vascello fantasma che galleggia al largo della città dove la realtà è sospesa, lasciata fuori (“mollo gli ormeggi di quella vita di usura che mi è capitata…. come ciascuno che entri a Nisida torno libera, torno bambina”); per questo, mentre entra, Elisabetta ripete tra sé il proprio nome, aggrappandosi a un’identità che vacilla nell’attraversare il varco d’ingresso al carcere, che come ogni soglia segna anche un confine e qualcosa da abbandonare.
Elisabetta lascia nell’armadietto il cellulare che la lega alle voci e alle persone all’esterno, e dentro Nisida rimane sola. Il carcere è fatto di gironi danteschi e affiliazioni fondate sulla colpa da espiare, i detenuti la osservano e “chi guarda ingaggia sempre una partita”, così lei deve continuamente riposizionarsi al loro sguardo, essere competente, autorevole, intera, non sbagliare la manovra con l’auto all’ingresso, non sbagliare il trucco, i capelli, perché deve essere scrutata dagli alunni, riconosciuta dalle femmine, rispettata dai maschi. Tra di loro c’è anche Almarina, una nuova allieva romena, di sedici anni e quel che resta di una vita usurpata, violentata, già sgualcita in più punti con strappi che sembra di sentire sottopelle. Almarina ha le braccia che sono un campo dissodato d’inverno, c’è il fango gelato di una fuga di notte e i segni delle botte e della paura, dietro le palpebre corre un treno che arriva dai Balcani, una folla di persone che scappano, il suono di un violino, i campi freddi della Slovenia con le coperte sui giacconi e nelle orecchie una nenia antica.
Ci sono oggetti, nel testo di Valeria Parrella, traboccanti di storie: il fascicolo di Almarina al suo ingresso in carcere, da leggere con le dita, scorrendo su montagne, vallate e torrenti, una casa dove non si può restare, lenzuola fresche di bucato, il vento della Transilvania e una canzone di Maria Lataretu; il panettone cucinato in carcere ogni anno dai detenuti, che contiene fili pieni di panni stesi, un televisore enorme sempre acceso dentro case popolari altissime e una famiglia che non ti può salvare.
Almarina è una possibilità da liberare, Elisabetta le regala storie, libri e un luogo in cui dimenticare strappi e ferite. È la figlia che non ha potuto avere, quel desiderio di tramandarsi, di riversare un po’ della propria vita in un’altra vita e lasciare che si divida da sé e cammini per il mondo. Almarina è la vita da accogliere per lasciare andare quelle passate, per alzarsi dalla pira su cui si è sdraiata alla morte del marito e riconoscersi corpo vivo. L’altro da attraversare, cui donare parte di sé per tornare interi.
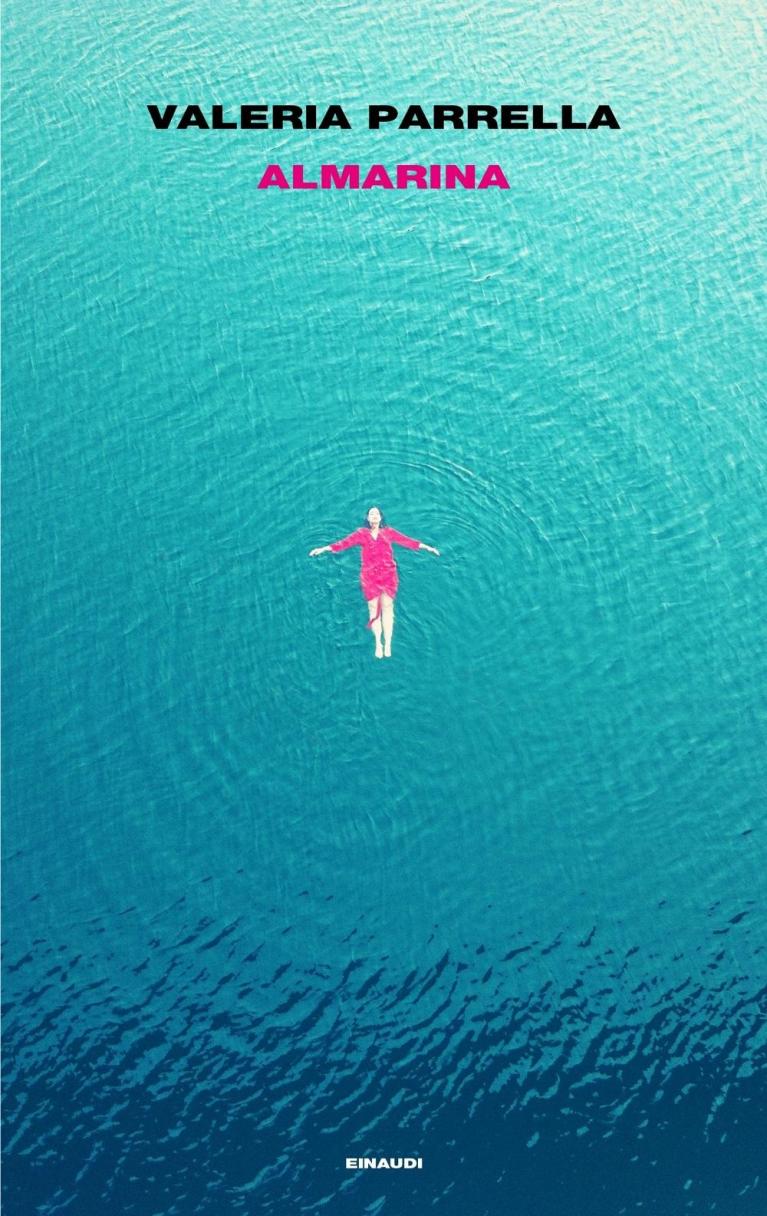
Alice Cappagli. Niente caffè per Spinoza
Anche Maria Vittoria si ritrova a metà della sua vita a fare la badante e anche per lei, come per Matilde, il tentativo di emancipazione economica si trasforma in percorso di emancipazione sentimentale e intellettuale. Ma se l'ingegner Dutto nel romanzo di Paola Cereda faceva i conti con nubi scure nella testa, visitato da lampi di memorie e allucinazioni, il Professor Farnesi di Niente caffè per Spinoza ha il buio soltanto negli occhi e a Maria Vittoria, oltre a rassettare la casa e a cucinare, tocca il compito di rintracciare tra i libri sparsi per casa le parole già scavate nella memoria del professore.
Fuggendo da un matrimonio che si consuma in silenzio, tra rancore e insofferenza e da un’immagine di sé che la opprime, su richiesta del professore Maria Vittoria setaccia la libreria e scopre Pascal, Sant’Agostino, Epitteto, Spinoza, recita massime, pensieri, li assume come pillole, una riga alla volta, lasciando che facciano effetto come le medicine, in modo indipendente da lei.
Il rapporto con il professore la obbliga a farsi vicaria dello sguardo altrui, la invita a guardare, in senso letterale, con gli occhi dell’altro. Così anche in questo romanzo si delineano, in modo forse più didascalico, il percorso di evoluzione che la protagonista si trova a intraprendere mentre si dedica all’altro, la reciprocità del rapporto di cura, il processo di apertura (dello sguardo, della mente, della vita) innescato dalla condivisione e dalla conoscenza, la riconquista dell’indipendenza attraverso l’avvicinamento all’altro e alla riscoperta di sé e dei propri desideri.
Maria Vittoria lascia la sua piccola e chiusa vita coniugale per entrare in una casa spalancata al sole e all’aria di mare che si fa spiaggia e onde e la spinge ad aprirsi e a lasciar entrare luce e possibilità. La Livorno che fa da sfondo al romanzo è Libeccio prepotente, una strada che l’attraversa, una deviazione che porta al mare. È un tempo presente, lambito da memorie che attraversano gli oceani e arrivano come pezzi di vetro opachi e lettere sbiadite e da opportunità vicine, limpide e raggiungibili.
Come per gli altri due libri, anche il mondo descritto da Alice Cappagli è costellato di oggetti che custodiscono dolori e affetti passati, cornici con vecchie foto che sbiadiscono giorno dopo giorno come i ricordi che conservano, la libreria che pian piano si svuota dei libri, in una “lenta emorragia di parole, sentimenti, desideri”, che è la vita del professore, giunta ormai all’epilogo.
Qui i simboli parlano forte e non c’è molto da decifrare, il percorso di Maria Vittoria è lineare e scorre regolare e rassicurante fino alla fine. Dentro una storia che rispetta ogni attesa, ciò che appare più prezioso sono le dissonanze, il professore cieco che si muove seguendo cigolii e correnti d’aria in una casa piena di vento e di luce, aperta come una nave; il vociare ininterrotto nello studio illuminato, durante interminabili conversazioni e letture con allievi, amici e colleghi opposto alla completa incomunicabilità della vita priva di dialogo e di libri nella vecchia famiglia di Maria Vittoria; la richiesta di rileggere passi già conosciuti, per sentire parole familiari nella voce di un altro, come un incantesimo che le fa diverse e più vere.
Tutti e tre i libri raccontano di solitudini che collidono con altre vite e dall’incontro si lasciano cambiare; tutti e tre parlano di vite infestate da rimpianti, ricordi e desideri che si cristallizzano in gesti, in simboli e in oggetti. Dentro questi amuleti abitano desideri inespressi, scelte incompiute, rinunce che mandano in stallo le vite che vi si incagliano e anche un potenziale alchemico di trasformazione, sprigionato dalla possibilità di lasciarli andare.
Così in tutti e tre i romanzi ci sono oggetti intrisi di valore affettivo, pegni di amori passati che pesano nelle tasche, affaticano il passo e non lasciano avanzare.
Per Maria Vittoria è la collana ricevuta per i suoi diciott’anni, con un ciondolo in rubino, quella che non indossava per la paura di perdere un ricordo caro. Rincasando trova in una zuppiera la ricevuta del Monte dei Pegni, scopre che il marito ha impegnato la collana per coprire i suoi debiti, e sente che il tempo stringe ed è ora di andar via.
Matilde porta lei stessa al Monte i suoi amuleti, che lì si chiamano beni “perché sono legami ceduti nel breve periodo, a garanzia di una mancanza o di un errore da risarcire”. Sono la spilla oro rosso e rubini regalatale dalla nonna per il matrimonio e rifiutata dalla figlia perché fuori moda e un girocollo oro-diamante, dono del marito per la nascita della figlia. Li scambia con denaro per pagare l’affetto di una famiglia distante.
Elisabetta, invece, va dall’orefice con le sue fedi, simbolo delle nozze con il marito compianto e ne fa orecchini perché il negoziante glielo suggerisce, prima di lasciar andare anche quelli, legati a un’altra vita da incominciare.
I negozianti napoletani, dice Elisabetta, sono bravissimi a “inventare formule per perpetuare morte e vita che altrimenti non valgono nulla”, e nei tre casi, il lasciare andare un tesoro carico di simboli e vincoli al passato ha la forza di una trasmutazione: l’abbandonare la propria forma per acquistarne una nuova.
In tutti e tre i casi ciò coincide con una scelta, una minuscola rivoluzione che sancisce il ritorno a se stessi, ridisegnando i contorni della propria identità e del proprio desiderio, legittimandolo di fronte agli altri e al proprio passato. E per tutte e tre le donne protagoniste di questi romanzi, questa conquista sembra passare necessariamente dall’esperienza di una femminilità materna, che accudisce, accoglie e si lascia trasformare. La riconquista della loro identità, della loro indipendenza sembra non poter prescindere da questo attraversamento, dal donare una parte di sé e del proprio desiderio all’altro perché ce li restituisca mutati.







