Andrea Pomella, Marco Rossari, Igiaba Scego / Incendi, una nuova collana di narrativa italiana
Alcuni incontri cruciali nel corso della vita colpiscono come folgorazioni: uno schianto secco contro una verità che stordisce e spacca la vita a metà, segnando un prima e un dopo inconciliabili. Altre volte si tratta invece di un graduale avvicinarsi, piccole collisioni accidentali prima di scoprirsi ormai sedotti, infestati, incapaci di distinguere il momento preciso in cui ha avuto origine il contagio. In mezzo c’è tutto il fantasioso spettro di possibilità con cui la vita semina intorno a noi scintille, esplosioni e segnali di fumo.
La collana Incendi di Add Editore va in cerca di queste testimonianze lucenti e bruciacchiate.
“Incendi è una collana fatta di passioni e di incontri” – leggiamo nella presentazione – “le passioni incendiano le vite, le muovono e le modificano”, come sassolini sui binari che fanno deragliare piani e progetti, un abbaglio che sbanda l’auto in corsa. E agli autori ospitati in questa collana viene chiesto di spiegare le proprie ustioni, di tornare indietro tra fiamme e carboni, di raccontare da dove l’incendio si è propagato, come tutto ha preso fuoco, in quali spazi è ancora vivo il calore. Spesso, anche se non è la regola, l’incendio prende forma umana, ha voce, corpo, ferite, si muove nel mondo e parla una lingua universale e privata. È il caso di tre titoli della collana dedicati a Bob Dylan, Caetano Veloso e ai Pearl Jam. Non sono biografie, non sono saggi, o meglio, lo sono in parte, ma sono prima di tutto racconti, guide, “narrazioni combustibili”, itinerari personalissimi e privi di qualunque pretesa di esaustività, dichiaratamente parziali, ritratti autobiografici “per interposta persona”, come scrive Rossari.
Andrea Pomella. Anni luce
Anni luce, di Andrea Pomella ne è un esempio perfetto. I Pearl Jam non sono solo la colonna sonora dei suoi vent’anni incendiati, la musica è soprattutto l’interprete che traduce il vocabolario della sua disperazione nella lingua del mondo: “non mi importava il nome dei Pearl Jam in sé, mi importavano alcune cose che esso mi evocava e che ogni loro lavoro diventasse al primo ascolto l’intermediario obbligatorio per l’acquisizione della mia consapevolezza del mondo, che portasse a galla i sintomi della mia costernazione, dei miei traumi, della mia angoscia, che fosse il grimaldello capace di forzare la scatola magica del mio gusto, e che abbellisse, accanto alla coscienza del dolore, i momenti più cupi della mia gioventù”.
Il libro è la storia di un’amicizia, “una solida, sbilenca, acida amicizia”, quella con Q., il compagno di sbronze e di viaggio, fratello nella musica, nell’avventura, nella distruzione, nel tentativo di trascinare il più possibile la propria giovinezza, di rubare anche quella degli altri, “per avere ancora più realtà da sabotare attraverso il vino”. Anni luce guarda nel vuoto, con un misto di dolore, tenerezza e nostalgia, lo fa attraverso i dischi dei Pearl Jam ma non si ferma a questo, “riguarda tutto ciò che si metteva in moto quando dalle casse dello stereo usciva una loro canzone, il vortice di angosce, divertimenti, memorie, furori, gioie, inquietudini che si incanalava attraverso la loro musica”.
Sono i primi anni novanta, Q. lavora come benzinaio, Andrea è iscritto alla facoltà di Lettere, suonano, ascoltano musica, vagano per Roma come flâneurs disperati in cerca della sbronza perfetta. I tormenti politici post-adolescenziali dei coetanei impegnati in scioperi e assemblee non li smuovono, rivelano il segno della contraffazione, appaiono come la parodia di un modello romantico ormai vetusto, un gioco noioso da rimpiazzare con qualcosa di diverso. “La nostra mente, il nostro sistema nervoso, e perfino quella cosa che si suole chiamare anima, erano permeati dall’assenza di luce” scrive Pomella, e quest’oscurità elettrica e distruttiva è lo spazio ideale per lasciar attecchire un genere musicale che viene da Seattle e che da moda giovanile diviene ben presto una filosofia di vita. Si tratta di “una filosofia ribelle, depressa, pessimista, che aveva come unico sfogo la pulsione suicida. La più lucida e disperata tra le mode giovanili dai tempi del decadentismo francese”, il grunge. Per la prima volta un genere musicale si fonda su una patologia psichiatrica: “Il punk era fondato sulla rivolta, il rock’n’roll sulla trasgressione, l’hard rock sull’aggressività, il dark rock sull’introspezione, il blues sulla malinconia” il grunge si radica nel disturbo depressivo.
“Grazie al grunge tutto ciò che accadeva intorno alle nostre vite trovava un terreno disposto ad accoglierlo, delle sensibilità in grado di condensarlo, e un bisogno capace di restituirlo. Il grunge faceva di noi degli iniziati che credevano alla dannazione del mondo”. Così inizia una corsa disperata e immobile, “con addosso la sensazione di una perpetua clandestinità senza sbocchi”, una disperazione che inghiotte ogni cosa, musica, cibo, alcol, fino a ridurre tutto in poltiglia vischiosa sul pavimento, in cenere spenta, “perché se c’è un fuoco, è giusto che qualcosa bruci”. Come l’estate del 1995 sfrecciando con un biglietto Interrail in mezzo all’Europa, zaini pieni di whisky e chitarre per bagaglio. “C’era da combattere il sonno, l’angoscia e i pensieri cupi che si addensavano”, ma il viaggio era la dimensione perfetta per bruciare la propria giovinezza, rifiutare di fermarsi e guardare il futuro, “sapevamo di aver scoperto il nostro luogo ideale. Non era una città o una terra. Era un movimento, un andare”.
La fuga, però, è un’illusione e la giovinezza il più effimero dei miraggi (“gli anni Novanta sono stati nichilismo, rifiuto, autodistruzione, oscurità, ipnosi. Se dovessi dire che sono stati anni bellissimi è solo perché hanno coinciso con i miei vent’anni”).
“Ten, Vs. e Vitalogy sono la santa trinità della mia giovinezza” scrive Pomella, “quei tre dischi mi hanno dato un’identità. Ero senza volto, immerso in una perenna zona d’ombra, che guardavo ai miei giorni passati e futuri con un ghigno velenoso. E poi improvvisamente ero di fronte a uno specchio, avevo un posto, mi riconoscevo in qualcosa.” Ten, Vs. e Vitalogy sono l’incendio che bruciava insieme alla sua giovinezza, la luce che ora filtra da quegli anni di buio quando si volta indietro, a distanza di anni luce, dopo che la vita lo ha “trapassato con un nugolo di frecce”, con tante piccole detonazioni ancora nel petto inesplose.
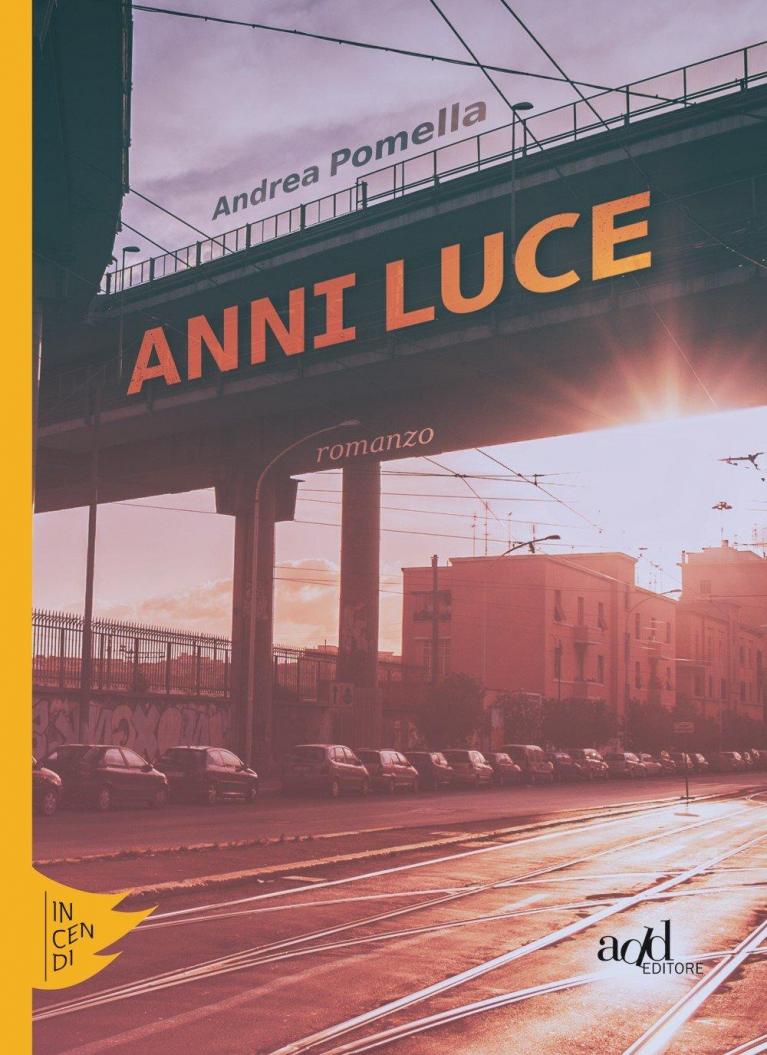
Marco Rossari. Bob Dylan Il Fantasma dell’elettricità
L’incendio di Marco Rossari è “un soffio leggerissimo, un filo di voce, un coltello nell’acqua, è la nebbia di T.S. Eliot che si strofina come un gatto contro i vetri”, è la voce Robert Allen Zimmerman, la voce di Bob Dylan che “è in grado, come ha scritto una volta un tizio, di rendere le parole irrecuperabili, come un sogno che si dilegua”.
Seppur dallo scheletro del libro trapeli la cronologia sacra del dio del folk, del menestrello di Duluth, neppure questa è una biografia. “È la storia di tre canzoni. Una storia di fantasmi. La mia storia”. Rossari sta tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici e copiosamente innaffiata di bonarda, nell’auto che corre lungo “le vene sporche di Milano” risuona la voce mutaforma di Dylan. L’auto si ferma, dal finestrino comincia a rovesciarsi la storia di Dylan mescolata quella dello scrittore, l’abitacolo si popola di spettri e di ricordi e nelle ossa urla “the ghost of ‘lectricity”, il fantasma dell’elettricità.
Tre spettri dickensiani accompagnano l’autore in un viaggio nel tempo e prendono la forma di tre canzoni, prelevate dalla discografia inesistente di Dylan (un patrimonio sterminato e nascosto, in parte inedito e colmo di meravigliose, preziose lacune) in nome dell’unica ratio accettabile in questo caso: l’arbitraria, appassionata volontà dell’autore.
I tre brani scelti sono The Lonesome Death of Hattie Carroll, Tangled Up in Blue, e Mississippi, ma nel libro gli spettri e le canzoni si moltiplicano, nascono una dall’altra, ritornano e sono sempre nuove, come Dylan e la sua intera opera, continuamente in divenire, impermanente; Dylan come Kafka, Joyce, Musil, una storia incompleta, aperta, dove quel che conta è il movimento, il flusso: “i dischi erano aggeggi provvisori, formazioni momentanee di un flusso impetuoso. È questo che fanno i musicisti: provare, cercare nuove strade, avventurarsi finché non si accende la fiammella di un cerino”. E tutte le volte che la fiammella si accende divampano incendi memorabili, Dylan non è un uomo, è un simbolo, un paradosso, è una colonna d’aria, come lo definisce Allen Ginsberg, un tutt’uno d’anima e corpo, è uno sciamano, “un fiume che scorre, una parvenza vaga”: “Dylan è stata un’avanguardia compiuta, impersonata da un solo individuo, nuovissima e insieme comprensibile a tutti, l’attimo perfetto, il tramite di un’epoca che si travasava in quella successiva e che non a caso, pur lasciandolo miracolosamente illeso, l’ha prostrato e ha portato dischi quieti in attesa che il daimon tornasse a scalpitare”.
Per Rossari l’incontro con Dylan è uno di quelli che iniziano con una voce dentro una radio che ti trapassa senza che tu possa opporti, con piccole apparizioni fumose finché non ti scopri stregato, impegnato a decifrare le formule magiche nascoste nei testi a varcare le soglie dei dischi più chiusi e a dimenticare tutto quello che hai sentito perché ogni volta che ascolti Dylan è la prima volta e non si finisce mai di conoscerlo e di conoscere se stessi attraverso di lui. “Dylan è un mondo privato, intimo, in cui trova riparo da ogni cosa”, il mondo che esplorava quando i genitori lo rimproveravano di stare chiuso nella sua stanza, ma lui invece era apertissimo, è la voce che traduceva il suo amore per una ragazza bruttina e sfuggente, in corsa su un treno (un altro Interrail) nell’estate del 1993.
Dylan è un fantasma perché muore tante volte e tutte le volte ritorna, è uno spettro che infesta perfino se stesso, e il suo essere inafferrabile eppure così terrestre è ciò che “ti tiene sospeso, appeso alla sua grazia”: “c’è qualcosa nel suo modo. È difficile stare a metà strada con Dylan. Se ti avvicini troppo vieni facilmente risucchiato. Girare intorno a un gorgo è pericoloso, si comincia a vorticare sempre più veloci, come dentro i solchi di un vinile e nel giro di un amen sei sprofondato nel maelstrom”. Come una falena verso la luce. Incendiata.
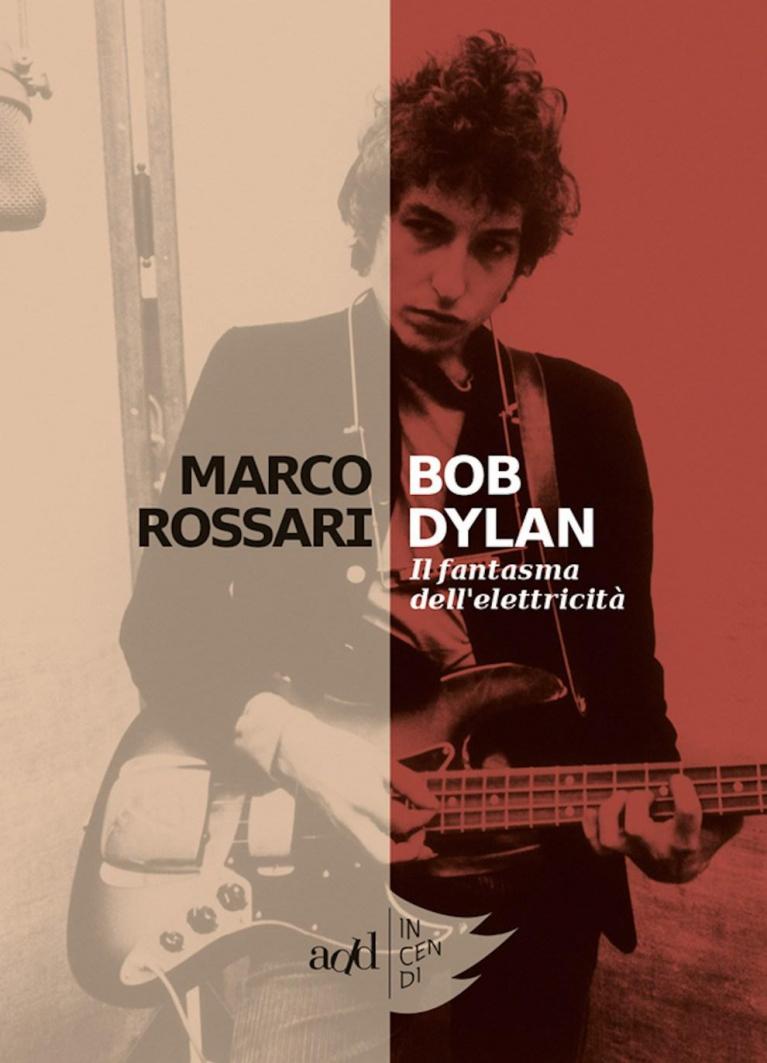
Igiaba Scego. Caetano Veloso. Camminando contro vento
Quello di Igiaba Scego è un itinerario sentimentale, “un percorso, fallace e incompleto”, dentro la musica di Caetano Veloso. Siamo dentro un cammino, il suo personalissimo Cammino di Caetano, e questo cammino inizia dalla fine, dal luglio del 2015, quando sui profili twitter in gran parte del mondo, compare l’hashtag #caetanodecueca, inaugurato da una rilassata foto dell’artista in déshabillé che diventa subito trend topic. Da ogni paese i fan di Veloso raccolgono l’invito a postare il proprio Caetano “in cueca”, ovvero in mutande, foto d’epoca raccolte con gioia, affetto e voglia di ridere della vita: “così abbiamo festeggiato in modo bizzarro la gioia di essere vivi, irriverenti, belli e soprattutto ironici. D’altronde lo abbiamo imparato da lui che si vive affrontando le incertezze, sbagliando come tutti e azzeccando l’essenziale. Rabbia, felicità, tristezza, ogni cosa assume la sfumatura di un accordo, la placida compostezza di un verso”.
Come ogni mito che si rispetti, anche quello di Caetano è fatto di ferite, guerre e poesia e la narrazione agiografica dell’eroe di Bahia racconta disfatte, rivincite, incontri, errori, passioni e innumerevoli rinascite. “Caetano Veloso è un frullato, uno di quelli dove polpa, gusci e semi vanno a braccetto. Non esclude, include. In fondo è come il Brasile. Odora di quella terra fatta di contraddizioni e bellezza, di orrori e paradiso. Non si è mai dato la missione precisa di raccontare il suo Paese, ma è successo. Forse è per questo che il 16 luglio 2015 sui social di tutto il mondo è circolata la sua foto in mutande”.
#caetanodecueca è il pretesto per celebrare la fortuna di essere inciampati, nel corso della propria vita, in una voce dalla giusta intonazione, capace di parlare l’idioma che risuona in fondo alle nostre parole ma s’incenerisce sulle labbra, incomprensibile e muto. Lo stesso è questo libro, legittimato solo dall’assoluta devozione dell’autrice per un artista che è maestro, guida, famiglia, identità. “Tutte le volte che la sorte mi ha ignorata o malmenata c’è sempre stata una sua canzone pronta a sorreggermi. Una sua canzone mi faceva da scudo contro un mondo ostile e cattivo”. Per Igiaba Caetano è rifugio ma anche una via per trovare se stessa, per riconoscersi dentro una storia lontana ma perfettamente somigliante. C’è l’amore profondo per la famiglia, per la madre Dona Canô, per la sorella Maria Bethânia, per i fratelli, per gli amici Gilberto Gil, Gal Costa, per il suo popolo, c’è il legame inviolabile con la sua terra, con il Brasile, con Salvador de Bahia, con Santo Amaro. E c’è il richiamo di quel Paese pervaso di contraddizioni e di bellezza, di una cultura sotterranea e pulsante, c’è il Tropicalismo, la rivolta contro le ipocrisie e il buon gusto e in nome di una sincera, sfrenata libertà, la voglia di danzare sul bordo di un mondo che sta per finire, perché “chi è di Bahia sa vivere come un equilibrista sull’architettura di un mondo in dissoluzione”.
Poi c’è l’esilio, il dolore, la saudade che toglie il respiro nella Londra del reggae e dei Beatles, viva a suo modo, ma irrimediabilmente lontana da casa. Igiaba Scego ritrova temi, movimenti, sentimenti che combaciano alla perfezione con i suoi, ma ciò che la lega più intimamente a Caetano è la musica: “Caetano Veloso per me è essenzialmente la sua poesia. E dentro questa poesia c’è la sua voce, strumento delicatissimo, che entra come una freccia di cupido nei nostri cuori”.
Con la sua musica e con la sua vita Caetano è il maestro che insegna che lottare per i diritti degli altri è possibile e dovuto, che rimanere ostinatamente fedeli a se stessi fa della propria rivolta un’istanza universale. Caetano è poesia ed è politica, “ogni sua azione è da considerarsi politica, ogni respiro”, ogni verso scagliato contro chi vuole negare la natura di quella terra, chi vuole spegnerne la musica più sincera. Sotto una dittatura militare Caetano Veloso rivendica con responsabilità e coraggio, “la voglia di guardare al futuro, senza paura dell’ordine costituito”, di “camminare controvento a testa scoperta e senza documenti”, come in Alegria Alegria, di ridere in faccia al nemico del popolo urlandogli la minaccia più sovversiva e luminosa: “dove ti nasconderai dalla smisurata allegria?”, come recita Apesar de você, il manifesto contro il regime del collega tropicalista Chico Barque. Non si può slegare la propria voce da quella che sale dal fondo della terra e Caetano è politico ma è anche mistico e rituale, “in Caetano tutto è legato, tutto ha un senso”, in Caetano tout se tient a rileggerlo con lo sguardo innamorato: “Caetano sperimenta suoni, rumori, sensazioni, tutto per arrivare a quella perfezione musicale che anche lui spera forse di non trovare. La perfezione può essere bella, ma quello che è ancora più straordinario della perfezione è la strada che si percorre per trovarla. Il percorso e il tentativo sono il fine di questa ricerca che impegna Veloso totalmente.”
Pomella, Rossari e Scego sono coetanei, nati tra il 1973 e il 1974, sono quarantenni e – scrive Rossari – “a quarant’anni scopri di avere un passato. Una buona parte di quello che è stato torna in superficie, riscoperto o insomma guardato con occhi nuovi”. È il momento giusto per voltarsi a contemplare l’incendio che è stato, per passeggiare tra i tizzoni accesi.
Dentro questi libri incendiari ci sono vite ricostruite con amore, permettendo a tenerezza e passione di lasciar affiorare nodi e destini dove sembravano spalancarsi solo il disordine e il caso. Questi libri parlano di fenici allenate a bruciare per esorcizzare le proprie innumerevoli morti e generare nuova vita, nuovi incendi. Questi libri parlano di ectoplasmi (i Pearl Jam che cantano gli spettri iridescenti, l’inafferrabile fantasma elettrico di Duluth, lo spirito di un amico pianto con tutte le lacrime che si possono versare e raccolto in una rosa e in una Cajuina), e gli incontri prendono la forma di fantasmi, visitazioni, accompagnano la vita come spiriti guida e infilate di fuochi fatui lungo la strada. Ma soprattutto, in questi libri gli autori parlano di se stessi, si guardano allo specchio, perché gli incendi non spostano veramente le vite e non cambiano la strada, la illuminano. Lo spiega bene Pomella: “la musica non mi ha salvato da oscuri propositi. Non l’arte, né la letteratura. I dischi e i libri non fanno né bene né male. Danno consapevolezza, generano dubbi, benesseri o malesseri temporanei. Incidono il tanto che durano, ma non cambiano la testa alle persone come fanno la filosofia, la politica o la religione. I dischi e i libri sono specchi, più o meno deformanti, in cui cerchi te stesso, le parole e i suoni che sei. E quando li trovi, è allora che esisti, totalmente, pienamente, che sei, senza propaggini, senza scaturire oltre i limiti, solo nel tempo che permane, nel preciso istante”.







