Marco Peano. Chiari lutti
Una donna torna a casa per morire. Questo è l'inizio de L'invenzione della madre, romanzo d'esordio di Marco Peano (minimum fax 2015). La donna è malata di cancro in varie forme da nove anni, le metastasi inarrestabili hanno raggiunto il cervello: la sua unica sorte possibile – anche se lei non lo sa, perché gli altri scelgono di recitare la finzione di un qualche tipo di sviluppo improbabile – è aspettare in un letto. E l'unico movimento del romanzo sarà il disfacimento del corpo, l'unico tempo quello statico e totalitario della malattia. La narrazione distrugge la stessa idea di viaggio, di percorso: la donna si disintegra lentamente, suo figlio ventiseienne non cresce, la provincia abulica in cui i personaggi stanno e sono sempre stati permane uguale a se stessa, un paesaggio di niente.
Il corpo – quel corpo – è il vero centro narrativo del racconto e insieme la voragine mefitica che tutto inghiotte. Con precisione implacabile, l'autore scandisce i dettagli della rovina: l'incontinenza, e il balletto rituale di marito e figlio della donna intorno al cambio di pannolone, la perdita dell'appetito, la perdita del pensiero logico, la perdita della vista, la perdita di un pezzo ancora, e poi un altro. La violenta descrizione dei fenomeni ricorda l'iperrealismo con cui Philippe Forest (che infatti è una delle ispirazioni dichiarate di Peano), in Tutti i bambini tranne uno e Per tutta la notte, insiste sui segni atroci che il tumore, divorandola, lasciava sulla sua bambina. E proprio come in Forest, non è uno sguardo pornografico: si riconosce l'affanno del testimone che cerca di restituire con parole sempre insufficienti la sofferenza mostruosa di chi non può più parlare (in questo caso, di chi è costretto al silenzio anche prima della propria fine). La stessa impotenza e la stessa apparente efferatezza linguistica di Simone De Beauvoir di fronte alla “carne putrescente” dell'anziana madre che sta morendo, lei pure, di cancro, per giunta in una situazione ospedaliera terrificante – il libro è Una morte dolcissima. L'esperienza autobiografica, nell'Invenzione della madre, è trasfigurata in una finzione narrativa del tutto autonoma (e solida, nonostante qualche debolezza drammaturgica), ma la necessità testimoniale resta la matrice evidente.
Fra tutte, la scena forse più significativa in questo senso è quella in cui Mattia, il protagonista, guarda il fisioterapista che manipola la madre: la morfina non ha ancora fatto effetto e lei ruggisce di un dolore “non necessario”, insopportabile; e lui «si domandava se quella belva calva schiumante di rabbia fosse davvero la persona che lui aveva tanto amato e dalla quale era stato tanto amato, se lì dentro ci fosse lei o la malattia».
Questo è l'altro paradosso insostenibile con cui protagonista e lettore devono confrontarsi. La madre, in qualche modo, pur essendo il fulcro della storia e l'oggetto d'amore, è stata cancellata. Nonostante Mattia cerchi di registrare ogni suo respiro, ogni frammento infinitesimale della sua esistenza prossima all'esaurimento, «quando però prova a immaginarla prima della malattia, incontra una specie di ostacolo mentale che frena il ricordo. È incapace di visualizzare il volto di lei se non sovrapponendolo con quello che conosce ora»: il volto deturpato dell'agonia. Ritrovare il suo vero volto, la sua identità, è un atto mnemonico impossibile. In qualche modo c'è già una risposta alla domanda che si è fatto considerando la “belva calva”: forse sua madre è davvero diventata la malattia, la malattia l'ha sostituita spazzando via la sua intelligenza e ciò che è stata, occupando interamente il suo carapace ferito, sfinito, svuotato del sé. In qualche modo, Mattia deve riappropriarsi della memoria e della persona: così, come suggerisce il titolo del libro, ricreare l'essere amato e perduto che un tempo ha creato lui, anche tramite gesti che a un osservatore esterno potrebbero sembrare folli, o di un lirismo stupido e puerile.
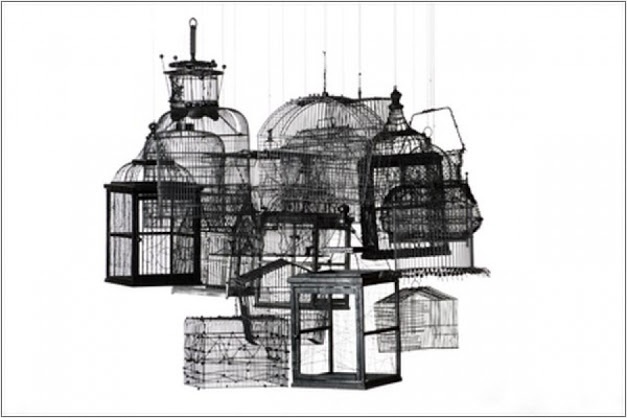
Giorgio Vasta ha trovato un'espressione felice (“negromante”) per la sequela di ossessioni tenera e irrazionale che il protagonista pensa e agisce, cercando prima di fermare la madre nel tempo e poi di perpetuarla nel ricordo. È il tema portante del romanzo, il fondamento stesso della sua struttura linguistica, che riflette la dissezione del reale, delle parole e delle intenzioni operata continuamente da Mattia. Ma c'è, intrecciato a questo, un altro motivo centrale che vibra in sordina per tutta la narrazione: la crudeltà di chi è in lutto. Mattia manipola le persone (in uno dei passaggi migliori del libro, fornisce a una vicina venuta in visita alla morte della madre una versione ricostruita ad hoc della scena di un lutto che aveva colpito lei molti anni prima, «insistendo sui particolari che più facilmente muovono alla commozione», lei piange e lui è soddisfatto), pungola la loro vergogna, li fa sentire in colpa di una colpa che non hanno (essere sani; essere vivi). Tutti i comportamenti degli “altri” con la madre malata e poi nel lutto sono letti in chiave negativa: vogliono evitarla, ringraziano di non essere lei, fuggono dalla sua malattia, poi fuggono dalla sua morte. Sono tutti cattivi, tutti scorretti, tutti vigliacchi. Sono tutti immeritevoli di essere vivi al posto di lei. È un meccanismo mentale tipico, ma Peano lo fissa sulla pagina con un'attenzione nuova, forse la cosa in assoluto più interessante del romanzo. Mattia è ingiusto, spesso subdolo, l'egoismo del suo dolore si spinge fino a desiderare che la madre sopravviva a tutti i costi, anche se ridotta a vegetale: possiamo essere orribili quando soffriamo.
L'invenzione della madre è un libro duro, sgradevole e bello, con momenti di tenerezza lancinante (il più emozionante, forse: la scena dell'acquisto della parrucca), orchestrato con estrema consapevolezza letteraria, talvolta un po' troppo forzata verso uno scopo (il tema che potremmo definire “cinematografico”, il meno convincente della partitura). È anche un libro amorale, nel senso che si situa fuori dalla morale, così come il comportamento del lutto. Non giudica né condona: racconta di quando cadono i criteri che siamo abituati a considerare normali. Al tempo stesso, però, è costruito intorno a un problema morale cruciale.
La resistenza di Mattia alla rassegnazione, all'oblio, alla guarigione – come quella di Forest che ripudia con rabbia e ostinazione la cosiddetta “elaborazione del lutto” - ha i tratti, ancora una volta, della malattia: ma una malattia necessaria, sembrerebbe, per piantare un segno nel posto vuoto di chi è stato, un tempo, vivo. Certo, la conclusione suggerisce che lasciar andare è necessario per crescere, per non fermarsi sempre nello stesso punto. Eppure, leggendo mi è tornato in mente Jean Améry, e la sua idea (per un evento tragico di tutt'altre dimensioni, la Shoah, ma valida anche per la catastrofe individuale) della memoria come risentimento, dell'opposizione al «rimarginarsi delle ferite» come rivolta assoluta. «È diritto e privilegio dell'essere umano non dichiararsi d'accordo con ogni evento naturale, e quindi nemmeno con il rimarginarsi biologico provocato dal tempo. Quel che è stato è stato: questa espressione è tanto vera quanto contraria al morale e allo spirito. La resistenza morale ha in sé la protesta, la rivolta contro la realtà, che è ragionevole fintanto che è morale. L'uomo morale esige la sospensione del tempo».
E questa minuscola storia di provincia, in cui il fatto banale prolifera in miriadi di significati, in cui l'ossessione prende possesso della realtà, in cui una creatura muore, è in fondo la storia di una rivolta contro il tempo.







