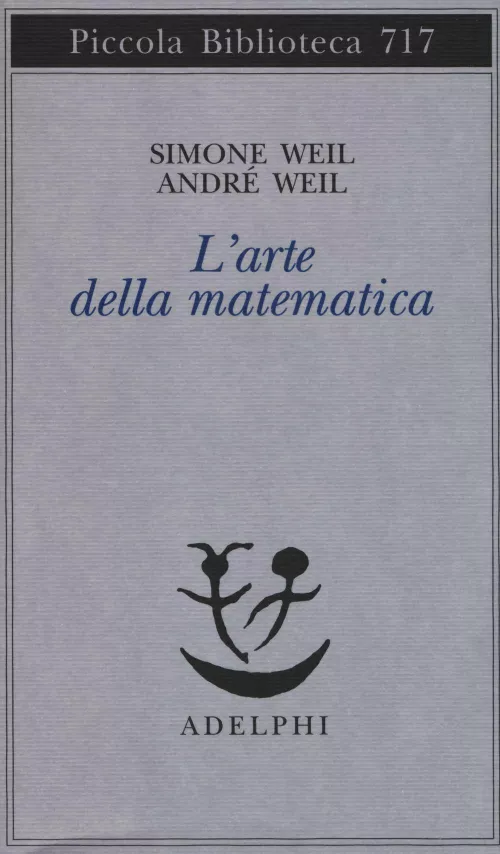Fratello e sorella / André e Simone Weil: l’arte della matematica
«Il genio era bicefalo – scrive Sylvie Weil, figlia di André e nipote di Simone, in un suo intenso libro di memorie, sospeso tra rievocazione famigliare e percorso di ricerca interiore (Chez les Weil. André et Simone, Buchet/Chastel, Paris 2009; trad. it. Casa Weil. André e Simone, Lantana, Roma 2013) –. Mio padre aveva un doppio, un doppio femminile, un doppio fantasma. Sì, perché mia zia, oltre a essere una santa, era un doppio di mio padre, cui assomigliava come una gemella. Doppio onnipresente, come può esserlo solo un fantasma che non ha più altro da fare. Che non è più militante, non insegna più, non parte più per fare la guerra in Spagna, non ha più stupefacenti incontri con Cristo, e ciò nonostante continua, senza tregua, a fare tutto questo, ancora meglio dei vivi. Un doppio per me terrificante, perché le assomigliavo tanto. Assomigliavo al doppio di mio padre».
Una fotografia li ritrae insieme, André e Simone, nel 1922, durante le vacanze estive a Knokke-Le Zoute. Entrambi sono seduti dietro un tavolo – quasi un banco di scuola – e strizzano gli occhi, forse a causa del sole, forse perché entrambi sono fortemente miopi. André, che all’epoca ha sedici anni, guarda fisso l’obiettivo con una mezza smorfia che esprime il fastidio di essere stato interrotto nella lettura del libro che tiene aperto tra le mani. Simone, di tre anni più giovane, fa un largo sorriso un po’ imbarazzato e tiene il braccio destro rigidamente piegato sul tavolo, quasi una barriera a protezione della propria inviolabile intimità. Viene in mente, al proposito, quel che Simone Pétrement ricorda nella sua Vita di Simone Weil (ed. or. 1973): «Non voleva essere baciata, si rifiutava di mangiare certe cose o di toccarne altre. A volte non voleva neppure sfiorare quel che era stato toccato da altri. In questi casi faceva appello al suo “disgusto” e per sottrarsi diceva: “Non posso a causa del mio disgusto”».
L’inclinazione di André per la matematica si manifesta molto precocemente. Ancora bambino studia da autodidatta il manuale di geometria di Émile Borel; a soli diciannove anni si classifica primo al concorso di agrégation per l’insegnamento della matematica nelle scuole; è del 1928 il suo primo articolo potentemente innovativo, L’arithmétique des courbes algébriques, in cui si inaugura un nuovo settore di ricerca, all’incrocio tra teoria dei numeri, algebra e geometria, destinato ad avere un ruolo propulsivo per lo sviluppo della matematica del XX secolo. Ma André è anche uno spirito irrequieto – trascorre più di due anni, dal 1930 al 1932, in India, insegnando nell’università di Alīgarh. Per usare le parole della figlia Sylvie, «il suo cervello [è] una piovra, i cui tentacoli si allunga[no] in tutte le direzioni»: si interessa di arte, legge l’Iliade nell’orginale greco, studia il sanscrito sotto la guida di Sylvain Lévi e frequentando (nello stesso anno di Georges Dumézil) le lezioni di Jules Boch alla Sorbona.
«Le straordinarie doti di mio fratello, che ha avuto un’infanzia e un’adolescenza paragonabili a quelle di Pascal – scriverà Simone, un anno prima della morte, in una lunga lettera a padre Perrin (la cosiddetta «autobiografia intelletuale», che si può leggere in traduzione italiana nel volume Attesa di Dio, Adelphi, Milano 2008) – mi costringevano ad avere coscienza [della mediocrità delle mie facoltà naturali]». Proprio a causa di questo sentimento di inadeguatezza, precipita, a quattordici anni, «in una di quelle disperazioni senza fondo tipiche dell’adolescenza», giungendo a un passo dal suicidio. Da questo periodo di «tenebre interiori» esce solo dopo aver maturato «la certezza che qualsiasi essere umano, anche se le sue facoltà naturali sono minime, penetra in questo regno della verità riservato al genio, se solo desidera la verità e compie un perpetuo sforzo di attenzione per raggiungerla». Influenzata profondamente dall’insegnamento di Alain, suo docente al Lycée Henri IV, Simone imbocca la strada della filosofia: la ricerca della verità – una nozione, questa, non astrattamente teoretica, ma radicata nella disciplina quotidiana dell’«attenzione», e legata in modo indissolubile ai concetti cardine di libertà e di giustizia – sarà il principio guida della sua vita, alla base di quelle scelte radicali e fuori dagli schemi che ad altri (incluso il fratello) apparivano soltanto ostinazioni e bizzarrie.
Nel 1940 – l’anno a cui risalgono le lettere e gli abbozzi di lettera raccolti nel volume L’arte della matematica (Adelphi, Milano 2018, basato sul primo volume del tomo VII delle Œuvres complètes edite da Gallimard, e ottimamente curato da Maria Concetta Sala) – i tempi di Knokke-Le Zoute sono lontani. Non siedono più allo stesso banco, fratello e sorella. André, intorno alla metà degli anni ’30, ha dato vita con altri giovani normaliens (tra cui Henri Cartan, Claude Chevalley e Jean Dieudonné) al gruppo di ricerca denominato con lo pseudonimo collettivo, originariamente goliardico, di Nicolas Bourbaki. L’ambizioso obiettivo che si prefigge questo manipolo di matematici iconoclasti è di ricostruire dalle fondamenta, in un trattato in più volumi, l’intero edificio della matematica, in una prospettiva unitaria che superi le diversità di linguaggio tra le varie discipline e secondo criteri di assoluto rigore formale. Il lavoro di preparazione si rivela forse meno agevole e sicuramente più lento del previsto, scandito da litigiose riunioni estive, ad alcune delle quali partecipa anche Simone: il primo smilzo fascicolo degli Élements de mathématique, consacrato alla teoria degli insiemi, è pubblicato nel 1939, il secondo, sulle strutture topologiche, nel 1940. In quello stesso decennio Simone persegue la propria quête solitaria, quasi con accanimento, in un inesausto «sforzo di attenzione» che abbraccia tanto l’impegno politico e sociale, quanto la riflessione filosofica, e si apre anche all’esperienza religiosa, soprattutto nei suoi aspetti mistici e soteriologici: interrompe l’attività di insegnamento (in licei di provincia) per sperimentare sulla propria pelle la durezza della condizione operaia; frequenta il circolo marxista di Boris Souvarine; prende parte alla guerra di Spagna, sul fronte d’Aragona; scrive alcuni dei suoi testi fondamentali, tra cui le Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale (1934) e L’Iliade ou le poème de la force (concepito nel 1937-38, pubbicato nel 1940 nei «Cahiers du Sud»).
L’inizio della seconda guerra mondiale sorprende André in Finlandia. Sospettato di essere una spia tedesca, viene arrestato e quindi liberato per una serie di circostanze fortuite e fortunate (un episodio che, molti anni dopo, il protagonista narrerà, non senza qualche compiacimento romanzesco, nella sua autobiografia, Souvenirs d’apprentissage; trad. it Ricordi di apprendistato, Einaudi, Torino 1994, rist. Castelvecchi, Roma 2013). Al ritorno in Francia, è incriminato per renitenza alla leva e rinchiuso, da febbraio a maggio 1940, nel carcere di Rouen, in attesa di giudizio. È a questo indirizzo che riceverà le lettere della sorella.

A scegliere i temi principali che si intrecciano in questo scambio epistolare – a condurre, per così dire, il gioco – è chiaramente Simone. «Visto che di tempo ne hai anche troppo – scrive nella prima lettera –, un’altra buona occupazione potrebbe essere metterti a riflettere sul modo di fare intravedere a profani come me in che cosa consistano esattamente l’interesse e la portata dei tuoi lavori. […] Non sono tanto le matematiche […] a interessarmi, quanto i matematici, così come in ogni altro ambito». La risposta del fratello è tagliente: «Quanto parlare delle mie ricerche o di qualsiasi altra ricerca matematica ai non-specialisti, tanto varrebbe spiegare una sinfonia a dei sordi». Certamente – argomenta –, sarebbe possibile parlare di «temi che si rincorrono, s’intrecciano, si coniugano e si separano», accennare ad «armonie» e «dissonanze», ma in questo modo non si arriverebbe a cogliere l’essenza ultima di ciò che si intendeva descrivere. Michelangelo – secondo il quale, come si sa, la scultura «si fa per forza di levare» – è autore di un sonetto i cui versi iniziali sono: «Non ha l’ottimo artista alcun concetto /c’un marmo solo in sé non circoscriva /col suo superchio, e solo a quello arriva / la man che ubbidisce all’intelletto». Proprio ricordando questa quartina, André osserva che «la matematica non è altro che un’arte: una sorta di scultura in una materia estremamente dura e resistente» (parole che, in verità, sembrano più vicine all’incipit «Si come per levar, donna, si pone / in pietra alpestre e dura» di un’altra delle Rime di Michelangelo, un madrigale, non un sonetto – la memoria, a volte, inganna anche i geni). L’«asperità della materia con cui lavora» conferisce alle creazioni del matematico «una specie di oggettività», e il fatto che queste siano, per presupposto apodittico, «opere d’arte» le rende «inspiegabili», cioè non traducibili in alcun linguaggio diverso da quello stesso in cui sono espresse. Eppure, a dispetto di queste convinzioni, nella lunga lettera successiva, André non si sottrae alla richiesta della sorella e si cimenta nell’impresa di illustrarle le proprie ricerche e la loro importanza, premettendo però l’avvertenza che «non potr[à] cercare di capire certi punti senza cadere nel lautmanismo» (un’allusione tanto perfida quanto ingiusta al brillante filosofo della matematica Albert Lautman, che Simone aveva conosciuto all’École Normale e ammirava). Le quasi venti pagine che seguono sono, in effetti, per la massima parte incomprensibili a chi già non abbia vaste conoscenze matematiche: sembrano scritte da André più per se stesso che per un lettore profano, quasi per mettere ordine nei pensieri che gli si affollano in testa mentre è intento a elaborare – sì, proprio in quei mesi di prigione – quello che si deve considerare il risultato scientifico più importante della sua lunga carriera, vale a dire la dimostrazione dell’ipotesi di Riemann per curve su campi finiti.
Simone, com’è naturale, si trova in disaccordo con l’idea che la matematica sia un’arte, nel senso inteso dal fratello. Lo scienziato, come l’artista, non vive in una bolla solipstica, perché è votato a una missione – quella di perseguire la verità. Per questa ragione – leggiamo nell’abbozzo di una lettera mai spedita – «i problemi che gli artisti hanno negli occhi e nelle dita» dipendono (o meglio, dovrebbero dipendere) «dalla loro concezione del mondo e della vita umana». Qualche anno più tardi, nel saggio Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, composto a Londra negli ultimi mesi di vita (e pubblicato nel 1949 con il titolo editoriale, scelto da Camus, L’enracinement, che Fortini, nella sua traduzione, bizzarramente trasformerà in La prima radice), la critica di Simone nei confronti della similitudine usata da André assume toni ben più aspri: «C’è un matematico cui piace paragonare la matematica a una scultura in una pietra estremamente dura. Persone che si presentano al pubblico come sacerdoti della verità, si divertono a svilire il ruolo che hanno paragonandosi a giocatori di scacchi: il paragone con uno scultore è più onorevole. Ma se si ha la vocazione di fare lo scultore, è meglio fare lo scultore piuttosto che il matematico. Quel paragone, esaminato più attentamente, non ha senso, nella concezione attuale della scienza. È solo il presentimento assai confuso di un’idea differente».
Nel passo appena citato, Simone, quando parla di persone che vanno in giro paragonandosi a giocatori di scacchi, fa senza dubbio allusione ai matematici dell’indirizzo formalista. Questo orientamento, ispirato alle idee espresse da David Hilbert, si fonda sull’impostazione assiomatica e sulla netta separazione tra sintassi (il gioco le cui regole sono gli assiomi e le leggi logiche) e semantica. Il gruppo Bourbaki – pur nella diversità di posizioni filosofiche, più o meno apertamente dichiarate, dei suoi membri – prende le mosse dal formalismo hilbertiano, evidenziando tuttavia che questa concezione non è sufficiente a «restituire l’intelligibilità profonda della matematica» (così nell’articolo L’architecture des mathématiques, pubblicato nel 1948): viene pertanto introdotta la nuova nozione di struttura, la quale continua però a essere puramente assiomatica e basata, dunque, sull’assoluto divieto di formulare qualsiasi ipotesi sulla natura specifica degli elementi della struttura. In altre parole, tanto per i formalisti quanto per Bourbaki, la matematica si riduce a mera manipolazione di segni astratti secondo regole del gioco del tutto arbitrarie.
In una lettera inviata al fratello nel marzo del 1940, Simone esprime il timore che, seguendo l’impostazione assiomatica, «ci si avvicini piuttosto alla concezione dei Babilonesi [che non a quella dei Greci], vale a dire che si faccia un gioco più che un’arte». E qual è – si domanda – la «materia dura» di cui parla André? «Questa materia – osserva con acume – non è forse essenzialmente costituita dall’insieme dei lavori matematici compiuti fino a oggi?». Soltanto «per i Greci la matematica era veramente un’arte» e «[i]l suo scopo era il medesimo di quello della loro arte, ovvero rendere sensibile un’affinità tra la mente umana e l’universo, fare apparire il mondo come “la città di tutti gli esseri dotati di ragione”» (una citazione tratta da Marco Aurelio). Infatti, in quella civiltà – che Simone ritiene aver inizio con l’Iliade e terminare con i Vangeli, come diffusamente argomentato negli scritti tradotti nel volume La rivelazione greca (Adelphi, Milano 2014), – non si limitava a essere «una speculazione razionale e astratta», ma, al contempo e inseparabilmente, rappresentava una «scienza della natura» (anzi, «la scienza della natura per eccellenza») e una «mistica». In particolare, la geometria greca, in quanto espressione del potere di mediazione del logos (sia come numero sia come Verbum), dovrebbe essere considerata «una forma simbolica della teologia», e la sua apparizione in terra ellenica sarebbe «la più fulgida tra tutte le profezie che hanno annunciato il Cristo».
Mentre non si può nascondere che la ricostruzione complessiva dello sviluppo della geometria greca proposta da Simone Weil, e soprattutto certe sue considerazioni sull’emergere dei concetti di numero reale e di funzione appaiano oggi quantomeno azzardate dal punto di visto della storia della scienza (e ciò indipendentemente dalla loro valenza filosofica), le critiche che la pensatrice francese muove nei confronti della concezione formalista della matematica non solo sono fondate, ma precorrono dissensi che altri avrebbero manifestato ancor più nettamente qualche decennio più tardi. È indubbio che l’influsso – anzi, il predominio – di Bourbaki sulla matematica del Novcento sia stato profondo e globalizzante, nel senso che gli Élements de mathématique hanno contribuito a imporre un simbolismo e uno stile (una maniera?) diffusi su scala internazionale: ricercatori di almeno quattro generazioni e della più varia provenienza geografica – dagli Stati Uniti al Giappone – si sono formati studiando questi trattati. Ma non sono mancate le voci fuori del coro. René Thom ha accusato Bourbaki di voler «ridurre la matematica a una mummia», Vladimir Arnol’d ha denunciato gli inutili eccessi di rigore degli Élements e la loro nefasta influenza sull’insegnamento della disciplina e Gian-Carlo Rota, da un punto di vista più generale, ha osservato che «confondere la matematica con l’assiomatica è come confondere la musica di Vivaldi con le tecniche di contrappunto dell’era barocca».
L’impulso genuinamente innovatore di Bournaki si esaurì all’incirca alla metà degli anni Sessanta, a causa soprattutto dei radicali mutamenti interni alla matematica stessa: divenne una scuola, una dottrina, quasi un catechismo. Alexander Grothendieck, il geniale rifondatore della geometria algebrica (e membro del gruppo fino ai primi anni Sessanta) ricorda lo stupore provato, nel 1970, «scoprendo fino a che punto il nome stesso di Bourbaki era diventato impopolare in ampi strati […] del mondo matematico, in quanto più o meno sinonimo di elitismo, di dogmatismo stretto, di culto della forma “canonica” a detrimento di una comprensione viva, di ermetismo, di antispontaneità castratrice e così di seguito». La «dura pietra» evocata da André Weil è materia troppo fredda e ostile, che inibisce l’attività di creazione e trasforma di fatto la matematica in una tecnica, un virtuosismo volto soltanto alla soluzione di problemi. Al contrario, le grandi idee matematiche non sono invenzioni artificiose dettate dal capriccio e dall’abilità fuori dal comune dell’«artista», ma hanno spesso una loro disarmante semplicità che scaturisce dalla capacità di gettare uno sguardo completamente nuovo, quasi infantile, sul mondo. Nessuno meglio di Grothendieck ha saputo esprimere la forza di questa necessità: «Le cose create richiedono sempre un ascolto più fine e attento, perché tutte hanno un senso. Questo senso è al contempo infinitamente delicato e folgorante come lo splendore insostenibile di mille soli. È per questo motivo che nessuno di noi lo può cogliere nella sua pienezza, ma tutt’al più presentirlo o intravederlo, nella prospettiva e nella luce uniche che a ciascuno fornisce la propria esperienza».
Parole, queste, che avrebbero fatto storcere il naso ad André, ma non sarebbero dispiaciute a Simone.
Simone Weil, André Weil, L’arte della matematica, a cura di Robert Chenavier e André A. Devaux, Ed. It. a cura di Maria Concetta Sala, Adelphi, Milano 2018, pp. 185