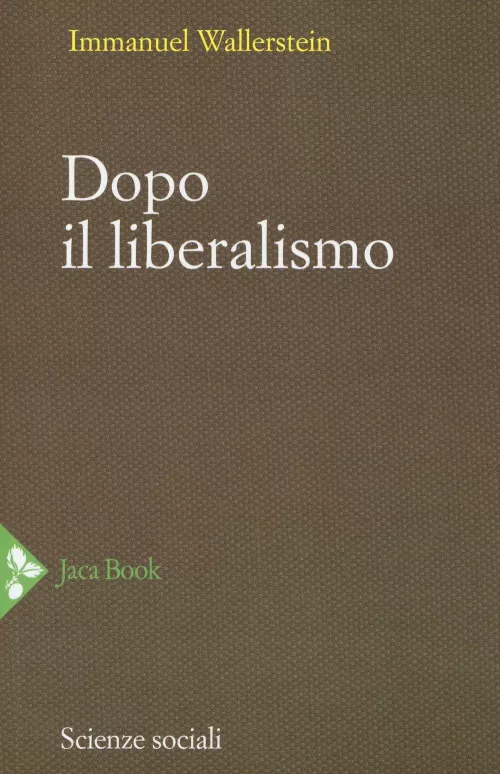La storia senza fondamenti di Wallerstein e Ceruti / Illusioni e sfide del passaggio di secolo
Trent’anni fa, la caduta del Muro di Berlino si elevò quasi immediatamente al rango di evento periodizzante. Come la cesura tra la fine del mondo bipolare della “guerra fredda” e l’avvento, non senza incognite, di un nuovo ordine mondiale, come la ferita rimarginata che ricuciva finalmente il tessuto europeo. Curiosamente, il suo enorme impatto simbolico indusse subito anche illusioni, errori, che attingevano ancora inconsciamente dalle fonti cognitive e dalle logiche di pensiero del primo Novecento, le quali avevano contribuito ai drammi storici e cruenti che quel Muro aveva finito per ricapitolare e sigillare. Infatti, la scomparsa o, meglio ancora, la sconfitta di uno dei due duellanti (il comunismo sovietico) e il collasso della sua corazza politico-ideologica (il marxismo-leninismo), secondo il politologo americano Francis Fukuyama, autorizzava non solo a sperare ragionevolmente nella democrazia liberale di stampo occidentale come modello insuperabile per la migliore convivenza possibile tra esseri umani, ma a riprendere la fiducia nell’esistenza del progresso e di una “storia universale dell’umanità, coerente e direzionale”, di cui quel modello si presentava ora chiaramente come compimento e fine. Era il 1992: l’anno in cui uscì il suo End of History and the Last Man. Uno dei vangeli della mainstream neoliberale che avrebbe segnato quegli anni, a discapito dell’accumularsi degli eventi che cominciarono comunque a incrinare la previsione di un’inevitabile e graduale convergenza del mondo verso la meta indicata da Fukuyama: la guerra nel Golfo Persico, la riesplosione dei nazionalismi etnici nell’Europa orientale, i primi germi di antipolitica nell’Europa occidentale, la disintegrazione della ex-Jugoslavia con lo spettro della pulizia etnica, l’alternativa competitiva del modello cinese, la recrudescenza del fondamentalismo islamico, fino ad arrivare all’attacco alle Twin Towers.
Ma, sempre in quegli anni, ci furono voci controcorrente che non si associarono né al facile trionfalismo politico né all’ottimismo di una nuova “filosofia della Storia universale”. Come ad esempio, quella degli autori di due libri, editi la prima volta nel 1995 (Mauro Ceruti, Evoluzione senza fondamenti) e nel 1998 (Immanuel Wallerstein, Dopo il liberalismo, invero una raccolta di saggi e articoli scritti già tra il 1991 e il 1994), ristampati da poco rispettivamente da Meltemi e Jaca Book. Legati, non a caso, anche dall’encomio che il secondo, lo storico, sociologo ed economista americano (purtroppo, scomparso di recente), espresse per la valenza epistemologica del libro del primo, il filosofo italiano, nell’occasione dell’edizione inglese del libro: Evolution Without Foundations, dove Ceruti parla esplicitamente delle storia umana come “il teatro di una continua creazione di possibilità”, che automaticamente esclude proprio la possibilità che la stessa Storia sia giunta alla fine e che si possa disegnarla con l’immagine di un decorso monodirezionale.
Immanuel Wallerstein, il noto teorico e studioso del sistema-mondo capitalista, che si è edificato e sviluppato a partire dal XV secolo, presenta nei suoi saggi molto densi una lettura decisamente ‘antagonista’ e scandalosa del “1989”. Quest’anno non è solo l’anno in cui si chiude il secolo breve, con il crollo dei regimi comunisti dell’Est Europa, ma anche l’anno del crollo dell’ideologia liberale che aveva dominato il sistema mondiale moderno per quasi due secoli, dal 1789 agli anni Sessanta del Novecento, e già in agonia dal 1968. La caduta del comunismo coincide, quindi, con la fine del liberalismo come cemento ideologico dell’economia-mondo capitalista. La tesi apparentemente paradossale di Wallerstein si comprende alla luce della periodizzazione storica che egli propone e declina in quasi tutto il libro, da angolazioni e prospettive tematiche diverse. Per lo storico americano, è la Rivoluzione francese a dare un primo involucro ideologico al nuovo sistema-mondo trasformando in Weltanschauung la visione moderna della “normalità” e desiderabilità del cambiamento politico e del principio di sovranità popolare. I futuri programmi politici si dovranno forgiare in reazione a questa nuova mentalità e, in effetti, l’ideologia liberale vera e propria, come programma completo e a lungo termine, capace di mobilitare un grande numero di persone, nasce in contrapposizione al rifiuto “conservatore” (De Maistre, Burke) delle innovazioni rivoluzionarie francesi.
Dopo le rivoluzioni del 1848, che, nonostante i fallimenti, archiviano come anacronistico e impraticabile il progetto della Restaurazione, il “liberalismo” s’interpone e si afferma come ideologia di centro tra il conservatorismo e il socialismo emergente, incardinata sulle promesse di un riformismo razionale e sociale graduale e l’ampliamento del suffragio, e sul ricorso, per la loro implementazione, alle strutture amministrative dello Stato nazionale, a dispetto della retorica dello “Stato minimo” e del valore della società civile. Nella seconda metà dell’Ottocento, quest’ideologia diventa imperante al punto che il suo programma sarà portato avanti da un conservatorismo divenuto “illuminato” (pensiamo a Bismarck in Germania) o dal socialismo divenuto liberal-socialista (pensiamo sempre alle vicende della socialdemocrazia tedesca), che resero a volte superflui gli stessi partiti liberali in senso stretto, fino a determinarne la sostanziale scomparsa dopo il 1914. Dopo il primo conflitto mondiale, il “liberalismo”, che ormai riscuote un consenso tacito universale, assume la veste programmatica e ideale del “wilsonismo”, ispirata appunto dal presidente statunitense che volle l’entrata in guerra del suo Paese, “per salvaguardare la democrazia nel mondo”.

La strategia ora non è più solo quella d’integrare le classi lavoratrici nella società e nello Stato dei Paesi industrializzati, ma d’integrare le semiperiferie e le periferie del pianeta nel sistema-mondo capitalista, facendo assurgere più esplicitamente l’ideologia liberale a vettore globale, cioè a geocultura del sistema-mondo. I due capisaldi del wilsonismo diventano, infatti, l’autodeterminazione delle nazioni e lo “sviluppo (economico) nazionale”, equivalenti, a livello mondiale, degli obiettivi del suffragio e del Welfare State. Il programma sarà perseguito soprattutto dai successori di Wilson e dopo la seconda guerra mondiale, favorendo i processi di decolonizzazione e promuovendo aiuti finanziari per il Terzo Mondo. Solo relativamente esso avrà un rivale nel contestuale programma anti-imperialista del leninismo, pure rivolto alle periferie del mondo che, in verità, agirà in modo complementare a quello wilsoniano, nelle modalità e negli esiti, al di là della propaganda ufficiale. Tuttavia, saranno le rivolte studentesche mondiali del 1968 e la stagflazione degli anni seguenti a far incrinare il consenso verso il programma wilsoniano-leninista, svelandone i fallimenti e le connivenze e sollevando dubbi sull’ideologia sviluppista che lo informava, aprendo una crisi che troverà il suo epilogo, per Wallerstein, con il tramonto definitivo del “liberalismo” come geocultura mondiale proprio nel fatidico “1989” e con l’avvio conclamato di un caos e disordine sistemico che, con incertezze e fluttuazioni interne, segnerà una transizione a un nuovo sistema-mondo, per almeno tutta la prima metà del XXI secolo, e con direzioni imprevedibili e potenzialmente divergenti nel risultato finale: “un nuovo sistema (o più sistemi) inegualitario e gerarchico oppure un sistema largamente democratico ed egualitario”.
A prescindere dall’intonazione militante di alcuni saggi e dal “pregiudizio” marxista che sembra portare Wallerstein a liquidare l’ideologia liberale dominante del passato come una retorica dell’emancipazione finalmente smascherata, quel che colpisce del libro è la capacità preveggente dello storico che ha imparato a fondo la lezione di Braudel, e che riesce a individuare, già alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, i germi dell’onda lunga di delusioni, speranze tradite e di rabbia che avrebbe gonfiato il vento dell’antipolitica e dei nazional-populismi in Occidente e dei fondamentalismi religiosi fuori dall’Occidente e fatto evaporare l’incantesimo del libero mercato, in concomitanza con criticità crescenti elencate nel libro: migrazioni da Sud a Nord, delegittimazione e crisi fiscale dello Stato, crisi dei debiti sovrani, senso diffuso d’insicurezza, impoverimento dei ceti medi. Wallerstein considera il sistema-mondo, la sua categoria storica chiave, come un “sistema complesso” e indaga lo sviluppo storico della geocultura liberale come un albero evolutivo a partire dalla formazione del suo “materiale grezzo” con la Rivoluzione francese. Si spiega così l’attenzione che lo storico americano riserva alle ricerche epistemologiche e al libro di Mauro Ceruti, che, ai suoi occhi, “riunisce le critiche alle visioni del mondo semplificate della scienza moderna e alle visioni evoluzionistiche semplificate, sviluppando un’argomentazione magnificamente chiara a favore di un pluralismo evolutivo e di discontinuità imprevedibili”.
Se, infatti, per Ceruti le scienze evolutive hanno ormai rinunciato a sciogliere l’intricatissimo nodo di “caso” e “necessità”, l’esempio di Fukuyama dimostra come le scienze storico-sociali si ostinino ancora a cercare una “ragione”, astuta o meno, immanente al processo storico. Proprio dall’esame degli sviluppi più recenti delle cosmologie fisiche e delle teorie dell’evoluzione biologica, Ceruti trae l’indicazione di un pensiero complesso e interdisciplinare, al di là della divisione tra le “due” culture, che, nella visione della storia, tenga insieme i processi e le forme, i flussi e le stabilità, insomma, una “visione binoculare del divenire”. È quella che suggestivamente definisce nell’ultimo dei quattro saggi brevi che compongono il libro: storia senza fondamenti. “Storia senza fondamenti” significa che non è possibile ricostruire la catena delle cause e degli effetti di ciò che è accaduto come la trama in grado di farci apparire coerente e ineluttabile ciò che siamo adesso, ma solo come una sequenza di eventi necessari sì, ma non abbastanza da giustificare l’ineluttabilità di quell’esito e a chiudere la possibilità di percorsi alternativi. È una storia in cui alcuni rami, come lo è stato per l’evoluzione di organismi e specie viventi, possono rinsecchirsi o estinguersi: qualcuno, forse, si ricorda ancora di quando Kruscev disse che l’Unione Sovietica avrebbe “seppellito” l’America?

La storia dell’evoluzione ha modificato l’immagine della natura e della storia umana e le nuove conoscenze sulla storia della natura hanno proiettato una luce diversa sulla natura della storia. Non accettare questo, non trarre cioè dalla lezione dell’“evoluzione dell’evoluzione” (il titolo di un altro dei saggi), oggi chiaramente priva di linearità, ma costellata di biforcazioni, soglie, svolte, transizioni, discontinuità, un nuovo approccio alla storia umana (ovviamente non più nel senso riduzionista, distorcente e tendenzioso di fine Ottocento, che prese il nome di “darwinismo sociale”), sarebbe come ripetere l’errore d’incoerenza logica che Darwin attribuiva a coloro che rinunciavano a trarre tutte le conseguenze dalla teoria dei mutamenti geologici di Charles Lyell, non accettando l’esistenza di trasformazioni delle specie viventi. Mostrando come si siano liberate dal condizionamento dei vari idola theatri (il progressionismo, l’essenzialismo, il provvidenzialismo, il finalismo), che sembrano ancora sedurre gli storici e gli scienziati sociali, Ceruti racconta il modo in cui biologi e naturalisti hanno cercato di comprendere la storia e l’evoluzione delle specie viventi incorporando nuovi principi, come quelli di “subottimalità”, di “ridondanza”, di “gerarchia”, per descrivere gli equilibri instabili a cui danno luogo i processi evolutivi e le variazioni che interessano anche i livelli superiori (le specie) e inferiori (il genoma) e non solo gli organismi individuali. Può bastare il caso del pollice del panda gigante di Stephen Jay Gould, per dimostrare come vincoli e possibilità, continuità e scarti, regolarità e singolarità possono combinarsi sulla linea mobile dell’evoluzione e con esiti mai ottimali, come attesta il rischio di estinzione che corre lo stesso panda, per effetto dei nuovi mutamenti ambientali intervenuti.
E, d’altra parte, milioni di anni di evoluzione degli ominidi hanno trovato compimento in una specie incompiuta: appunto, la specie umana. Ora il pluralismo evolutivo (di individui, specie, biosfera, cosmo) non può non essere, per Ceruti, l’ologramma di un pluralismo storico ed epistemico, che oggi può fare da viatico a un “umanesimo planetario”. Questo umanesimo planetario, infatti, si deve appoggiare alle narrazioni multiple delle varie civiltà umane e storiche e alla memoria collettiva dilatata fino alle origini più remote della nostra specie, che sostituiranno il “grande racconto” etnocentrico euro-occidentale che, fino alla prima metà del secolo scorso, vedeva convergere verso il proprio modello le altre culture, misurandone in rapporto ad esso i ritardi o l’arretratezza e qualificando, volta per volta, il bagaglio delle loro conoscenze come prelogico o prescientifico. Si tratta, invece, di riconoscere la pluralità di modelli di razionalità, oltre quello dell’astrazione e della problematizzazione che si è forgiato in Grecia e che Husserl giustamente ci ha indicato come il tratto irriducibile dello “spirito europeo”. Si tratta di comprendere come la conoscenza, anche quella che si è depositata nei miti, si leghi alle forme di vita, ai contesti ambientali, alle congiunture storiche. A cominciare dalle conoscenze cosmologiche antiche che sorgevano dall’auto-interrogazione degli uomini, in ogni latitudine del pianeta, sulla propria posizione nel mondo e relazione col mondo. E l’apertura mentale e culturale che chiede Ceruti è la stessa che chiede Wallerstein, per il quale, nel tempo caotico di transizione che stiamo vivendo verso un nuovo sistema-mondo, “ciò che dobbiamo cercare è la giusta combinazione tra lucidità e fantasia, e potremmo trovarla nei posti più impensati, in qualunque angolo del mondo”.