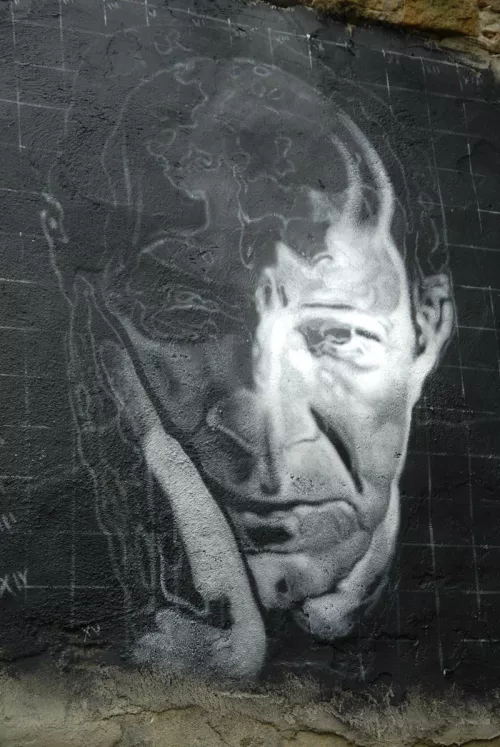Edizione integrale / Homo Sacer. Intervista a Giorgio Agamben
Il 25 ottobre 2018 è uscita in edizione unica per i tipi Quodlibet l’opera che ha tenuto Giorgio Agamben impegnato per vent’anni, vale a dire il progetto Homo sacer. Questo, apertosi con il volume omonimo, uscito nel 1995, si è concluso, infatti, con quello che porta la numerazione IV.2, L’uso dei corpi, uscito nel 2014. Nei volumi che fanno parte di quest’opera sono stati definiti e introdotti nel dibattito filosofico concetti che poi diverranno patrimonio comune (anche nel loro essere stati spesso oggetto di critiche) della filosofia contemporanea: quello di “sacertas”, di “nuda vita”, di “campo”, di “forma-di-vita”, la dicotomia “bios/zoe”, per nominarne solo alcuni. L’enorme successo in particolare del primo volume del progetto nel mondo anglosassone ha creato le premesse per la diffusione dei dibattiti avanzati da Agamben a livello planetario (Agamben è al momento, con ogni probabilità, il filosofo italiano più conosciuto all’estero), tra i cui effetti di ritorno vi è anche quella che poi sarebbe stata definita Italian Theory, ossia un movimento di autoriflessione e di interrogazione della filosofia italiana sulle proprie categorie fondative, che ha investito anche (e soprattutto) il mondo anglofono – interessato a comprendere come un pensatore come Agamben potesse essere posto in dialogo con altri autori, sempre italiani, che hanno animato i dibattiti teorico-critici dei decenni scorsi (tra tutti Toni Negri e Roberto Esposito).
L’intervista che segue, che si concentra principalmente sul progetto Homo sacer e sulla struttura del volume in uscita, è frutto di una riflessione di chi scrive riguardo alle questioni “architettoniche” dell’opera agambeniana. Oltre a dovere un sincero ringraziamento a Giorgio Agamben per l’occasione di dialogo, vorrei in questa sede ringraziare l’amico Carlo Salzani per i preziosi suggerimenti che mi hanno portato alla formulazione di alcune delle domande presentate.
Antonio Lucci: Giorgio Agamben, escono in questi giorni, per Quodlibet, in un’edizione unica i nove volumi di Homo sacer, un lavoro che l’ha tenuta occupata, praticamente, per vent’anni. Lei stesso, nella prefazione all’ultimo dei volumi della serie, L’uso dei corpi, sosteneva che un’opera «può essere solo abbandonata», rifiutando, all’epoca, di mettere la parola “fine” al progetto. In questa edizione completa, Lei vede, a tre anni di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo volume del progetto, un lavoro definitivamente chiuso, o qualcosa ancora passibile di integrazioni?
Giorgio Agamben: Nel pensiero, come nella vita, non è facile sapere che cosa è definitivamente chiuso e che cosa è ancora aperto. Una genealogia della politica occidentale come quella che ho intrapreso in Homo sacer potrebbe continuare senza fine. In questo senso, l’opera compiuta è sempre un frammento. L’apparenza di compiutezza di un’opera è dovuta piuttosto a ragioni per così dire architettoniche e stilistiche ed è soltanto perché l’edificio mi sembrava aver raggiunto una forma coerente che ho potuto abbandonarlo. Un’integrazione in senso tecnico è la lunga nota di quindici pagine sul concetto di guerra che ho aggiunto a Stasis in questa edizione. Ma preferisco considerare altre ricerche che ho pubblicato e potrò eventualmente pubblicare in futuro come opere autonome. Del resto ognuno dei nove volumi qui raccolti era nato con una vita propria e la loro composizione in un insieme non segue soltanto criteri logici e concettuali. Se il primo livello di una composizione filosofica è certamente concettuale, l’ultimo, come ricordava Benjamin, è di ordine musicale.
Una domanda riguardante l’architettura generale del progetto, che prende il nome complessivo dal volume I: Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Originariamente questo volume è l’unico a non essere numerato, il che potrebbe dare l’idea che il volume fosse stato pensato per essere autoconclusivo. D’altra parte, la chiusura dello stesso libro apriva già all’epoca alla possibilità di un ampliamento futuro delle ricerche lì presentate, come indica il passaggio conclusivo: «Se chiamiamo forma-di-vita questo essere che è solo la sua nuda esistenza, questa vita che è la sua forma e resta inseparabile da essa, allora vedremo aprirsi un campo di ricerca che giace al di là di quello definito dall’intersezione di politica e filosofia, scienze medico-biologiche e giurisprudenza. Ma prima occorrerà verificare come, all’interno dei confini di queste discipline, qualcosa come una nuda vita abbia potuto essere pensato e in che modo, nel loro sviluppo storico, esse abbiano finito con l’urtarsi a un limite oltre il quale esse non possono proseguire, se non a rischio di una catastrofe biopolitica senza precedenti» (Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, p. 211). Quando ha pensato e scritto questo primo testo, aveva già in mente di non limitarsi a un solo volume, ma di fare di Homo sacer un progetto?
Anche se sapevo con certezza che avevo intrapreso una ricerca di lungo respiro, non avevo ancora un’idea precisa della sua articolazione. Ho cominciato a intravederla con maggior chiarezza mentre lavoravo a Stato di eccezione. Compresi, cioè, che una ricerca come la mia doveva necessariamente comportare una serie di indagini archeologiche, che sono quelle che sono andate a formare la seconda sezione dell’opera (oltre allo stato di eccezione, la guerra civile, il giuramento, l’economia, l’ufficio – e va da sé che altre avrebbero potuto aggiungersi). Quanto all’ultima sezione, come la sua citazione suggerisce, ero consapevole fin dall’inizio che doveva essere dedicata a una definizione della forma-di-vita.
I primi tre volumi usciti nel progetto, Homo sacer, Ciò che resta di Auschwitz e Stato d’eccezione, sono chiaramente animati da un interesse politico. Nel primo vengono teorizzate due delle categorie filosofiche che avranno poi più successo nella seconda metà degli anni Novanta e nel primo decennio del nuovo millennio: quella di “nuda vita” e di “campo”. Si sono serviti di queste categorie filosofi, antropologi, sociologi, persino geografi. Nei libri successivi però, l’interesse politico esplicito sembra lasciare il posto all’analisi archeologica e i due succitati concetti perdono un po' la loro centralità, mi sembra. Ritiene questi due concetti ancora centrali per la Sua filosofia?
Non ha senso distinguere l’analisi archeologica da quella politica. Una ricerca filosofica che non ha la forma di un’archeologia rischia oggi di finire nella chiacchiera. E non solo perché l’archeologia è la sola via di accesso alla comprensione del presente, ma perché l’essere si dà sempre come un passato, ha costitutivamente bisogno di un’archeologia. I due concetti che lei ha menzionato, avevano il loro posto e il loro senso in una ricerca archeologica sulla struttura del potere e non possono essere separati da questa. Certo, al loro apparire a metà degli anni novanta, questi due concetti suscitarono polemiche e scandalo, e faticai non poco per far capire in che senso la produzione della nuda vita definiva l’operazione fondamentale del potere e perché il campo e non la città fosse il paradigma politico della modernità. Oggi, negli spazi integralmente depoliticizzati delle nostre società postdemocratiche, in cui lo stato d’eccezione è diventato la regola, quei concetti sono diventati quasi banali. Comunque si preferisce spesso usarli in modo generico, al di fuori del contesto in cui erano stati creati e dal quale sono inseparabili; alcuni hanno perfino semplicemente rovesciato la nuda vita e la biopolitica in categorie positive, operazione quanto meno incauta.
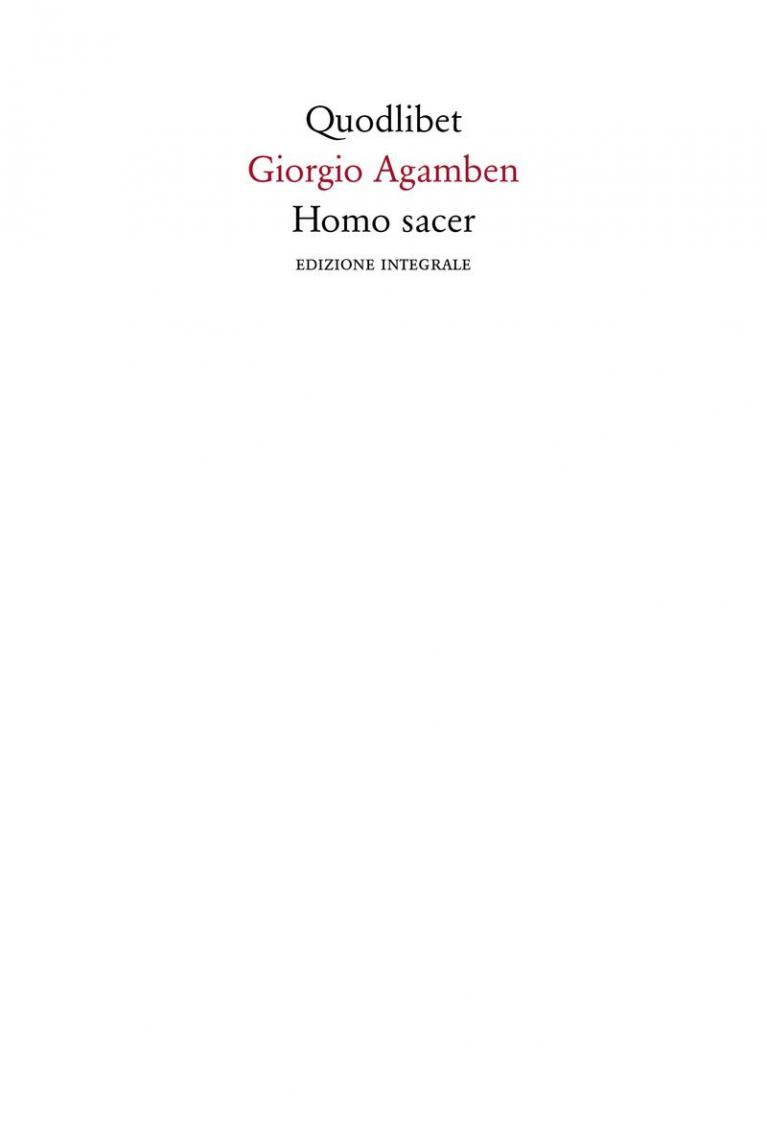
Una domanda sempre relativa alla prima parte del progetto, in particolare ai volumi I e II. Se si considerano il volume di apertura del progetto, Homo sacer, e quelli presenti nella parte II, latinità e grecità appaiono essere in perfetto equilibrio, fin dai titoli dei testi, tre latini (Homo sacer, Iustitium, Opus dei) e tre greci (Stasis, Horkos, Oikonomia). Questo suo non voler dare la predominanza né alla tradizione greca né a quella romana è voluto? Oppure, malgrado l’equilibrio tra i titoli, a Suo parere nel progetto Homo sacer una delle due tradizioni è prioritaria rispetto all’altra?
Non avevo alcuna preoccupazione di mantenere l’equilibrio fra le due culture classiche e i titoli non devono trarre in inganno. Lavoravo su testi latini o greci senza preconcetti secondo le necessità della ricerca e in ciascuna delle mie indagini archeologiche le due tradizioni continuamente si incrociano. L’enorme influenza che ha esercitato sull’occidente il diritto romano mi ha spesso obbligato a confrontarmi con il mondo latino, ma la Grecia, come più tardi la teologia cristiana, è ugualmente presente. Decisivo piuttosto per me è che l’inchiesta archeologica raggiunga ogni volta un punto in cui tra il fenomeno storico e le fonti e i documenti che ce lo hanno trasmesso c’è uno iato e una non coincidenza. A questo punto, che si potrebbe definire il punto di insorgenza del fenomeno o, come lo chiamava Overbeck, la sua preistoria, le fonti e le tradizioni vengono meno e il passato e il presente, la preistoria e la poststoria si fronteggiano e sembrano quasi toccarsi.
Ancora una domanda sull’importanza delle diverse tradizioni filosofiche per il Suo progetto. Dopo la conclusione di Homo sacer, Lei ha pubblicato un testo – Karman. Breve trattato sull’azione, la colpa e il gesto (2017) – in cui si confronta con una genealogia del concetto di colpa, e – per quello che posso ricordare, mi corregga se sbaglio – per la prima volta in maniera diffusa col pensiero orientale. Karman non avrebbe potuto, forse, fare parte anch’esso della sezione II di Homo sacer? O il pensiero orientale è troppo lontano dal progetto di un’archeologia della politica occidentale? Detto altrimenti: secondo Lei, le categorie filosofiche soggiacenti alla struttura concettuale del mondo contemporaneo sono principalmente quelle derivate dall’asse genealogico greco-romano-cristiano, o ci sono altre tradizioni che hanno influito in maniera decisiva sul nostro presente?
Io lavoro solo su ambiti dei quali posso controllare le fonti di prima mano. Questo non significa che le tradizioni, come quelle orientali, di cui non conosco la lingua non mi interessino: significa solo che non posso pretendere di parlarne seriamente. In “Karman”, il pensiero indiano non è oggetto di una indagine archeologica, ma viene solo citato per l’analogia che secondo alcuni studiosi esiste fra il termine sanscrito karman e il latino crimen, che designano entrambi l’azione imputabile a un soggetto e gravida di conseguenze.
Probabilmente la parte II del progetto è quella che, usando una categoria che Lei stesso introduce in Signatura Rerum nel 2008, procede maggiormente per “paradigmi”. Guardando alla nuova disposizione e nomenclatura dei testi che fanno parte del progetto, sembra quasi che due categorie appartenenti al mondo romano, quella di Iustitium e di Opus dei, formino la parentesi di apertura e di chiusura entro cui si inseriscono tre categorie greche, quelle di Stasis, Horkos e Oikonomia. Questi volumi della seconda parte di Homo sacer, e il loro ordinamento, sono da intendersi come interconnessi, da leggersi in continuità l’uno con l’altro? O sono da prendere, appunto, come paradigmi che – La cito – vanno mantenuti «nella loro dispersione» (Signatura rerum, 81), al fine di darci immagini e Urszenen molteplici che hanno condotto fino al cuore pulsante della nostra epoca?
Ancora una volta, le connessioni sono nelle cose e non nell’arbitrio dell’autore. Più che “scene originali”, io cerco di raggiungere ogni volta quello che Foucault chiamava un apriori storico, che per me coincide, come ho appena detto, col punto in cui appare uno scarto fra il fenomeno nella sua sorgività e le fonti e i documenti che ce l’hanno trasmesso, fra la preistoria e la storia. A questo punto la ricerca storica e quella archeologico-filosofica si dividono.
Il volume III del progetto porta ora il titolo “Auschwitz”, e non più “Ciò che resta di Auschwitz”. Come mai ha voluto rinunciare al rimando al “resto”, che è una categoria così importante per tutta l’architettura del Suo volume?
Cambiare un titolo non significa in alcun modo rinunciare a un concetto. “Resto” è una categoria importante nelle mie ricerche e ho anzi da poco terminato un saggio che s’intitola appunto La lingua che resta.
In un’intervista del Gennaio 2001 con Hanna Leitgeb e Cornelia Vismann, uscita per la rivista tedesca Literaturen, lei definiva Homo Sacer III «ein ethisches Korrelat, eine Theorie der Subjektivität», ossia «un correlato etico, una teoria della soggettività» alle teorie esposte nel primo volume di Homo sacer. È ancora di quell’idea, vale a dire che “Auschwitz” contenga la Sua “teoria della soggettività”?
La dottrina del soggetto come testimone svolta nel terzo capitolo del libro su Auschwitz resta per me fondamentale. Sono ancora convinto che veramente umano è solo colui che testimonia del non-umano e che il soggetto testimonia innanzitutto di una desoggettivazione. E mi sembra tuttora vero, come mi ha insegnato Primo Levi, che soggetto è colui che porta alla parola un’impossibilità di parlare.
Spesso nei suoi lavori, e fin dal finale del primo volume della serie Homo sacer, lei fa riferimento alla forma-di-vita. Il testo che sembra avvicinarsi di più alla descrizione di quella che, nella storia della cultura occidentale, è stata una forma-di-vita è Altissima Povertà. Qui il monaco francescano, nella misura in cui esso diviene puro “gesto”, vale a dire incorporazione della regola monastica al di là della propria individualità, diventa – mi sembra di capire – forma-di-vita. Alla fine di Homo sacer IV.2 lei definisce l’anima, per come viene descritta nel platonico Mito di Er, una forma-di-vita. Personalmente ho visto nel Pulcinella di Divertimento per li regazzi (2015), nel Majorana de Che cos’è reale? (2016) e nel Giorgio Agamben de Autoritratto nello studio (2017) tre ritratti paradigmatici di tre forme-di-vita. Ci potrebbe dire qualcosa di più su questo concetto così importante per la sua filosofia? La forma-di-vita ha anche una dimensione politica? Essa si può, in qualche modo, definire, oppure appartiene a quel campo di oggetti che non può essere descritto, ma solo “mostrato”?
La forma-di- vita non ha anche una dimensione politica, è un concetto intrinsecamente politico. Con qualche approssimazione, si potrebbe dire che la forma-di-vita definisce la politica che non è più fondata sull’isolamento della nuda vita, che non è più, in questo senso, una biopolitica. Uno dei risultati delle mie indagini, è che, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, nella nostra cultura la vita non è un concetto medico-scientifico, ma una categoria filosofico-politica. Nei 57 trattati del Corpus Hippocraticum, che raccoglie i testi della medicina greca, il termine vita (zoé) non compare quasi, e comunque mai in un significato tecnico. Se si apre invece la Politica di Aristotele, il concetto “vita” vi assume fin dalle prime pagine una funzione fondamentale. La vita (zoé) è ciò sulla cui esclusione si fonda la polis, o, più precisamente, ciò che viene incluso in essa attraverso la sua esclusione e, in questo modo, funge da fondamento negativo della politica. Questa ex-ceptio, questa presa-fuori o esclusione-inclusiva della vita si ritrova in moltissimi aspetti della nostra cultura, non soltanto politica. Anche l’isolamento della vita vegetativa (anche questa di origine aristotelica, Aristotele detestava le piante) che è alla base della medicina moderna ha una struttura molto simile.
Quanto al suo accenno al libro su Pulcinella e all’Autoritratto nello studio, va da sé che ciò che mi interessa in un essere vivente è sempre la sua forma-di-vita.
Una domanda sui referenti filosofici di Homo sacer. Leggendo i suoi volumi in ordine cronologico, si ha l’impressione che, nei primi testi, gli autori di riferimento siano per Lei, principalmente, Aristotele tra gli antichi, Benjamin e Schmitt tra i contemporanei. Se si guarda invece agli ultimi volumi del progetto, sembra che Lei finisca col “temperare” Aristotele con Platone, per quanto riguarda la grecità, e che Foucault assuma un ruolo sempre più importante, in parallelo con un’importanza sempre minore accordata a Schmitt. In L’uso dei corpi, inoltre, Lei torna di nuovo su Heidegger, dopo che negli ultimi volumi di Homo sacer questi sembrava aver perso importanza. Si tratta solo di un uso di autori differenti a seconda dei differenti contesti e interessi d’indagine, o – effettivamente – nel corso degli ultimi anni il suo interesse filosofico si è spostato? Quali autori ritiene essere i suoi interlocutori principali nel progetto Homo sacer?
Se si dividono i filosofi, com’è stato spesso suggerito, secondo una discendenza platonica e una aristotelica, è chiaro che io mi situerei fra i platonici e non fra gli aristotelici. Altrettanto evidente è che mi sento più vicino a Benjamin che a Schmitt. Ma in una ricerca come quella di Homo sacer non si lavora secondo discendenze e simpatie, ma, come in un campo di battaglia, secondo necessità di ordine strategico e tattico. Se avessi seguito le simpatie, avrei fatto certamente a meno di sfogliare l’immenso corpus della teologia medievale o quello della tradizione giuridica, ma in questo modo mi sarei lasciato sconfiggere da avversari che spero invece di essere riuscito a neutralizzare.
Mi sembra che tanti dei libri e saggi che non fanno "ufficialmente" parte del progetto Homo Sacer siano però molto importanti per la sua concezione e per la sua architettura. Mi riferisco, in particolare a Profanazioni, Che cos'è un dispositivo, ma soprattutto a Il tempo che resta e L'aperto. Quest'ultimo (esplicitamente, ma implicitamente e insistentemente anche Il tempo che resta) è il testo che Lei stesso cita maggiormente tra quelli che ha scritto (cosa che non fa quasi mai nelle Sue opere), specialmente in L'uso dei corpi. Altri testi, invece, – ad esempio Auschwitz – non ritornano mai e non sono mai menzionati. Ci può chiarire il rapporto tra questi (e altri) Suoi testi con quelli inclusi in Homo sacer?
Lei dà forse troppa importanza alle distinzioni formali. Va da sé che tutte le parti dell’opera di un autore sono intrecciate l’una all’altra, non fanno che chiamarsi e rispondersi. E certamente L’aperto, in quanto contiene una riflessione sul concetto di vita e sulla macchina antropologica che divide e insieme congiunge l’animale e l’umano, tocca da vicino la ricerca di Homo sacer. E un’archeologia del messianismo come quella svolta nel Tempo che resta non può mettere in questione l’intera concettualità della nostra cultura. In una indagine come la mia – ma forse è così sempre nel pensiero – tutto è intimamente connesso.
Un’ultima domanda, se permette. Lei scrive, nella prefazione a L’uso dei corpi, che la sua ricerca può «eventualmente, essere continuata da altri». Al ricercatore che volesse porsi nel tracciato indicato da Homo sacer, per cercare di “continuare” quel genere di ricerca, che cosa si sente di dire? E, viceversa, che cosa si augurerebbe di vedere indagato in un possibile Homo sacer V?
Io sono convinto che ciò che vi è di più prezioso in un’opera di pensiero sia la sua capacità di essere sviluppata e continuata da altri. Non si tratta soltanto di un principio metodologico, ma anche di un vero e proprio principio etico che ho sempre cercato di seguire. Se dovessi fare una raccomandazione ai giovani studiosi, sarebbe proprio di non cercare a ogni costo l’originalità, ma di applicarsi piuttosto a raccogliere e a continuare ciò che negli autori che amano è rimasto incompiuto o non detto. Ma, per rispondere alla sua domanda, percepire con chiarezza ciò che nel proprio pensiero è rimasto incompiuto o non detto è per un autore estremamente difficile. Per questo è necessario che sia un altro a farlo.