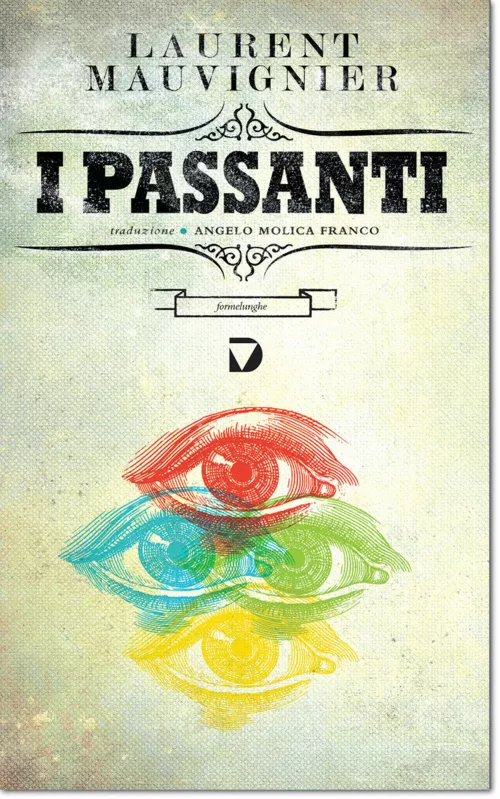Per voce sola: I passanti di Laurent Mauvignier
Al lettore italiano il nome di Laurent Mauvignier suona ancora spesso – troppo spesso – sconosciuto. A fissarne il nome nel pantheon dei contemporanei non è bastata l’ottima stampa di cui ha goduto anche in Italia Degli uomini, romanzo pubblicato da Feltrinelli nel 2010 e da più parti considerato come un pugno allo stomaco per la società francese, troppo disinvolta nel rimuovere i momenti neri della storia dalla propria coscienza collettiva.
Un intreccio sapientemente costruito intorno alla memoria cava e sanguinante di chi prese parte all’eccidio di soldati e civili algerini negli anni che in Europa chiamiamo del dopoguerra e che forse dall’altra parte del Mediterraneo hanno un altro nome. Una storia d’invenzione, senz’altro, ma capace di toccare corde sensibili attraverso l’incrocio di una buona documentazione storica e di un’incredibile padronanza delle tecniche stilistiche nel riprodurre il profilo altimetrico della psicologia, dell’emotività e della moralità “degli uomini”, appunto.
Storia di un oblio, pubblicato due anni dopo sempre da Feltrinelli, lasciò forse un segno più incisivo nella nostra memoria letteraria, plasmata da un decennio di scritture ibride, che scavano tra le efferatezze della cronaca nera nella speranza di estrarne la perla della letteratura. Un ininterrotto monologo di 50 pagine, in cui una voce anonima e difficile da localizzare rievoca l’uccisione di un uomo, colpevole di essersi aperto una birra nel reparto bevande di un supermercato di periferia: un semplice gesto – il dito che alza la linguetta della lattina – per scatenare la rabbia e il risentimento di quattro vigilantes.
Una voce continua, che si muove tra i ricordi e i desideri di chi è morto, così come tra i rimpianti e le solitudini di chi resta; di chi è colpevole di un atto chiamato “assassinio”, che è punito dalla legge, ma anche di chi è responsabile di un omicidio quotidiano, che sfugge alle griglie censorie del consorzio civile perché è fatto “solo” di insofferenza e disprezzo, cattivi umori e diffidenze.
Laurent Mauvignier appartiene al ricco filone della letteratura francese ascrivibile alla scrittura del Male e nel quale si annoverano Emmanuel Carrère, Laurent Binet o Le benevole di Jonathan Littel. La sua, di scrittura, gira attorno ai buchi neri dell’esperienza, a quei luoghi della memoria o della coscienza che oppongono resistenza alle parole. A questa resistenza, Mauvignier, contrappone esattamente quello strumento che all’apparenza sembra il meno incisivo: la parola, appunto.
Che si tratti della Storia, con la maiuscola – la guerra d’Algeria, ma anche la tragedia dello stadio Heysel del 29 maggio 1985, rievocata in Dans la foule (2005, ancora in attesa di traduzione) –, o della quotidianità minima e minimale, per non dire miserabile, di donne e uomini che riversano nel privato della propria coscienza rabbia e frustrazione, egoismo e delusioni di una vita sempre al di sotto delle proprie aspettative, Mauvignier affida al flusso verbale, continuato e sinuoso, il compito di avvolgere, e così coinvolgere, quell’ostacolo. Le parole producono uno sguardo “obliquo”, perché la cosa non può essere vista, ma può comunque essere avvicinata.
In un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita di Dans la foule, Mauvignier aveva definito questo atteggiamento attraverso la metafora del sole: «Io non so cos’è il sole, ma so cos’è la sensazione del calore sulla mia pelle. Io mi accontenterei dell’esplorazione di questa sensazione di calore per dire qualcosa […] Si tratta proprio di rendere conto di un’esperienza. Il monologo ristabilisce quel tipo di fragilità. Non parte da una certezza». Scrivere non significa assegnare dei nomi alle cose, ma rendere raccontabile un’esperienza, anche e proprio a partire dall’impossibilità di darne una definizione precisa.

Così nei romanzi di Laurent Mauvignier la lingua, modulata secondo le linee di un ininterrotto monologo interiore, si presenta come uno strumento di carotaggio, di penetrazione nella coscienza individuale, ma anche collettiva. Perché se in Storia di un oblio e Degli uomini è una sola voce a contenere tutte le diverse espressioni e a ricondurle a un’omofonia di base, nei romanzi precedenti la costruzione del racconto è polifonica, prodotta dal montaggio alternato di voci diverse.
Lontano da loro (1999) e La camera bianca (2000), brevissimi romanzi meritoriamente pubblicati da Zandonai (rispettivamente 2009 e 2008), così come il recentissimo I passanti (2014), portato in Italia da Del Vecchio (che con questa traduzione, di Angelo Molica Franco, arricchisce un catalogo di narrativa straniera già molto interessante) si presentano come “romanzi di voci”, che, in un gioco di rifrazioni reciproche arrivano a far affiorare gradualmente il profilo di ciò che non si ha il coraggio di nominare.
Le esperienze indicibili coprono tutte le latitudini del dolore e del male quotidiano: il suicidio di un ragazzo (Lontano da loro), il tradimento di un marito (La camera bianca) e, nei Passanti, lo stupro di una giovane donna. A parlare qui sono un’altra donna, Catherine, e un uomo, rispettivamente l’amica e l’aggressore della vittima, Claire. Ed è questa la prima cosa che colpisce: la parola che racconta non viene da chi ha vissuto l’evento, ma da chi l’ha osservato, o vi ha partecipato, dall’esterno.
Perché anche l’uomo, per paradossale che possa sembrare, ha visto i fatti svolgersi da fuori: la violenza praticata su Claire – che lui non sa neanche se sia sopravvissuta – è stato un atto estraneo alla sua volontà («Contro la mia volontà, dato che non volevo»). È il perché di questo gesto, allora, che le sue parole cercano di ricostruire, rivivendo gli istanti che l’hanno immediatamente preceduto, ma anche quelli più lontani – il primo incrocio di sguardi con lei, in piscina –, fino ad arrivare a tanti altri momenti di umiliazione quotidiana, che hanno scandito una vita passata a comportarsi come gli altri si aspettavano, solo per compiacerli, per essere visto, riconosciuto, magari anche amato.
Per Catherine le cose sono apparentemente diverse. Nella sua voce rivive il senso di colpa per non essere intervenuta la sera dell’aggressione, quando lei era in casa e avrebbe potuto sentire i rumori provenienti dall’appartamento di Claire, confinante con il suo. Proprio dal percepire i movimenti e i piccoli rumori quotidiani intorno a sé Catherine ha sempre tratto un privato piacere, dato dal sentirsi circondata di persone dalle vite piene, scandite da appuntamenti, incontri, doveri e piaceri. È il riflesso del pieno altrui che dà l’illusione di attutire il proprio vuoto.
Come quando la sera, sentendone i passi sul pianerottolo, sperava che Claire bussasse alla sua porta per fumare un’ultima sigaretta in compagnia e rendere così, inconsapevolmente, la sua giornata degna di essere stata vissuta. Così, a poco a poco, nelle parole di Catherine, il peso di questa solitudine arriva ad affiancarsi al dolore provato per quanto accaduto all’amica. I due sentimenti, però, non sono in competizione tra loro (non potrebbero mai esserlo), bensì legati da un rapporto di necessità che, tuttavia, precisandosi, si rivela invertito.
«Quel mio dolore, proprio qui, che scavava un vuoto e che sentivo battere sotto pelle»: I passanti si apre con queste parole di Catherine. E il dolore a cui si riferisce, che le prime righe sembrano associare allo stupro di Claire, con il passare delle pagine si scopre invece essere quello provato da Catherine per la propria solitudine. Una solitudine che da consuetudine rimediabile diventerà condanna spietata: perché Claire ha deciso di trasferirsi, per provare a ricominciare una vita lontana dalla casa che le ha portato via qualcosa per sempre, lasciando così la sua amica definitivamente sola.

Si precisa così, forse scandalosamente, il centro del romanzo di Mauvignier: se lo stupro di una donna costituisce il “buco nero” di ogni discorso – tanto da non essere mai esplicitamente nominato –, le parole che si accumulano intorno finiscono per esplorare un’altra esperienza di sofferenza, apparentemente meno radicale, ma forse più profonda. I monologhi interiori di Catherine e dell’uomo che ha violentato Claire finiscono per costruire una mitologia della solitudine, sostenuta su una dicotomia alla quale non sembra esserci alternativa: «Ci sono quelli che sanno e poi ci sono gli altri, quelli che conoscono solo il dolore di essere umiliati per ricordarsi di essere vivi».
I personaggi di Mauvignier, qui come in altri romanzi, appartengono alla seconda schiera: sono emarginati e sconfitti, guardano gli altri vivere, inchiodati a un tempo che non scorre. Uomini e donne che vivono di piccole disperazioni e silenziose ipocrisie, mescolano l’insofferenza nei confronti della propria stessa inezia con l’odio per l’indifferenza altrui. Incapaci di vivere con gli altri e per gli altri, giustificano i propri rancori con il bisogno di proteggersi. Abituati a obliterare ogni sentimento per non dover provare il dolore di scoprirlo vuoto, sono condannati – si condannano – all’insignificanza e non possono far altro che rubare agli altri la gioia che non saprebbero vivere («il dolore di sapere che rubo a Claire ciò che lei crede di condividere»). Invidiano tutto degli altri, anche quanto c’è di più osceno e inconfessabile: «la cosa peggiore è che della mia vita non c’è niente da raccontare».
Si può arrivare ad augurarsi uno stupro? Catherine lo fa, trasformando una violenza nella manifestazione più estrema di un desiderio, ma anche nella garanzia più crudele di esistere per gli altri. E l’uomo che ha aggredito Claire non è da meno: la sua è la violenza di chi ha deciso di passare «dalla parte di ciò che fa paura per non essere più fra quelli spaventati». Lo stupro come estrema difesa, ma anche come vendetta verso una ragazza che non si è dimostrata diversa dagli altri: «Perché a un certo punto il fatto di non essere visti ferisce troppo profondamente». Per Catherine come per quest’uomo la vera condanna è nello sguardo degli altri. Ma chi sono gli altri?
Sono quelli che sanno come si vive, ma che non si accorgono che dalla fenomenologia minima dei propri comportamenti dipende la salvezza di chi gli sta di fianco. Sono «ceux d’à côté» – come recita il titolo originale: possono essere degli sconosciuti, incrociati una volta per strada, oppure gli amici, «quelli ai quali si finge di volere bene, no, ai quali si vuole davvero bene perché non ne esistono altri per darti la possibilità di capire quanto vuoi bene a loro», o ancora «gli uomini che porto a casa per avere di che vivere come gli altri, con un domani di rimpianti, gioie e parole da dire – anch’io». Gli “altri” sono quelli che giudicano, con un semplice sguardo o con l’implicito che porta con sé ogni singolo gesto. E anzi, quanto più quel giudizio è implicito, tanto più potrà essere percepito come spietato e severo.
Proprio da qui traggono la loro forza Catherine, l’aggressore di Claire e tutti quelli come loro – come noi. Perché la dittatura dello sguardo altrui diventa anche l’alibi per una continua assoluzione, per il rinvio di ogni confronto: «Perché, ecco, il non sapere degli altri serve a esistere un po’, ad avere il diritto di non essere sempre l’uomo che ha fatto questo o detto quello, né il suo contrario, ma di essere come tutti gli altri». Meglio vivere in un mondo fatto solo di congetture e supposizioni, dove lo sguardo dell’altro riflette sempre una sentenza già nota, anche se crudele.
Il dialogo è una strada troppo accidentata per potercisi avventurare; più conveniente è continuare a vedersi soli contro tutti. E se anche capitasse di incontrare lo sguardo di chi vive la stessa condizione, nulla spingerà a infrangere il muro del silenzio: la parola rimarrà muta, ognuno resterà solo. Se spunta, nel finale, un soggetto plurale, un “noi” che si articola nelle voci di Catherine e del violentatore, è solo per dare un nome a quell’insieme di solitudini che ogni giorno va incontro ai “passanti”, senza essere viste. Senza contatto non può esserci redenzione.
Così la costruzione polifonica del romanzo di Mauvignier non raggiunge una dimensione corale; ogni monologo rimane chiuso in se stesso, avvolto intorno a quell’arbitrario sistema di pesi e contrappesi – di percezioni e sensazioni – da cui sembra dipendere la felicità – mancata – delle persone. A questo livello, dove spesso non arriva la coscienza collettiva, la voce della comunità, può arrivare la parola letteraria, che sfidando le indulgenti assoluzioni dell’autocoscienza così come la retorica di un sentimentalismo a buon mercato riesce a dire la sofferenza e la solitudine che fanno la vita della persone.