L’opera oltre i melomani
Il giro dell’opera in ottanta voci, lo definisce l’autore nella Premessa. In realtà, il nuovo libro di Emilio Sala, docente di musicologia alla Statale di Milano, è molto di più. S’intitola Opera, neutro plurale (il Saggiatore, pagg. 410, € 26,00) e si propone come “Glossario per melomani del XXI secolo” (così il sottotitolo). E tuttavia, il “melomane medio” (la definizione è di quel brillante scrittore di cose operistiche che è Alberto Mattioli) troverà in queste pagine poco cibo per alimentare la sua viscerale passione, quasi sempre marcatamente passatista. Nei lemmi di questa ampia e affascinante “peripezia”, attraverso le forme, i personaggi e gli eventi che hanno fatto dell’opera un fenomeno unico nella cultura occidentale, Sala disegna infatti quella che per molti aspetti appare come una vera e propria “destrutturazione” della melomania. E quindi una sua sostanziale rifondazione. Né per cambiare verso alla sua narrazione basta la sorridente “captatio benevolentiae” autobiografica (alla voce Iniziazione) – nella quale lo studioso racconta l’episodio della sua adolescenza al quale fa risalire il suo innamoramento per il melodramma: quella volta che una burbera ma illuminata professoressa del liceo di Rimini gli imprestò un bel po’ di dischi della Callas, ingresso magico in un mondo fino a quel momento insospettato.

L’opera è troppo complessa e troppo intrecciata con la storia culturale dell’Occidente per lasciarla in esclusiva ai melomani. Il suo futuro è legato alla consapevolezza del fatto che la mediatizzazione della fruizione – per larga parte del Novecento solo sonora - ha sì rinnovato e radicalmente allargato il mito della primadonna e in generale il culto della voce, cardini della melomania fin dall’Ottocento, ma ha prodotto una “sottrazione” nell’idea stessa del teatro musicale (concetto peraltro sottilmente diverso da quello generale di opera, come sottolinea Sala) che soltanto l’avvento nell’ultimo quindicennio del secolo scorso del Dvd, cioè della più avanzata fruizione audio-video prima dell’avvento dell’era dello streaming e di YouTube, ha contribuito a recuperare e almeno in parte a equilibrare.
La struttura operistica è composita come non accade in nessun altro tipo di spettacolo: ridurla unicamente al contesto vocale (e in subordine musicale) significa perdere di vista quello che probabilmente è il motivo della sua resilienza attraverso i secoli, che l’ha fatta rinascere dalle proprie ceneri quando sembrava che le esequie fossero già state celebrate. In essa interagiscono elementi diversi e fra loro collegati, di carattere drammaturgico, scenico, coreografico. La dimensione musicale è funzione di ciò che si vede, e viceversa. Dalla combinazione e dall’interazione di ciascun “opus” nasce l’opera. Il messaggio di questo libro è chiaro: solo se il sostantivo femminile singolare è sottoposto a una sorta di revisione e concepito come il plurale della parola neutra latina che racchiude in sé la più vasta gamma delle attività creative umane, artistiche e pratiche, il futuro del genere rappresentativo nato all’inizio del XVII secolo può considerarsi al sicuro.
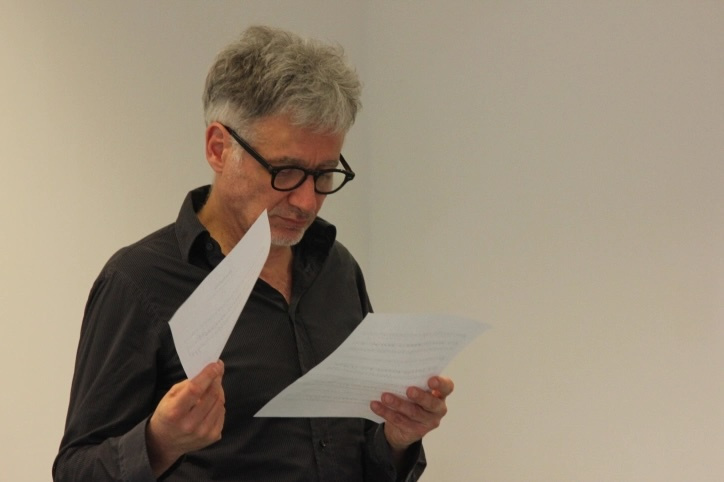
Dalla A di Acuti alla Z di Zeitoper, la proposta di Sala è naturalmente molto diversa da una storia dell’opera e non ne costituisce nemmeno una sorta di enciclopedia sintetica, come l’ordine alfabetico dell’esposizione potrebbe far credere. All’interno del glossario – a fianco di notazioni quasi impressionistiche, o di approfondimenti dotti e felicemente sintetici su particolari della fenomenologia operistica spesso sorprendenti – si riconoscono peraltro alcuni filoni assai nettamente delineati. Uno dei più interessanti riguarda la “prassi esecutiva”, cioè il modo in cui opere di un passato lontano o anche – sempre più spesso – relativamente vicino hanno visto mutare la loro resa musicale nel corso del Novecento e nei primi decenni di questo secolo, nel perseguimento di una ipotetica “versione originale”. Tic e tabù delle cosiddette Historically Informed Performances (alla voce HIP) s’incrociano con gustose ricostruzioni di pratiche esecutive antiche e specialmente dell’Ottocento (il secolo lungo dell’opera) e del primo Novecento. Un profilo storico composito, che ha il merito di chiarire le opposte esagerazioni dei fautori della tradizione esecutiva otto-novecentesca e di coloro che ritengono sempre e comunque plausibile un’esecuzione astrattamente “filologica”. Il punto di incontro in queste guerre di “religione esecutiva” – argomenta molto saggiamente Sala – consiste nel non perdere mai di vista il fatto che ogni opera ha una propria storia esecutiva, fin dalla prima assoluta, che non necessariamente coincide con quanto scritto nella partitura autografa, ma che comunque costituisce un elemento “autentico”, tanto quanto erano concrete e pressanti le non aggirabili leggi del sistema rappresentativo delle origini.
Quanto alla regia, essa è messa a fuoco nei suoi sviluppi storici non meno che nell’evoluzione dell’ultima e più controversa fase, quella che in nome del “Regietheater” nato in Germania durante gli anni Settanta (non per caso specialmente nel contesto dei drammi musicali di Wagner) ha portato la figura del regista a un ruolo primaziale, tale da scavalcare – con grave scandalo dei melomani più radicali – la storica preminenza dei cantanti e del direttore d’orchestra.

I più importanti operisti del secondo Ottocento e del primo Novecento (Verdi, Wagner, Puccini…) avevano sempre avuto un occhio di assoluto riguardo e nel caso del tedesco una funzione decisiva nella realizzazione teatrale dei loro lavori, ma dopo gli anni Dieci la figura del direttore d’orchestra ha assunto un ruolo centrale e totalizzante, mentre quella del regista ha cominciato a prendere piede solo dopo la Grande Guerra, e molto cautamente. Oggi, ammainate le ideali bandiere dei demiurghi dell’esecuzione musicale, l’avvento del “Regietheater” – nota acutamente Sala – ha finito per delineare una sorta di dissociazione fra le ragioni delle esecuzioni “storicamente informate”, con il loro sguardo rivolto all’epoca in cui l’opera ha visto la luce, e quelle di rappresentazioni di gusto post-moderno, attente alle ambiguità di genere, attualizzanti, fortemente mediatizzate. Una dissociazione che non di rado provoca forti ripulse da parte dei melomani, spesso coalizzati nell’agorà dei social, terreno fertilissimo di qualunquismo pseudo specializzato.

Il glossario proposto da Sala (in parte derivante, con ovvi ampliamenti, da una rubrica tenuta per un paio di anni sul mensile di informazione musicale Amadeus) è configurato in maniera tale da non evitare nessuno dei temi caldi del discorso operistico odierno, sia dal punto di vista degli spettatori che da quello degli studiosi. Per citare i titoli di alcune voci, in questo libro si parla di Kitsch e di Mammismo, di Castrati e di Controtenori, di Political Correctness, di Claque e di Dilettanti, di Unesco e di Festival, di Fiaschi e di Primedonne. E tuttavia, nella varietà dei temi resta sempre evidente l’obiettivo dell’autore, al quale con tutta evidenza sta molto a cuore – e non si può che consentire – la conservazione anche nel XXI secolo del bene culturale chiamato opera.
In molti casi, gli argomenti storico-musicologici sono sostenuti anche da un approccio metodologico di natura psicoanalitica, con Jacques Lacan come nume tutelare. Per capire le ragioni di una persistenza come quella operistica, che ha un carattere spesso irrazionale, è in effetti utile un ragionamento nel quale gli elementi formali, estetici e storici vengano illuminati anche da approfondimenti su quanto di inconscio caratterizza l’appropriazione di un “prodotto culturale” così particolare.

Centrali appaiono le argomentazioni su due elementi decisivi, la nascita dell’opera e la sua spesso proclamata morte. Il tema delle origini, annota Sala nelle Riflessioni conclusive, è questione storica e musicologica tuttora oggetto di discussione: c’è chi sottolinea le radici neoplatoniche oltre che tragiche del nuovo genere, nell’aristocratica Firenze della Camerata de’ Bardi all’inizio del Seicento; ma c’è chi vede in esso (probabilmente con maggiore ragione) la confluenza di gusti teatrali compositi e spesso popolari nella Venezia dove entrò in funzione il primo teatro pubblico della storia, nel 1637.
Il discorso sull’altro tema è condotto in fervido confronto con un saggio fondamentale come La seconda morte dell’opera di Mladen Dolar e Slavoj Žižek, pubblicato a New York nel 2002 e in Italia da LIM - Ricordi nel 2019. Proclamata defunta più volte durante il XX secolo, a partire quanto meno dalla prima esecuzione dell’incompiuta Turandot di Puccini, alla Scala nel 1926 e poi, per esempio, in occasione della scomparsa di Maria Callas nel 1977, l’opera – argomenta Sala – conserva invece un irresistibile fascino, probabilmente collegato «alla sua supposta, irrimediabile decadenza». Per dirlo con le parole di Dolar e Žižek citate dall’autore, «[…] L’opera è un fenomeno molto più grande e complesso di quanto non lo fosse quando era in vita, e più è morta, più rifiorisce».

Oggi sempre più spesso questo fenomeno rischia di conoscere settarismi e incomprensioni – conseguenza dell’accusa di “scorrettezza politica” che sempre più spesso viene rivolta all’opera, specialmente quella ottocentesca e di primo Novecento. Con il contorno di controverse scelte esecutive e registiche, dalla modifica dei libretti per frasi considerate inaccettabili al rifiuto di usanze come il “blackface” per i personaggi di colore (ad esempio, Otello o Aida) interpretati da cantanti bianchi. La discussione è sempre aperta e spesso polarizzata o estremistica. Rispetto ad essa, Emilio Sala delinea nelle citate Riflessioni conclusive (sorta di sintesi del punto di vista dell’autore e insieme di progetto per la salvaguardia) una sorta di “multilateralismo operistico”, una visione capace di andare oltre le polemiche e i paradossi storico-culturali. Si tratta di concepire l’opera come fatto globale, e a questo proposito appaiono rivelatorie nel glossario le incursioni dell’autore nel Kabuki giapponese e nel Jingju cinese, tradizioni teatrali i cui punti di contatto con il nostro melodramma sono illustrati con ricchezza di argomentazioni e riferimenti storici. E si tratta di aprirsi all’idea che le manifestazioni contemporanee di questo fenomeno – sia per i titoli del repertorio che per le novità – possano arrivare a tenere conto non solo delle culture non occidentali (come, del resto, sempre più spesso la musica colta odierna si incarica di fare) ma anche delle espressioni in linea teorica non “colte”, andando oltre i generi e aprendo i confini della drammaturgia musicale. Solo così l’opera potrà perpetuare il suo miracolo: essere allo stesso tempo antica e attuale, come è accaduto fin dall’inizio della sua storia.
In copertina, una scena di uno spettacolo Kabuki.







