Speciale
Atlante occidentale / Emancipazione
Poche settimane fa, ascoltando Radio Radicale, mi sono imbattuto in un’intervista a Fausto Bertinotti che esponeva le sue attuali idee – radicalissime – sul futuro della sinistra. Confermando le convinzioni maturate negli ultimi anni, il già segretario di Rifondazione ha ripetuto che è inutile cercar di tirare qualche filo rimasto impigliato nella storia del movimento operaio novecentesco: il ciclo aperto dalla rivoluzione d’ottobre, che da noi ha avuto gli effetti più rilevanti nel contributo comunista alla costituzione e nel welfare del secondo dopoguerra, è ormai chiuso per sempre. Chi prova a tornare su quei passi, non importa con quale acrobazia autocritica, viene subito intrappolato in una logica di eresie e scissioni prive del referente che dava loro un senso autenticamente drammatico.
Accanto alla sinistra legata al marxismo, Bertinotti citava con la consueta affabilità quella liberale, riconoscendone da estraneo i tratti e gli apporti più nobili; e con un certo pathos ricordava il ruolo del cattolicesimo democratico. È un quadro che fa riflettere; tanto più che a delinearlo non è un vecchio togliattiano e nemmeno, in origine, un membro della minoranza Pci, ma un dirigente sindacale cresciuto nel milieu socialista di Riccardo Lombardi. L’ex leader, ritiratosi nei pensatoi dei tempi lunghi, accusa la nostra epoca di scarsa memoria; eppure anche lui sembra dimenticare qualcosa. Perché la storia della sinistra non coincide con l’album di famiglia marxian-lenin-gramsciano e con le sue lotte intestine; né ora che le forze capaci di cambiare lo stato di cose presente passano sopra le nostre teste, e gli antichi litiganti progressisti si ritrovano a chiacchierare in un malinconico clima da polisportiva, si può credere di completare questo album dando l’onore delle armi a qualche allievo di Salvemini. Il fatto è che la vicenda del movimento proletario non comincia con il secolo breve, non s’incarna per la prima volta nell’antideterministica declinazione leniniana di un socialismo abusivamente detto “scientifico”: anzi, semmai è proprio tra le macerie della Grande Guerra che finisce la sua stagione più libera e più viva, e che s’inaugura l’epoca della malafede dominata dai comitati centrali, dalla caccia alle streghe riprodotta fin nel più sparuto gruppuscolo eretico, dalla perversa unione di una cultura ridotta a dottrina e di una politica ridotta a culto del fatto compiuto (molto più che da Gramsci, il quale malgrado l’“innocenza” del prigioniero è già tutto interno al nuovo corso, le tragiche contraddizioni di quel passaggio sono testimoniate dal destino di Rosa Luxemburg).
Se oggi, come un personaggio di Flaubert, il Socialismo si voltasse indietro, se si alzasse sulle punte per vedere al di là dei suoi eredi soltanto nominali, dei suoi nipotini rampanti e dei suoi figli settari, se scavalcasse con lo sguardo i gesuiti del marxismo novecentesco, i cadaveri della rivoluzione d’ottobre e del leninismo... alla fine non scoprirebbe forse che i suoi momenti più alti sono stati proprio quelli del vituperato, “stupido” ponte tra XIX e XX secolo? Non dovrebbe glorificare il periodo dell’ingenua Seconda Internazionale, delle leghe ancora un po’ bakuniniane o mazziniane, delle università popolari e delle dispense positivistiche, dei contadini, degli operai o degli artigiani autodidatti che avrebbero poi conservato a lungo nei bauli un Hugo e uno Zola, un Gorkij e un London? E non dovrebbe ammettere, il nostro allegorico personaggio, che il meglio della sua biografia novecentesca sta nell’eredità dell’Ottocento, ancora impregnata di quelle tradizioni “non scientifiche” di cui si è voluta dannare la memoria?
È l’eredità che anche il marxismo da politburo ha dovuto conservare quando, come in Italia, la sua rappresentanza ufficiale è divenuta una grande agenzia di educazione collettiva, e in alcuni contesti una bandiera autorevole sotto i cui simboli le classi povere e vessate potevano invocare un po’ di giustizia. Penso alla vita tenace e multiforme delle case del popolo, ai circoli operai intitolati a Francesco De Sanctis, a quelle scuole di partito che per molti sono state, per fortuna, prima e più scuole che partito; e penso soprattutto alle lotte dei Placido Rizzotto, dei Pio La Torre e dei Giuseppe Di Vittorio, condotte in condizioni nelle quali fare la rivoluzione significava semplicemente rivendicare la dignità umana (quante volte, proprio a Radio Radicale, ho sentito Bordin e Macaluso ricordare a Pannella che essere comunisti nella Sicilia degli anni Quaranta o Cinquanta voleva dire essere molto più liberali di quei liberali di nome che erano i latifondisti, cioè gli ignobili galantuomini immortalati da Sciascia nelle Parrocchie di Regalpetra).
Certo, sappiamo bene che per le sanguinose doppiezze della Storia quest’epopea è stata favorita anche dalla minaccia sovietica: il rovescio del progresso ottenuto a ovest era l’oppressione a est. E sappiamo anche che, per un’astuzia della ragione storica in apparenza meno truce o più beffarda, l’espansione dei diritti sociali si è a poco a poco ridotta alla gestione amministrativa e corporativa degli interessi; che dal boom in poi, sotto le parole d’ordine nazionalpopolari, ha iniziato a verificarsi una metamorfosi infinitamente più pervasiva delle istanze politiche, e destinata a cancellare ogni alternativa all’esistente: quella omologazione che secondo Pasolini ha trasformato i comunisti in consumisti appena più civili della media.
Eppure, se si riavvolge il film, si vede che la miglior parte della storia in senso lato socialista è storia delle lotte cooperative che oggi andrebbero riconcepite per un genere completamente diverso di esclusi, per un volgo disperso che non ha ancora nome; che è insomma la concreta, varia opera “ottocentesca” tesa a migliorare le condizioni dei “miserabili” e nutrita dalla fiducia vaga ma vasta e realmente sentita in una palingenesi. Il Novecento ci ha insegnato a diffidare dell’idea moderna di rivoluzione, con la sua metafora inadeguata e violenta della società come macchina; ma altra cosa da questa finta scienza è l’utopia che alimenta senza fanatismi i comportamenti quotidiani, la speranza che fa tutt’uno con la umana necessità di giustizia. Se l’ipotesi di una trasformazione radicale del mondo viene disinvoltamente rimossa dal dibattito pubblico, come si è fatto negli ultimi trent’anni, non può non riapparire poi in forme mostruose: ed è appunto ciò che sta avvenendo con i demagoghi a cui non si vorrebbe riservare il nome di populisti, per non sporcare una nobile vicenda di epoche remote e anche per non rinnegare una vocazione in certa misura fisiologica di ogni politica impegnata a occuparsi di chi sta in basso. “Ai pazzi e agli squilibrati si apre la possibilità di una copertura rivoluzionaria perché abbiamo trasformato l’idea della rivoluzione in una follia”, ha annotato Walter Siti in un suo romanzo di sapore gnostico.
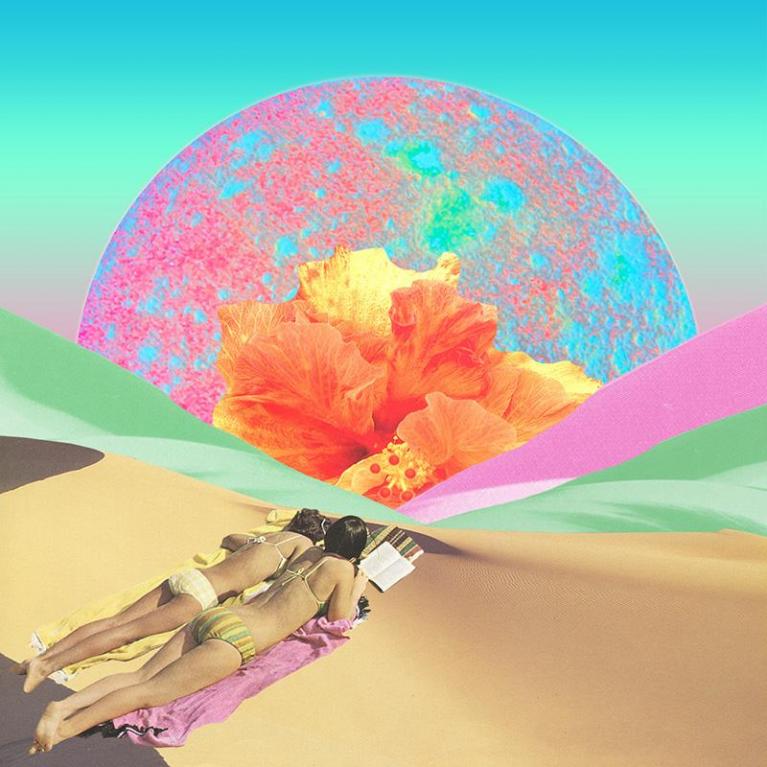
Leaf and Petal Design.
S’intende che della latitanza di una tale ipotesi occorre discutere con tutt’altri mezzi interpretativi rispetto a quelli dei due secoli alle nostre spalle: il groviglio di fedi e ideologie del diciannovesimo ci è lontano quanto il marxismo più sottile, sofistico e arlecchinesco delle tarde accademie del ventesimo. Ma al di là dei mezzi, la revisione deve toccare un altro punto. È sempre urgente costruire una duttile teoria della prassi in cui inquadrare le proprie azioni, che altrimenti vanno disperse, ed è utile anche elaborare filosofie magari raffinatissime per interpretare il mondo: a patto che non si pretenda di nuovo di cambiarlo, il mondo, tramite una loro applicazione ingegneristica. Ecco: malgrado Bertinotti inviti a ripartire da (quasi) zero, nel suo discorso echeggia immutata una vecchia idea del rapporto tra azione politica e cultura: e proprio lì si annida il virus che porta alle mistificazioni.
Tanto per capirci, riassumiamo il problema con un nome. Il Gramsci storico e interprete della nostra civiltà non sarà mai meditato abbastanza; ma il Gramsci figlio sprezzante del primo Novecento volontaristico e idealistico, che culturalizza la prassi con un integralismo gentilian-leniniano destinato a esiti o autoritari o fumosi, va lasciato senza scrupoli al suo tempo. Fuori dalla cella, l’intellettuale organico non può incarnarsi se non in una corporazione di tartufi, che i loro figli operaisti rispecchieranno mentre li rinnegano con mosse edipiche da piccoli demoni dostoevskiani.
E per continuare coi nomi emblematici: oggi attuali non sono né Togliatti, né le eresie pseudomarxiste modellate sull’archetipo trockista e affogate in una salsa scolastico-apocalittica di French Theory o in un pubblicitario sincretismo arcobaleno, né ovviamente la terza via di Giddens. Oggi, nello spirito se non nella lettera, attuale è il sindacalista e sindaco di Molinella Giuseppe Massarenti, riformista nell’abitare le istituzioni e intransigente nell’organizzare le battaglie frontali contro il potere economico dell’Emilia tra Otto e Novecento, una terra dove i lavoratori passavano quattordici ore in risaia per paghe da fame, e i braccianti dovevano ricontrattare l’ingaggio stagione dopo stagione davanti a padroni che minacciavano il sequestro delle grandi tenute.
Adriano Sofri osservava di recente che in alcuni quartieri delle nostre città un embrione di welfare sta rinascendo intorno ai centri sociali. Le loro esperienze più felici non rappresentano più un ribellismo giovanilistico nato sui detriti ideologici del Novecento, e l’ironia dei tempi li costringe a onorare letteralmente il proprio nome: nei loro stanzoni, spesso strappati al degrado o agli speculatori, i gestori di collettivi come il bolognese Làbas dànno asilo ai bisogni più diversi tessendo reti tra generazioni, ceti e culture, e incollando i cocci di realtà atomizzate da quella crisi dei corpi intermedi e delle istituzioni che sta mutando i comuni in signorie. Solo che chi svolge questo lavoro meritorio, aggiungeva giustamente Sofri, sulle questioni internazionali coltiva quasi sempre idee irresponsabili. La nuova sinistra – minuscolo, per carità – dovrebbe quindi comporre gli slanci conviviali di Làbas e i programmi europei di Emma Bonino: un’unione difficile, salvo che sul tema pure decisivo dei migranti; ma comunque, sia chiaro, un’unione che non ha niente a che vedere col liberalsocialismo novecentesco e le sue élite, né con la polverosa sintesi tra massimalisti e riformisti.
Anche Bertinotti, alla fine dell’intervista e altrove, ha parlato di mutuo soccorso, e di una sinistra che va riorganizzata a macchie intorno a urgenze circoscritte (e qui si potrebbe rimandare alla tradizione americana del community organizing, che Diego Galli, fino a pochi anni fa dirigente radicale, sta caparbiamente cercando di importare in Italia). Tuttavia, malgrado inviti a sfuggire le panie del Novecento, basta ascoltare l’ex leader di Rifondazione per capire che come troppi è ancora legato a una concezione marxianamente organicista, sebbene via via più generica, nella quale intervento politico ed elaborazione culturale finiscono per rendersi irreali a vicenda. È questa concezione che ha indotto a sottovalutare costantemente le tradizioni antiche e libere del socialismo non (solo) marxista, o comunque precedente alla leninizzazione e all’hegelizzazione subìta dalle sinistre dopo il 1917 e dopo la violenza nichilista scatenata dalla Grande Guerra. Siccome poi la storia la scrivono gli intellettuali, si capisce perché una tale sottovalutazione sia arrivata fino al disprezzo: quelle tradizioni non possono gratificare chi è irresistibilmente portato a confondere le parole e i gesti, le teorie e i fatti, le Aufhebungen verbali e le circostanze reali la cui verità impietosa può essere registrata solo da un limpido occhio orwelliano.
L’effetto di tutto ciò, per dirla marxianamente, è l’accumulo di un enorme capitale di falsa coscienza, problema che un marxismo ridotto a scolastica universitaria non frequenta volentieri, temendo comprensibilmente di guardarsi allo specchio e di segare il ramo su cui è seduto.
Ma ora che gli ex comunisti di ogni genere e provenienza rimuginano per l’ennesima volta sul passato, sperando di cogliere le cause prime della deriva, bisogna ricordare che le particolari condizioni della vita politica italiana hanno incentivato nell’intera sinistra anche un altro tipo di ideologia. Le radici dell’impasse mi sembrano più vecchie del post-comunismo, della svolta “neoliberale”, e anche del moralismo berlingueriano, ombra ambigua di un Pci che col suo corpaccione si adagiava intanto nella palude partitocratica. La sua schizofrenia affonda infatti nelle scelte dell’assai meno moralista Togliatti, comunque la si pensi sul loro grado di fatalità. La doppiezza comunista, in Italia, ha permesso ai militanti di pensarsi rivoluzionari (senza le crude responsabilità del caso) e di agire da socialdemocratici goffi, impotenti, o invece fin troppo efficaci nel ridurre la politica ad amministrazione: ha generato, cioè, un’autorappresentazione mistificatoria ereditata anche dalla Nuova Sinistra e da tutte le sfumature dell’arcobaleno post-marxista fino a ora. Risultato: la doppia sterilità di un movimentismo velleitario e di uno speculare riflesso da uomini d’ordine che rende, diciamo così, più realisti della legge Reale (ne sa qualcosa Minniti). In mezzo, a restare schiacciati, sono le riforme pragmatiche ma coraggiose e lo stato di diritto.
Oggi, credo, è più che mai necessario lasciarsi alle spalle questa schizofrenia. Ma soprattutto, adesso che la comunicazione web inghiotte qualunque evento, e si rivela l’unica rivoluzione in grado di trascinare chi non la segue di sua spontanea volontà, bisogna smettere di mischiare le carte, di scambiare le caricature promozionali dell’engagement (l’eterna ricerca del padre nobile, dell’intellettuale da ingaggiare come leader) con le esigenze di una politica che quando è degna ha tempi diversi sia da quelli dei media onnipervasivi sia da quelli della cultura, la quale se si esprime davvero si esprime senza scopi, “gratuita” e socratica, e solo così, per vie mediate e inimmaginabili, può fecondare la mentalità dei cittadini impegnati nell’azione pubblica. Senza dubbio, lo ripeto, occorrono anche analisi politiche sottili; occorre nominare con esattezza e collegare soggetti soli e dispersi, e colmare la distanza tra i valori sbiaditi in campo lunghissimo e i cinismi di dettaglio della tattica quotidiana. Ma per farlo bisogna appunto evitare di confondere i piani, non usare le suggestioni culturali come droghe, sapere che il cuore più reale e dunque “scientifico” da cui nasce la sinistra è il moto elementare della giustizia, così come il moto elementare da cui nasce l’illuminismo che l’ha fecondata è la ricerca della verità. Ecco perché se devo scegliere, come mi è stato chiesto, una parola che vorrei fosse custodita dalle sinistre residue in questi anni di deserto, una parola-radice che può durare al di là di tutte le loro vicissitudini storiche e i loro fallimenti, mi viene subito in mente “emancipazione”. Emanciparsi vuol dire sottrarsi a un’alienazione, a un possesso estraneo che ci riduce a cose.
Vuole dire togliersi di dosso le catene, non solo quelle economiche o immediatamente visibili ma anche quelle dei moderni sogni prometeici, che per la nota dialettica dell’illuminismo hanno prodotto nuovi mostri e nuove alienazioni. Vuole dire, di conseguenza, provare a cambiare radicalmente quella specie di incubo girardiano che è divenuta la società virtuale: imparare che la libertà sta nella misura, e che ciò che appare illimitato non migliora il mondo ma lo trasforma in proiezione, in fantasma, e dunque produce violenza. L’emancipazione comincia dalla riduzione dell’irrealtà, dall’amara presa d’atto di un destino che esige una lotta mai finita e sempre reversibile. Implica la coscienza del fatto che agire e riflettere, anche se si auspica siano connessi, non sono la stessa cosa; né si possono fissare per le due attività gli stessi criteri senza svilirle entrambe. Emanciparsi significa ricordare che un ordine collettivo più giusto si strappa giorno per giorno attraverso un’organizzazione efficace ma non totalitaria dei bisogni di chi è oppresso, mentre dalla caverna di Platone si esce uno alla volta.







