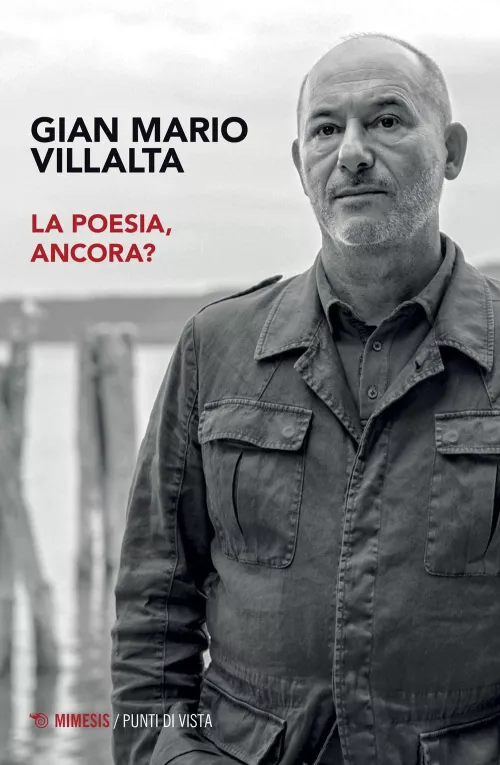Un saggio di Gian Mario Villalta / La poesia non è uno sparo
Il titolo del saggio di Gian Mario Villalta, La poesia, ancora? (Mimesis, 2021), è spiazzante e ambiguo. Da un lato, potrebbe suonare come la reazione infastidita di un potenziale lettore (“Santo cielo, si parla di nuovo di poesia?”), dal lato opposto come un’interrogazione meravigliata sul permanere della poesia nel nostro mondo, nonostante tutto. Chi legge è portato subito – com’è ovvio – a propendere per la seconda interpretazione, e a considerare la prima un espediente retorico, una provocatoria anticipazione – esorcizzazione del disincanto di chi “la sa lunga” (o crede di saperla).
Il libro è articolato in quindici capitoli, e costituisce una sorta di apologia della poesia, di sua rinnovata, appassionata legittimazione. Villalta parte da considerazioni e argomentazioni storiche, estetiche e antropologiche, con riferimenti che vanno da Heidegger al Futurismo, da Dante alle neuroscienze. Nelle prime pagine emerge innanzitutto la distinzione tra il fare proprio della poesia e l’agire comunemente inteso: l’arte è danza che si distingue significativamente dal nostro quotidiano camminare, dal muoversi, dal gesticolare.
La poesia viene definendosi negativamente, in contrasto con i pregiudizi circolanti: non ha a che fare con la cosiddetta “creatività” e neppure con la “comunicazione” (men che meno con l’informazione, o – aggiungerei – con la predicazione di “valori”). Più avanti l’autore dichiara: “La lingua non è fatta per comunicare, ma è il luogo proprio dell’esistenza dell’animale parlante; così la poesia non è comunicazione, ma una forma che mira all’eccellenza della lingua, ovvero a realizzare con le parole il luogo dove permane l’evidenza della sua tensione all’esistenza nella sua più alta possibilità”. (In questa prospettiva, anche l’idea di Jakobson della poesia come messa in atto della “funzione poetica” del linguaggio viene respinta).
Villalta contrappone a più riprese la “superficialità dell’empatia istantanea”, quello che chiama il “meccanismo di sparo” proprio della comunicazione, cioè la ricerca di un effetto immediato, alla pratica della poesia, che è quella – scrive – di un indugiare intenti.
Una delle questioni centrali del libro è il rapporto tra oralità e scrittura. “La parola è voce (…): ben presto però siamo capaci di separarla dalla nostra voce e da quella degli altri per farne un’entità differente, autonoma”. La poesia è sostanzialmente un fare i conti con ciò che potremmo chiamare “oggettivazione” o “esteriorizzazione” della parola, un metterla in opera. Fin dai primi capitoli l’autore si sforza di difendere le ragioni della pagina scritta, in contrapposizione (implicita, fino a un certo punto) con l’oralità e con la presenza fisica dell’autore che dominano nella comunicazione massmediatica. E si chiede ad esempio: “Perché (…) millenni di arte della parola scritta? È accaduto soltanto per l’opportunità di conservare e trasmettere l’espressione verbale?” La risposta, naturalmente, è no. La parola scritta non è un semplice mezzo “tecnico” di conservazione del testo: è ciò che permette alla poesia di realizzare la sua natura essenziale, quella di essere, cioè, composizione. Da un certo momento in avanti, la poesia – e quella moderna in particolare – è sostanzialmente un testo scritto, stampato. La natura diciamo così tipografica dell’arte della parola, la possibilità di una “oggettivazione” del testo, da cui si genera appunto il suo carattere essenziale di composizione, è però anche la fonte di non pochi problemi, che investono il ruolo stesso della poesia, e conducono alla sua crisi attuale.
Nel settimo capitolo, a partire da un’inchiesta promossa da F.T. Marinetti per la rivista “Poesia” (1905), Villalta mette a fuoco la questione del cosiddetto “verso libero”, della libertà di ogni autore, cioè, di modulare il ritmo di ciò che scrive secondo la propria individualità, rifiutando gli schemi codificati. Prima di questa “liberazione” che, iniziata nel tardo Ottocento, ha preso piede nel corso del Novecento e oggi è data per scontata “L’individualità si esprimeva all’interno di una stessa ‘lingua’ poetica. Quando esprimere un’individualità significa invece porre in questione la ‘grammatica’ (ovvero l’aspetto normativo convenzionale) di questa lingua, non si tratta più di accedere a una libertà che riguarda la varietà dell’espressione (…) quanto piuttosto di inscenare sulla pagina un’interrogazione radicale, ponendo un problema che non è più di metrica ma di estetica, quello dei limiti della poesia rispetto a ciò che non è poesia”.
Proprio questo, mi pare, è il problema che la poesia contemporanea si trova ad affrontare. In gioco non è solo la forma del testo, ma l’identità stessa della poesia, la sua specificità, il suo proprio.
Più avanti, Villalta individua un altro passaggio storico in direzione della crisi attuale, con particolare riferimento alla situazione italiana: “La differenza (…) tra ‘lingua della letteratura’ – e più ancora della poesia – e ‘lingua parlata’ trova nel Novecento un punto di rinnovamento radicale quando, tra gli anni Sessanta e Settanta, una lingua comune di riferimento viene riconosciuta e praticata dagli italiani sull’esempio dei mass media e in particolare della televisione (…)

Proprio negli anni Settanta, però, si raggiunge un punto di rottura, oltre il quale non è più possibile, da un lato, ignorare la lingua viva e, d’altro lato, questa lingua viva, le sue parole, il suo sound, il gesto espressivo che veicola, non accettano più le forme affinate per una tradizione che offriva alla poesia un terreno linguistico speciale”. E aggiunge: “È stato in questo frangente di tempo che, paradossalmente, ha trionfato il formalismo e insieme si è perso ogni orientamento formale, o meglio: si è smarrito generalmente il senso della forma che mette in opera il fare poesia”.
Nella situazione attuale, questa mancanza di senso della forma ha raggiunto limiti estremi. Oggi “è diffusa la convinzione che la poesia sia legata a una condizione interiore che nulla ha a che fare con la coscienza artistica. Nessuno si sognerebbe mai di immaginare qualcosa di analogo per la musica e credere che, una volta raggiunta una certa dimensione dell’interiorità, chiunque non abbia mai messo mano a uno strumento musicale si possa sedere al pianoforte e far sgorgare le note di una sublime composizione. Per la poesia invece sì. D’altra parte, non è vero che usa le stesse parole che usiamo sempre, anche nei sogni? Dov’è l’‘arte’? Si capisce che per scrivere un sonetto qualcosa bisogna imparare, ma di quelli non se ne fanno più!”.
A queste considerazioni sulla condizione dell’arte della parola, arte apparentemente alla portata di tutti (che mi hanno fatto pensare a certi aforismi di Karl Kraus) si aggiungono quelle sul confronto impari della poesia con la cultura pop, con la sua fusione caratteristica tra corpo dell’artista e opera (Villalta la chiama funzione rock star). Il poeta è esposto alla tentazione di seguire quella strada, di muoversi verso un ambito in cui “All’abbandono della coscienza formale della poesia si sostituisce la vicenda di un corpo-psiche, che spesso vale come testimonianza della validità di un’esperienza”. La “liberazione” del verso, la perdita del senso della forma, la rimozione di ogni tradizione di riferimento, portano a un diffuso dilettantismo, a una sorta di spontaneismo che mette in primo piano “emozione” e “comunicazione”, sostituendoli a ogni ragionamento, ad ogni “indugio”, e facendo prevalere “il gesto o il dato biografico”.
Villalta, evidentemente, si colloca sul versante opposto. Il che non significa, però, che propugni un ritorno acritico alle forme classiche.
“La conoscenza e l’esercizio delle regole tradizionali di versificazione, la coscienza dell’evoluzione delle forme poetiche, i cosiddetti ‘ferri del mestiere’ – si chiede – sono i presupposti sufficienti per fare poesia? La risposta è semplice: no. Ma hanno una loro ragione di necessità”. Questa “necessità”, un tempo fuori discussione, oggi è largamente ignorata dalla maggioranza dei facitori di versi (in particolare i “poeti da web”, direi, ma anche i cantautori e i rapper/trapper), che si affidano per lo più a una presunta immediatezza del rapporto tra autore e lettore, fondato su un’empatia che esclude ogni rapporto e ogni confronto con la tradizione. Ciò che si ricerca è l’effetto immediato, il “messaggio” che a colpo sicuro arriva a destinazione, lo “sparo” appunto, che coglie il bersaglio senza mediazioni.
Villalta cerca di delineare un diverso fare, caratteristico della (autentica) poesia: “scrivere/leggere una poesia – argomenta – è un ‘sostare’ in quella dimensione in cui la percezione del vissuto è sospesa e aperta; ma non si tratta di un sostare inerte, bensì di un coinvolgimento nell’operare dell’opera”.
Inevitabilmente, la riflessione ritorna sulla principale “rivale” della poesia (scritta): la canzone. Da anni quelli che io chiamo i “canzonisti” vanno ripetendo che la poesia è originariamente cantata (Omero, i trovatori provenzali, ecc.) e “dunque” la parola in musica ne costituirebbe la forma più genuina. “Ma – si chiede Villalta (e io stesso me lo sono chiesto in varie occasioni) – se nasce così opportunamente ‘vestita’, per quale motivo, in un tempo tutto sommato allora breve, la forma scritta prevale fino a diventare finalmente del tutto autonoma? Se la presenza della musica fosse davvero un ‘di più’, perché si sarebbe andati incontro a un ‘di meno’? Forse perché la poesia ha la sua musica. Forse perché la voce della poesia non è di qualcuno che ‘a voce viva’ la dice, ma è interna alla composizione della lingua scritta”. E ancora: “Come è più facile rilevare quanto la voce viva sia più efficace della scrittura, così viene quasi istintivo pensare che la voce intonata con la musica dia alle parole ancora qualcosa di più. Non è qualcosa di più. Né qualcosa di meno. È un’altra cosa, che potrà anche piacere di più, ma non è poesia”.
La crisi della poesia, intesa come poesia scritta, crisi legata in un primo tempo alla progressiva rimozione dei limiti formali, si configura oggi come dilagante prevalenza della dimensione orale, della parola cantata, radicata in un corpo, in una persona fisica. “La questione – scrive Villalta – è il legame tra parola e scrittura e il fatto che la poesia chiede da secoli di essere considerata in quanto composizione nella forma della scrittura. Allora siamo invitati a insistere sulla differenza tra voce viva e scrittura (…) Quando ascolto la parola detta, che mi arriva attraverso la voce viva di un altro, a portata d’orecchio o registrata, riconosco un’identità, un’impronta che veicola determinate caratteristiche che comportano effetti specifici sulla mia percezione e sulla mia psiche. Abbiamo aggettivi per descrivere le voci e intere frasi per dire l’effetto che ci fanno. Si usano per i cantanti e per gli attori. Quanto più sono particolari, tanto più sono riconoscibili e determinano già di per sé una relazione tra un ambito di senso e il ‘testo’ veicolato. La capacità di esaltare i valori di un testo è, però, direttamente proporzionale a quanto altri valori risultano depressi”. Ecco il meno che accompagna il (presunto) più della parola pronunciata, musicata, cantata. Si tratta – argomenta Villalta – di essere liberi di ascoltare la voce del testo.
Di chi è, la voce del testo? Non è la voce dell’autore. “La voce del testo (…) è quella che l’autore ha composto dentro il testo”. “La composizione dell’autore è la sua voce esposta, nella lingua, alla voce di altri che diventa voce di un altro che è il testo stesso”. Si tratta insomma, per il lettore, di ascoltare quella che Villalta chiama voce dell’opera. “La voce viva – scrive – si estingue nel testo, per configurare una voce nuova, altra, irriducibile a qualsiasi voce viva che la pronunci (…) La voce si estingue per rinascere attraverso la lettura come voce altra del lettore (…) Il poeta diventa voce di sé e di un altro come per il lettore la poesia diventa voce di un altro e di sé”.
La necessità di resistere alle derive “pop” ha il merito di costringerci a tornare a riflettere – come i poeti del passato, anche recente, potevano fare senza doversi confrontare con lo spettro di una totale delegittimazione della loro arte – sui fondamenti e sui processi profondi della poesia. E per poesia, Villalta intende senz’altro quella di tradizione scritta, che in questo momento rischia di apparire come una forma desueta, mummificata, di cui si sono smarrite le ragioni essenziali. “Non si tratta – precisa – di tornare agli antichi perché sono un valore o perché offrono insegnamento: è possibile invece comprendere, nella tradizione che gli antichi hanno formato nei secoli, le ragioni e le forze che hanno opposto il perdurare all’effimero, ciò che rinnova la creazione a ciò che la oblitera in una vuota rincorsa verso l’etichettatura dell’istante. Il nostro tempo ha insidiato e pervertito il senso dell’effimero e di ciò che dura”.
Occorre dunque cercare “Non l’ottundimento, la droga del consumo di senso, ma quel sostare inquieto che interroga il sentire e ridà voce al corpo, al percepire la nostra più vera collocazione sul lembo di terra che calchiamo, al pensare dentro le corrispondenze che ci legano a tutte le forme dell’esistere”.