Adorno ce l’ha con il jazz
Se c’è una questione che ha per lo più lasciato perplessi anche i più strenui difensori del pensiero filosofico di Theodor Wiesengrund Adorno è il suo giudizio negativo sul jazz. Le sue critiche alla musica d’intrattenimento in quanto espressione e prodotto dell’industria culturale possono essere accettate o, almeno, comprese senza troppe difficoltà. Certamente c’è stato chi, come Hans Robert Jauss, ha preso le distanze dall’austerità dell’estetica della negatività, che, polemizzando contro l’arte destinata al consumo di massa, ha accusato di irrilevanza e volgarità la nozione di “piacere estetico”. Secondo Adorno, infatti, quella offerta – o piuttosto: propinata – dai prodotti artistici dell’industria culturale è una esperienza degradata, “gastronomica” e “pornografica” che rinnega l’ambiguità enigmatica, utopica e scandalosa che caratterizza l’arte autentica. Tuttavia, questa tesi, per lo meno nella sua unilateralità, può senz’altro essere discussa e precisata; ma, di per sé, con buona pace di Jauss, non è ingiustificata: soprattutto se intesa alla luce dell’idea secondo cui, come Adorno scriveva riprendendo Stendhal, quella offerta dall’arte è una promesse de bonheur, non la felicità tout court. Il che, a ben vedere, è coerente con la concezione dell’arte autentica come fatto a un tempo sociale e autonomo: espressione delle dinamiche sociali, ma non a queste riducibile.
Ora, il jazz non sembra assimilabile ad arte di mero intrattenimento, a mero prodotto dell’industria culturale. Semmai, almeno certe manifestazioni di questo esteso e differenziato campo di pratiche musicali, dalla storia lunga ormai più di un secolo, sembrano poter acquisire lo status di autentica arte, esattamente nei termini dell’idea di autenticità artistica difesa da Adorno. Certo, a volte i filosofi sbagliano. Nulla di strano, dunque, nel fatto che nelle sue riflessioni sull’arte un filosofo giudichi in maniera errata, o per lo meno singolare, opere o artisti. Qui siamo però di fronte a quello che è da molti considerato come il più importante filosofo della musica del Novecento. La sua condanna priva di appello del jazz – del jazz in quanto tale, non di qualche jazzista o di qualche brano o performance – non può lasciare indifferenti.
Il libro Variazioni sul jazz. Critica della musica come merce (Milano-Udine, Mimesis, 2018), curato da Giovanni Matteucci, raccoglie le traduzioni di tutti gli scritti di Adorno sul jazz, offrendo al pubblico italiano l’opportunità di capire meglio il suo verdetto, valutandone ragioni e motivazioni. Si tratta di sette scritti, comparsi nel cruciale ventennio 1933-1953, in cui Adorno analizza l’esperienza della musica jazz, enuclea le caratteristiche specifiche dei suoi materiali musicali e lo sottopone a una critica aspra, impietosa, feroce. Il jazz è per Adorno una musica falsa e mistificante: la “battuta apparente” (paradigmaticamente una scansione ritmica “terzinata” su un tempo in 4/4, per cui la suddivisione 2-2-2-2 è articolata come 3+3+2 ovvero 3 battute in 4/4 possono essere interpretate come 4 battute in 3/4), la mera impressione di una varietà ritmica illusoria (dato che la pulsazione è in realtà fissa), l’inganno di armonizzazioni solo apparentemente imprevedibili, la simulazione del contrappunto, la pseudovocalizzazione strumentale, la pseudoinventività dell’improvvisazione, il carattere militaresco dell’orchestra jazz ecc., sono tutti elementi che Adorno adduce come ragioni della falsità di una musica che spaccia come liberatorio l’incanto inebetente tipico delle merci. Il jazz, insomma, è “merce in senso stretto” (p. 36) che asservisce subdolamente i suoi fruitori all’ordine opprimente del mondo totalmente amministrato.
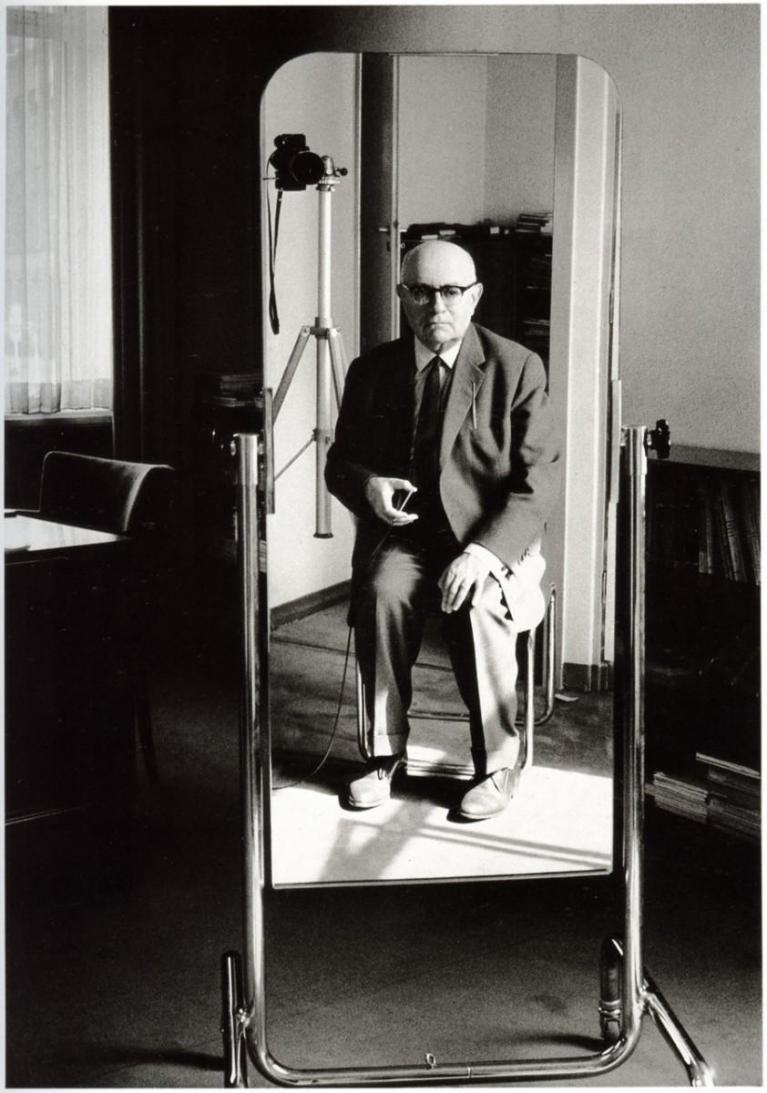
Si è provato in diversi modi a spiegare e a giustificare questo giudizio impietoso. Alcuni hanno osservato che il jazz conosciuto da Adorno era quello delle orchestrine swing degli anni Trenta: musica da ballo e di puro intrattenimento, senza pretese artistiche. Ci si potrebbe però domandare se le tesi di Adorno valgano almeno per la musica da lui conosciuta e, in proposito, potrebbe sorgere seri dubbi.
Altri hanno offerto spiegazioni più filosofiche. Nel suo saggio contenuto nel numero 59/1 (2014) della Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft dedicato all’estetica del jazz (Jazz als paradigmatische Kunstform – Eine Metakritik von Adorno Kritik des Jazz), Georg Bertram ha sostenuto ad esempio che la ragione principale della posizione di Adorno sia da ricercarsi nella sua incomprensione dell’interazione performativa, in particolare in riferimento all’improvvisazione e al ritmo. Il jazz espone la dinamica della costruzione e dell’espressione della soggettività attraverso l’interazione intersoggettiva tipica dell’improvvisazione. A causa del suo rigido e oggettivistico concetto di “legge formale”, Adorno trascurerebbe questa dinamica attribuendo così alla musica jazz una staticità che non ne rispetta il carattere d’interazione performativa.
Inserendosi in questo dibattitto, la prefazione al volume ad opera di Giovanni Matteucci (“Il jazz in Adorno: variazioni in serie”) e la postfazione del traduttore dei testi, Stefano Marino (“Adorno e l’estetica del jazz come pseudos”), offrono un importante contributo per orientare il lettore nella comprensione e nella valutazione delle tesi adorniane. Il fatto che Matteucci e Marino difendano tesi almeno in parte assai diverse è davvero un pregio del volume. Ed è il segno che questa è un’operazione culturale seria e significativa – soprattutto in un periodo in cui anche in Italia la filosofia si sta aprendo in modo efficace a fenomeni artistici come il jazz e l’improvvisazione. Il saggio di Matteucci attraversa le diverse variazioni cui Adorno sottopone il suo rapporto filosofico con il jazz, esplicitando le ragioni del filosofo tedesco e difendendone la coerenza e la plausibilità. Il contributo di Marino è più critico e mostra come Adorno avrebbe potuto capire l’autenticità artistica del jazz, se soltanto avesse attribuito al jazz (o almeno a certe sue espressioni: non si pretende certo sostenere che tutto il jazz sia, in quanto jazz, artisticamente valido) quei caratteri che attribuisce alla musique informelle: lo sviluppo processuale della forma. Tuttavia, il problema è proprio questo, come si è visto: la nozione di forma cui Adorno riconduce la musica jazz non sembra appropriata.
Matteucci legge insieme le diverse pagine adorniane sul jazz e nota come diventi via via più esplicita l’idea che il jazz sia una moda, una zeitlose Mode (moda senza tempo), come recita il titolo del saggio del ’53. Non solo il jazz non esprime la genuinità “naturale” afro-americana, ma piuttosto ne riproduce l’alienazione conforme al sistema vigente; non solo il jazz resta sempre qualcosa di preordinato (ritmicamente, melodicamente, armonicamente), senza lasciar spazio a un soggetto progettualmente utopico; soprattutto, il jazz semplicemente “non è di per sé all’altezza del concetto di arte” (p. 18). Come il romanzo giallo (il paragone è di Adorno), il jazz offre solo una stantia stereotipicità, pronta all’uso e alla vendita. Perciò, semmai, il jazz è arte applicata. Arte finalizzata a un soddisfacimento immediato: arte non autentica; ergo, non-arte. Come scrive Adorno, “il jazz è la falsa liquidazione dell’arte: l’utopia, invece di realizzarsi, scompare dal quadro” (p. 108). Come la moda, il jazz rispecchia e riproduce la realtà sociale vigente: “attraverso l’istituzionalizzazione del sempre-uguale […] le pratiche del jazz socialmente sfociano nel riconoscimento […] di un mondo realistico e privo di sogni […]” (p. 106). Come la moda, il jazz non ha vera storia né la sua è vera temporalità. Come la moda è “senza tempo”, ripete il sempre uguale. Eppure, almeno così sembra suggerire Matteucci, il jazz, se in quanto jazz è appunto falsa arte, mera merce, in quanto musica può sì essere arte, sebbene Adorno non sembri aver elaborato questa prospettiva.
È proprio questa possibilità teorica la chiave adoperata da Stefano Marino per interrogare Adorno. La domanda è sempre la stessa. Perché si è scagliato in questo modo contro il jazz? Conosciamo già la risposta. Essa va ricercata nel “carattere illusorio” che il filosofo tedesco attribuisce al jazz (p. 89), nella sua falsità, ovvero nella sua mancanza di autenticità. Secondo Adorno il jazz spaccia per libera spontaneità improvvisativa “un atteggiamento meccanico nei confronti della forma” (p. 80); esibisce come dinamicità quella che in realtà è una fuga dal tempo “nello stato di quiete del movimento sempre uguale” (p. 81); la sua presunta creatività non è che “l’adattarsi della trasgressione alla norma” (p. 73). La presunta ribellione contro il potere collettivo non è che l’adeguamento a questo potere, il suo rispecchiamento, la sua riproduzione: il jazz è un “amalgama di marcia e musica da salotto” che, però, è un “falso amalgama” (p. 58). Politicamente, esso è (ovviamente) “pseudodemocratico”: “aiuta coloro che sono disciplinati ad avere la coscienza morale pulita” (p. 38) e “l’atteggiamento della sua immediatezza, definibile come un fisso sistema di trucchi, inganna riguardo alle differenze di classe” (p. 38).
La sua espressività, veicolata da un’esecuzione estetica che, appunto, “viene sportificata da un sistema di trucchi” (p. 108) – verrebbe da dire che al linguaggio che Adorno usa per catalogare il jazz si può rivolgere la stessa accusa di standardizzazione uniformante che egli lancia contro questa pratica musicale! –, non è che un piatto adeguamento a strutture che si ripetono meccanicamente; le idee improvvise sono solo “il precipitato delle convenzioni accumulate” (p. 47). Il jazz è perciò “pseudolibero e psuedoimmediato” (p. 58). Non c’è progresso nel jazz: “la sincope non è, come la sua controparte, quella beethoveniana, espressione di forza soggettiva accumulata che si rivolgeva contro quanto era stato posto in precedenza fino a produrre la nuova legge a partire da sé. Essa è priva di meta: non porta da nessuna parte e viene revocata a piacimento mediante uno sciogliersi non-dialettico, matematico, nei tempi metrici” (p. 56), mediante uno sviluppo musicale “indifferente” (p. 44). Anche quel “gusto” che sembra emergere nei suoi rappresentanti più moderni (s’intende: all’apparenza) della musica jazz, come “l’uomo di colore Duke Ellington” (p. 48), è “mero inganno”: rigidità, meccanicità, staticità si nascondono dietro la falsa simulazione di un progresso. Le variazioni dello schema (passaggi hot, break…) non sono che ornamenti che non contribuiscono in nulla alla costruzione formale e, conformemente alla logica capitalistica che alimenta la (pseudo)cultura del jazz, ogni elemento è indifferente e può essere scambiato con qualsiasi altro.
Ecco: le descrizioni di Adorno, e la sua conseguente reiterata accusa di falsità rivolta al fenomeno jazz nel suo complesso sono attendibili? In passato Marino ha già intelligentemente indagato con strumenti concettuali adorniani fenomeni musicali che Adorno avrebbe con tutta probabilità condannato (Frank Zappa, ad esempio). Qui suggerisce che ciò vale anche per il jazz. Il problema risiede semmai per un verso nello schema dualistico che il filosofo applica alla musica (da un lato le musiche fondate sullo sviluppo, dall’altro quelle basate sulla ripetizione) e per altro verso nell’andamento teleologico della adorniana filosofia della storia della musica che individua in Schönberg la meta del progresso del materiale musicale. Sono idee preconcette e infondate; e soprattutto non sono all’altezza della stessa estetica della negatività con cui Adorno sostenta la sua idea di autenticità artistica.
Infatti, che senso ha ricercare nel jazz, e in altri fenomeni musicali diversi dalla tradizione che culmina nella dodecafonia e nella “Neue Musik” (destinata peraltro a invecchiare rapidamente), caratteristiche che hanno altre origini, in tal modo disconoscendo brutalmente gli aspetti specifici di queste pratiche musicali? Adorno non coglie il radicamento del jazz nell’ibridazione di diverse culture musicali (un aspetto ben articolato nel libro del 2008 di Christian Béthune, Le Jazz et l’Occident); fraintende del tutto la fisicità di una musica “audiotattile” (secondo la nozione introdotta da Vincenzo Caporaletti), il cui medium (nel senso di McLuhan) è il corpo, e non la scrittura (perché qui il valore normativo della partitura è diverso rispetto a quello delle composizioni “classiche”); ignora (come si è visto) il potere costruttivo dell’interplay; non comprende minimamente il carattere di straniamento del signifyin’, per cui l’(ab)uso di canzonette e musiche da ballo (si pensi alla My favorite Things di Coltrane, egregiamente analizzata da Ingrid Monson nel suo libro del 1996, Saying Something: Jazz Improvisation and Interaction) genera significati artistici che vanno precisamente nella direzione dell’utopia e dell’enigma che definiscono per Adorno l’arte autentica; non coglie il rapporto tra improvvisazione e formule né quello tra variazione (poli)ritmica e pulsazione swing; e, lasciando perdere molti eccetera, non si avvede del fatto che la normatività retroattiva dell’improvvisazione è quella che egli stesso scorge all’opera nella musique informelle: benché il senso di quanto accade ora sia determinato da quanto avvenuto prima, esso è riconfigurato da quanto accadrà dopo nel corso dell’interazione performativa (cfr. T.W: Adorno, Immagini dialettiche, Torino, Einaudi, p. 258).
È chiaro che la complessità di una sinfonia di Brahms e le modalità di sviluppo del suo materiale musicale non si ritrovano nel jazz; d’altronde, tuttavia, neppure le specifiche complessità di una performance jazz e le specifiche modalità della sua articolazione temporale non si ritrovano in una sinfonia di Brahms. Criticare il jazz per non essere ciò che non è è un errore categoriale: si applica a un fenomeno un ordine normativo scorretto. Sarebbe come criticare Van Gogh perché i suoi quadri non sono quelli di Raffaello. Banalmente lo si può fare, se in questione sono solo le preferenze soggettive; ma da qui ad accusare ciò che non ci piace di ogni sorta di nefandezza e meschinità ce ne passa.
Ignoriamo pure i toni (che oggi suonano tuttavia imbarazzanti) di alcune espressioni di Adorno – “la pelle dei negri, così come l’argento dei sassofoni, è un effetto coloristico” (p. 42); “Il jazz sta ai negri come la musica da salotto del violinista da caffè, che esso crede così fermamente di aver superato, sta agli zingari”; p. 41). Trascuriamo anche la strana tempistica del suo pamphlet contro il jazz, uscito nell’anno del suo divieto da parte del Terzo Reich. Ciò non toglie che questo libro mostra che Adorno, semplicemente, non ha capito il jazz. Non è soltanto che non amasse questa musica – non c’è nulla di male in questo: come canta Paolo Conte, anche le donne odiavano il jazz, perché … non si capisce il motivo. Il punto è che l’ha frainteso teoricamente. Certamente esistono, e sono sempre esistite, espressioni jazzistiche assimilabili alla musica commerciale, e chi lo nega? Ma ciò non significa che il jazz nella sua totalità sia riducibile a queste espressioni.
La buona notizia è che lettori e ascoltatori ora possono farsi un’idea più articolata e informata di questa vicenda culturale. Il libro non solo ci consegna tutti i testi che Adorno ha pubblicato sul tema, ma ci offre anche le prospettive di lettura di Matteucci e Marino che invitano a riflettere su forza e limiti della riflessione adorniana. Personalmente, in questo caso non salverei Adorno. Ha affrontato il jazz con strumenti inadeguati, e ha sbagliato. È filosoficamente scorretto denigrare teoreticamente qualcosa che non si ama esteticamente e di cui, per pregiudizi culturali, sfugge il senso. Di sicuro, contrariamente a quanto mi disse una volta Peter Kivy (che è stato l’esponente più importante della filosofia analitica della musica), Adorno non è un autore overread, cioè letto eccessivamente, e di cui si potrebbe invece sostanzialmente fare a meno. Questo giudizio è una sciocchezza che lascia il tempo che trova: l’estetica analitica sta ad Adorno come i cavoli stanno alla merenda. La morale della storia è che anche i filosofi prendono le loro cantonate. Kivy l’ha presa con Adorno; Adorno, con il jazz.







