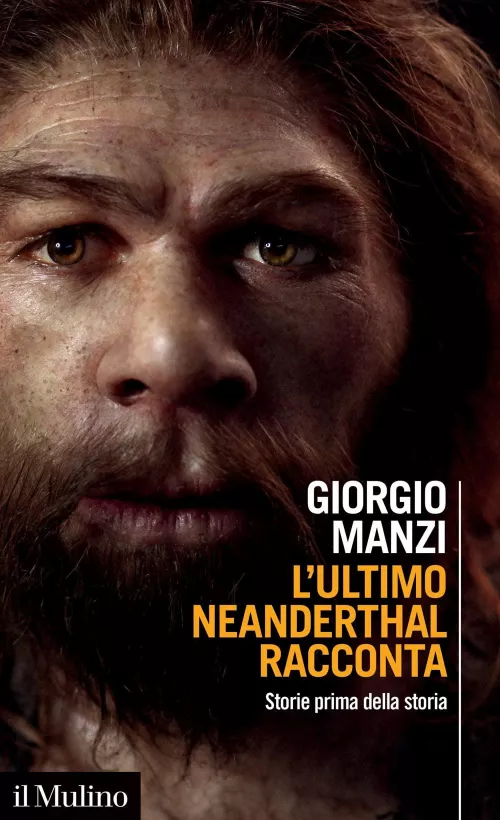Da dove veniamo? / I’m Neanderthal man
Nei pressi di Düsseldorf c’è una valle, thal in tedesco, che deve il suo nome a un certo Johachim Neumann – uomo nuovo, cognome fatidico! – un musicista seicentesco che, seguendo la moda dell’epoca, aveva scelto di grecizzare il proprio nome in Neander. In quella valle nel 1856 ebbe luogo il primo ritrovamento di un fossile umano sconosciuto al quale fu dato il nome di Homo neanderthalensis, uomo di Neanderthal. Le ipotesi su chi potesse essere furono le più varie e fantasiose: un uomo deforme, un cosacco congelato o un nostro predecessore nella scala (che non è una scala ma un complesso e vigoroso cespuglio, la fronda di un gigantesco albero) dell’evoluzione, forse addirittura l’anello mancante (che oggi sappiamo non esistere) tra l’uomo e la scimmia. Certo è che quell’uomo ha abitato il nostro immaginario, prima come una sorta di bruto primitivo e scimmiesco, poi come una specie di buon selvaggio rimasto vittima del feroce e astuto Homo sapiens. Alla fine degli anni Sessanta è diventato quasi un’icona hippy, grazie al successo mondiale di una canzone degli Hotlegs che ripeteva, al suono ritmico di percussioni tribali: I’m Neanderthal man, you’re a Neanderthal girl; let’s make neanderthal love, in this neanderthal world… Un tipo di poche e dirette parole, insomma. Neanderthal è stato anche protagonista di alcuni romanzi, tra i quali La danza della tigre (Franco Muzzio Editore) in cui l’autore, Bjorn Kurtén, già negli anni Settanta lo immaginava con tratti sorprendentemente confermati molti anni dopo dalla scienza.
I progressi nelle ricerche sull’evoluzione umana negli ultimi dieci o quindici anni grazie a tecnologie prima impensabili, come l’analisi di DNA ricavato dai fossili (DNA antico), hanno riacceso l’interesse attorno ai Neanderthal, tanto che nel solo mese di ottobre sono usciti tre saggi sull’argomento. In L’ultimo Neanderthal racconta. Storie prima della storia (il Mulino) Giorgio Manzi, paleoantropologo di fama internazionale e ottimo divulgatore, inserisce la storia dei Neanderthal nel contesto più ampio dell’evoluzione del genere Homo. Rebecca Wragg Sykes, archeologa inglese specialista del Paleolitico medio (300.000-35.000 anni fa), epoca in cui Neanderthal si diffonde in Europa e oltre, è autrice di Neandertal. Vita, arte, amore e morte (Bollati Boringheri), un saggio di cinquecento pagine in cui si approfondisce ogni aspetto della loro vita e cultura anche attraverso una meticolosa analisi dei loro manufatti. Giuseppe Remuzzi, medico e ricercatore affermato, in Le impronte del signor Neanderthal (Solferino) si sofferma sui legami genetici tra noi e loro. Insomma, non c’è dubbio che Neanderthal ancora ci intriga e ci affascina, forse perché è un po’ come se, dopo essere rimasti soli al mondo sin da bambini, si ritrovassero le tracce di cugini scomparsi grazie ai quali si può scoprire qualcosa in più di se stessi e della propria famiglia.
Cosa sappiamo, oggi, di Homo neanderthalensis – più familiarmente Neanderthal? Sicuramente appartiene al nostro stesso genere, Homo, e condivide con noi un antenato (circa mezzo milione di anni fa). A partire da circa 300 mila anni da oggi, si è diffuso dall’estremo Occidente europeo al territorio compreso tra il Mediterraneo e le steppe della Mongolia. Nel corso della sua lunghissima vicenda ha vissuto in periodi glaciali e interglaciali, dunque ha dovuto affrontare grandi variazioni climatiche che, cambiando l’ambiente, hanno inciso sulla sua esistenza e sui suoi modi di vita. I Neanderthal furono sempre cacciatori-raccoglitori, piccole bande di 20-30 persone che si spostavano continuamente seguendo le prede e le stagioni e si riparavano in grotte e anfratti naturali.
Grazie alla tecnologia che ha permesso di estrarre il DNA dei fossili ne è stato sequenziato il genoma e questo ha cambiato completamente il nostro punto di vista su di loro. Da cavernicolo tutto sommato scimmiesco, il Neanderthal si è rivelato un nostro parente rispettabile e molto prossimo. Abbiamo scoperto, infatti, che non solo ha condiviso con H.sapiens gli stessi territori per diversi millenni, ma anche lo stesso giaciglio, non sistematicamente, di certo più volte. I primi incontri avvennero tra i 100 e i 50 mila anni fa in Medio Oriente, nel territorio dell’odierno Israele, da sempre luogo di passaggio nelle ere preistoriche tra Africa e Eurasia, in seguito anche altrove. Le due popolazioni non si sono mai fuse tra loro, tuttavia i contatti intimi – pare prevalentemente tra maschi neanderthaliani e femmine sapiens – furono abbastanza frequenti da lasciare tracce significative nel DNA dell’umanità odierna: dall’1,8 al 2,6% e anche di più in tutte le popolazioni mondiali.
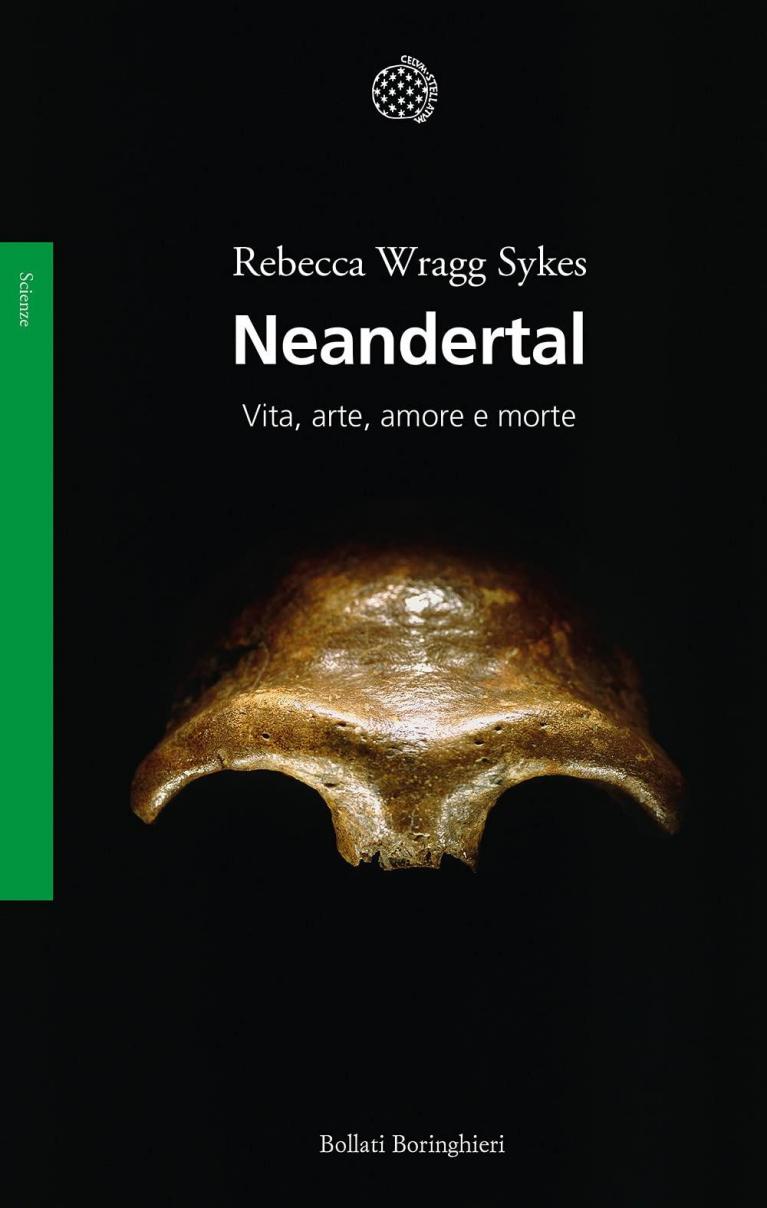
Secondo Rebecca Wragg Sykes ciò vuol dire che i neanderthaliani sono nostri progenitori e l’autrice sembrerebbe suggerire che non siamo specie diverse di un unico genere, ma una sola specie. È una sua ipotesi, naturalmente, con la quale non concorda Giorgio Manzi. Per lui è la vicinanza temporale dall’origine comune ad avere reso possibile la nascita di figli fertili dagli incroci tra le due specie, ma nonostante siano state “praticamente contemporanee e, tutto sommato, [siano] piuttosto vicine dal punto di vista biologico (ed ecologico), ciascuna di esse è stata protagonista di una sua propria storia evolutiva, prima che queste due umanità si potessero ritrovare e si venissero a confrontare sugli stessi territori”.
Le uniche popolazioni che non hanno traccia di DNA neanderthaliano sono gli abitanti dell’Africa sub-sahariana, pertanto i fanatici della purezza razziale, se proprio ci tengono a indicare un modello umano più puro degli altri, devono prenderlo dall’Africa, con pelle nera e occhi scuri. Tutti gli altri, tutti noi, siamo ibridi e meticci.
Un’altra cosa interessante rivelata dal DNA è che ognuno di noi porta frammenti diversi di DNA neanderthaliano, “come dire che il piccolo Neanderthal che è in me è diverso da quello che si annida in altri miei conspecifici di ieri e di oggi”, spiega Manzi; inoltre “si è potuto anche valutare l’effetto che il materiale genetico dei Neanderthal ha sulla nostra biologia; sembra infatti che si siano conservati soprattutto geni che, in combinazione con il nostro genoma, risultano dannosi, tanto da renderci più suscettibili a malattie come il diabete, ad alcune patologie autoimmuni come il lupus e il morbo di Crohn, o addirittura che – lo abbiamo saputo ultimamente – portano ad ammalarsi gravemente (ma alcune varianti indicano il contrario) di COVID-19. Altri sembrerebbero facilitare la dipendenza dal fumo, mentre altri ancora potrebbero indicare una migliore resistenza in ambienti freddi”. Su questi aspetti della ricerca si sofferma in particolare il saggio di Giuseppe Remuzzi.
Un altro argomento importante su cui le opinioni di Manzi e di Wragg Sykes divergono riguarda gli aspetti culturali. Mentre la studiosa inglese vede comparire progressivamente i segni di una vera e propria cultura neanderthaliana, Manzi ritiene che per quanto si riscontri, soprattutto nei tempi di convivenza delle due popolazioni sugli stessi territori, una evoluzione delle tecniche e in piccola misura del comportamento dei neanderthaliani, questo significhi piuttosto che essi fossero “davvero prossimi a una natura propriamente umana, vicina a quella dei primi Homo sapiens, anche sul piano del comportamento e delle potenzialità intellettive”. Ritiene però inappropriato parlare di una vera e propria evoluzione culturale perché i mutamenti rilevati “corrispondono a un lento, lentissimo progresso tecnologico piuttosto che a un processo evolutivo a carattere culturale che, per sua natura, dovrebbe essere di tipo esponenziale”.
Un netto cambio di marcia si ha soltanto con H. sapiens, con la cui comparsa siamo davanti a quella che lo studioso italiano definisce una vera e propria rivoluzione ontogenetica. “Penso cioè, spiega, che all’origine della specie sia intervenuto un drastico mutamento nel processo di accrescimento e sviluppo, tale da comportare un nuovo equilibrio tra ossificazione della volta cranica e la forma della stessa e del suo contenuto, cioè il cervello, con conseguenze importanti sull’organizzazione dei lobi e delle aree cerebrali e sulle relazioni fra esse. Di conseguenza, in ultimo, su fondamentali aspetti cognitivi”. Insomma non basta un grande cervello – Neanderthal lo aveva grande come il nostro – bisogna considerare anche come si sviluppa. Per la conformazione del suo cranio H. sapiens ha sviluppato aree cerebrali che ne hanno modificato sia le capacità intellettive, anche a favore di una maggiore capacità di pensiero astratto, sia il comportamento, rendendolo capace di costruire relazioni più ampie, più complesse e più strette con gli altri e con l’ambiente. Un atout che ha fatto la differenza e ne ha determinato probabilmente il successo.
Non ci sono dubbi né discordanze tra gli autori per quanto riguarda, invece, l’aspetto fisico dei Neanderthal. Se dovessimo incontrare un Neanderthal al bar capiremmo subito che si tratta di un essere umano un poco anomalo. Piuttosto basso, meno di un metro e settanta, con le cosce possenti di un forte camminatore capace di inerpicarsi senza difficoltà, ma non di correre velocemente a lungo. Con mani grandi e molto forti, un ottimo rugbista secondo Giorgio Manzi. Pelle chiara, occhi azzurri e capelli rossicci, probabilmente lentigginoso. Quello che lo tradisce è il cranio che si allunga posteriormente anziché verso l’alto rispetto al viso, insomma ha una fronte molto bassa. In compenso gli occhi sono grandi e rotondi, peccato che siano sormontati da un osso molto prominente che gli conferisce un certo cipiglio. Un naso dalle narici molto grandi, utilissime per riscaldare l’aria fredda prima di farla scendere nei polmoni racchiusi in un torace notevole, e un mento sfuggente perché quasi privo di osso completano il quadro. Però cammina perfettamente dritto e se, appunto, lo incontriamo al bar solleva il suo bicchiere con agile disinvoltura.
Alla fine, nonostante le sue molte qualità e la grande resistenza, questo nostro fortissimo cugino si è estinto e ancora ci chiediamo come sia potuto accadere. Probabilmente è stato sopraffatto da una serie di concause. Diverse migliaia di anni di grandi oscillazioni climatiche sempre più rapide e intense, modificando drasticamente l’ambiente probabilmente li hanno costretti all’isolamento in piccoli gruppi; una situazione che può aver provocato una deriva genetica – collo di bottiglia – inevitabilmente tradottosi in una gravissima crisi demografica. Certamente avranno dovuto affrontate più crisi di questo genere nel corso della loro lunghissima storia, ma questa volta una nuova variabile in più, la presenza di H.sapiens nello stesso difficilissimo ambiente, si è rivelata letale e ha portato, nel giro di pochi millenni, queste straordinarie creature all’estinzione. Ma qualcosa di loro vive ancora in noi, nei nostri geni e ancor più nella nostra immaginazione.