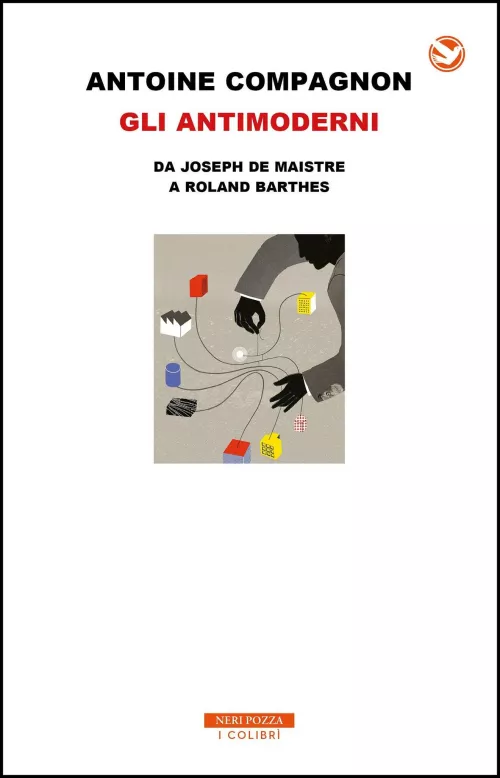Antoine Compagnon. Gli antimoderni
La modernità è quel posto da cui non si può tornare indietro. Accelera i cambiamenti, divora i suoi figli che un attimo prima erano all’avanguardia, scioglie le caste e scompiglia i ceti, rende obsolete le filosofie sistematiche e dissolve i generi classicisti. Non ci si bagna due volte nel suo fiume. Appena si è morsa la mela dello sviluppo, delle rivoluzioni e dello storicismo, ogni restaurazione che provi a mettere il tempo tra parentesi appare culturalmente kitsch e socialmente grottesca, anche e magari soprattutto quando s’impone con mezzi criminali. La modernità è puro artificio, e suscita il desiderio struggente di un altrove naturale. Ma tentare di raggiungerlo è inutile, perché ormai anche la natura coincide con questo artificio, e tutte le sue immagini edeniche scadono subito nel quadro pompier. L’innocenza, l’infanzia e il buon selvaggio sono il paradiso perduto dell’uomo otto-novecentesco proprio perché quest’uomo è caduto nell’èra irreversibilmente adulta e corrotta dei cronometri, e viene straziato a ogni passo da nostalgie e rimorsi. Così qualunque rivolta credibile contro il mostro moderno non può che ammettere di esserne complice, accettarne il contagio e mediarlo in sé, tentare di mitridatizzarsi.
Solo in un mondo dove l’attualità occupa tutto l’orizzonte può nascere il pathos dell’inattuale, che non è se non un attuale di secondo grado: torcendosi, il pensiero si stringe addosso le corde che lo legano, e s’inventa un punto d’appoggio esterno alla fiumana perché non può aggrapparsi a niente di concreto e stabile mentre la corrente se lo porta via. Perciò i veri contestatori della modernità, i reazionari, sono i rappresentanti maggiori e più consapevoli della sua cultura. Si tratta spesso di moderni delusi, innalzati per un istante sulla cresta dello Zeitgeist e poi travolti dall’onda successiva: gente che ha creduto di poter afferrare i comandi di quella locomotiva senza guida che mangia le rotaie dell’epoca a velocità folle, e che più avanza più fa apparire il progresso non come una forza emancipatrice ma come una camicia di forza. “La controrivoluzione subisce il fascino della Rivoluzione, come la fedeltà alla tradizione si oppone al culto del progresso, come il pessimismo del peccato originale si leva contro l’ottimismo dell’uomo buono, come i doveri dell’individuo o i diritti di Dio confliggono con i diritti dell’uomo”: così Antoine Compagnon nella sua raccolta di saggi su Gli antimoderni, proposta pochi mesi fa da Neri Pozza e contrassegnata al solito dalla pieghevole ragionevolezza con cui questo autore sa scaricare a terra le idee e le teorie, per loro natura estreme, rivendicandone al tempo stesso la funzione.
A inventare la modernità è stata la Francia, nel suo doppio volto cartesiano e rabelaisiano, con i suoi eccessi d’ordine e con i suoi eccessi carnevaleschi: è dunque giusto che sia uno studioso francese a riepilogare questa storia. In una serie di capitoli corposi, intitolati in parte ai concetti chiave e in parte ai singoli intellettuali, Compagnon ritrae un albero genealogico che va da Joseph De Maistre al suo maestro Roland Barthes. Nel conte savoiardo, l’elogiatore del boia che quintessenzia e rovescia il secolo volterriano, si trova la matrice di alcuni argomenti decisivi per la cultura antimoderna. Lo si vede bene in Baudelaire, che seguendo le sue orme irride la pretesa umana di autodeterminarsi e insiste sul motivo del peccato originale. Il dandy delle Fleurs e dello Spleen, schiavo ipnotizzato e fustigatore implacabile del Presente, è una figura centrale dell’antimodernismo, sia perché ne vive la fase “classica”, sia perché offre un vero e proprio catalogo riassuntivo dei suoi ossimori. Come Flaubert, Baudelaire appartiene alla generazione che ha varcato la linea tra giovinezza e maturità dopo il ‘48, quando l’Ottocento dello slancio romantico, delle barricate e dell’eroica borghesia in ascesa si ribalta e biforca nell’Ottocento dei decadenti e dei positivisti, della prosa angusta e della mediocrità burocratica. Le magnifiche sorti impiegatizie sembrano non lasciare alternative, ispirando agli scrittori un pessimismo assoluto. La loro rappresentazione disperata e satirica di bêtise e sottise colpisce la mentalità di chi crede che la vita e il cosmo siano addomesticabili dalla retorica liberaldemocratica, riducibili alla misura del suffragio universale: così l’uomo che in una famosa pagina baudelairiana insiste a guardarsi allo specchio malgrado abbia un volto spaventoso lo fa perché ne ha “diritto”, come dice rivendicando i “principi immortali dell’89”.
Ma questo tipo di cittadino ebete è passato alla storia con il nome del flaubertiano Homais. Il farmacista è il bersaglio per eccellenza degli antimoderni, che con mossa indebita retrodatano il suo filisteismo agli illuministi. Nessuno di loro riesce infatti a volgersi verso il Settecento senza pregiudizi, o perlomeno senza un forte sospetto. Perché lì sta l’origine del male: in quel Rousseau, o più spesso nella sua caricatura, a cui oppongono Pascal; e in quell’universalismo astratto, sfociato nell’incubo giacobino della tabula rasa, a cui oppongono il rispetto storico dei costumi e delle tradizioni, secondo una prospettiva che da Edmund Burke arriva fino al “paese reale” di Charles Maurras. Ed è proprio lungo il passaggio maurrasiano tra Otto e Novecento che lo spirito antimoderno, nella sua polemica contro la belle époque piatta e gretta, determinista e mollemente democratica, si carica di un idealismo volontaristico e attivistico destinato ad avanzare la sua ipoteca minacciosa sull’Europa del secolo nuovo. Siamo nel periodo dell’Action Française, dei paradossi antisemiti intorno al caso Dreyfus, e anche delle riviste di Péguy, che interpreta la lezione di Bergson con una faziosità eretica e militante simile a quella che i vociani applicano a Benedetto Croce (il quale Croce, ancora lontano dai ripensamenti del ventennio, esalta a sua volta la forza contro le “insipidezze giusnaturalistiche, antistoriche e democratiche” e “i cosiddetti ideali dell’89”).
Queste strumentalizzazioni, come altre diverse e magari contrarie, non possono dirsi del tutto illegittime. Vale infatti per i due grandi filosofi quel che valeva per Chateaubriand e per Renan: il vasto amalgama del loro pensiero ha un aspetto bifronte, è un miscuglio di moderno e antimoderno – che del resto, come chiosa Compagnon, sono sempre tali rispetto al punto di vista di chi li definisce, per la stessa ragione per cui capita di trovarsi contemporaneamente a destra di qualcuno e a sinistra di qualcun altro. Nei giovani che a inizio Novecento trasformano la metafisica in militanza o in esame di coscienza, e che presto imboccano strade incompatibili, un pragmatismo spregiudicato convive e fa contatto con un oltranzismo teorico “sublime”, secondo un impasto ideologico già brevettato da un pensatore assai più andante di Bergson e Croce: quel Georges Sorel che nel suo intuitivo e confuso entusiasmo pubblicistico tentò di colmare l’abisso del nichilismo con il mito della violenza rivoluzionaria. Purtroppo i miti o vivono spontaneamente nel corpo sociale o non sono: è impossibile deciderli, fondarli a freddo. Se ci si prova si partoriscono suggestioni vaghe e pronte a prendere qualunque forma, come confermano sinistramente proprio le opinioni di Sorel e il loro vario uso; oppure si propongono esegesi magari acute ma travestite da pratiche velleitarie, come mostra negli anni Trenta il Collège de Sociologie dove Bataille e Caillois giocano agli alchimisti del Sacro.

E proprio qui sta forse uno degli scacchi più dolorosi della modernità novecentesca, esemplarmente messo in risalto da quella eccezionale incarnazione dell’antimodernismo che è il poeta modernista alla Eliot. Da una parte si avverte cioè la necessità di nuovi miti e gerarchie, che sostituiscano le forme del passato in cui non si ha più fede; ma d’altra parte si comprende che l’atomizzazione socioculturale e la babelica democrazia dei linguaggi e degli stili non li lascia più sorgere. In una civiltà dove il progresso sembra un fatale calculemus, gli antimoderni denunciano la sparizione delle comunità ristrette, l’omologazione caotica, l’esproprio della libertà di scelta nelle questioni essenziali della vita, e in definitiva la distruzione di tutto quello che alla vita dà senso – il mito appunto, ossia un racconto comune, una comune credenza capace di operare tagli e di selezionare valori collettivi nel corpo brulicante del reale. Gli antimoderni constatano che nelle tecniche e nelle organizzazioni straordinariamente efficienti, logiche e aride della modernità “non c’è nulla da amare”, per dirla con Simone Weil, dato che confinano nel chiuso di una coscienza del resto sempre più perversamente standardizzata ciò che proprio perché conta non può essere contato.
Questo spiega la venatura teologica dell’antimodernismo, e il richiamo a una dimensione spirituale sulla quale però, data la sua natura ormai ineffabile e astratta, non si può costruire un’alternativa se non tradendola, volgarizzandola demagogicamente, cioè abbassandosi al livello giornalistico del mondo contro cui ci si scaglia. Resta che il vuoto di senso fa apparire lo sviluppo liberaldemocratico, economico e amministrativo come un dissanguamento ideale, un processo entropico e una pura decadenza. Ecco allora che la modernità diventa il luogo nel quale la politica si scinde dalla cultura, come nota Albert Thibaudet durante quella Terza Repubblica che solo oggi l’erede-archeologo dell’antimodernismo Marc Fumaroli può trattare retrospettivamente da compatta e saggia civiltà neoclassica. Se la politica avanza verso sinistra, la cultura svolta quasi inevitabilmente a destra, salvo casi speciali e comunque paradossali: come quello di Alain, mistico e stoico del radicalismo, o di Julien Benda, che più della ragione incarna “la passione della ragione”, difendendo i lumi con una violenza acida e sulfurea assai distante dalla compostezza cartesiana.
Ultimo tra gli spiriti magni della generazione di Gide, Valéry, Claudel e Proust, Benda muore mentre si afferma il giovane Barthes. E la parabola barthesiana mostra cosa ne è del moderno-antimoderno quando s’inserisce in una cultura ormai interamente amministrata dalle università e dai media. La sua corsa a rotta di collo, sempre più ricattatoria e ricattata dallo spirito del tempo, si trasforma allora in un contorsionistico piétiner sur place, in una dialettica strozzata dall’uniformità: la macchina del pensiero procede senza attrito su qualunque strada, anche quelle nominalmente più vertiginose. Così alla fine, dopo avere disperso in mille rivoli i fuochi d’artificio più o meno pretestuosi di un’intelligenza spettacolare, questo avanguardista-restauratore costantemente votato al dernier cri traduce la sua insofferenza in un più estremistico e insieme più dubbioso, depresso “vorrei scendere”.
Nelle generazioni successive Compagnon non riconosce più antimoderni nel senso pieno del termine. Con l’estenuarsi della modernità, a suo avviso si è consumato anche l’agonismo che ne nutriva la tradizione. Né Michel Houellebecq né Alain Finkielkraut, né Régis Debray né Renaud Camus, e nemmeno l’ex papa Benedetto XVI, avrebbero attraversato drammaticamente il moderno: nelle forme, oltre che nei contenuti, alcune di queste figure gli appaiono quindi al limite del pompier. Inoltre, ora che i fondamentalismi attaccano da ogni parte la società aperta, secondo l’autore occorre prima di tutto custodire l’eredità illuminista.
Qui però la ragionevolezza compagnoniana rischia un frettoloso appiattimento. Non credo infatti che il problema stia nelle posizioni in sé. Forse bisognerebbe riflettere piuttosto sul fatto che la mistificazione, la volgarizzazione e anche un certo pompierismo dipendono dai rapporti equivoci tra politica e cultura. Lungo la modernità la letteratura, la filosofia e il pensiero critico si sono trasformati spesso in ideologia, senza pagare pegno né sul piano del rigore teorico né su quello della prassi. Così gli intellettuali moderni, politici della cultura o uomini di cultura politicizzati, hanno finito per non fare davvero né politica né cultura. Dei politici hanno assorbito una demagogia che però in loro appare imperdonabile, dato che non dipende dall’obbligo di chiedere il consenso. Troppe volte questi maîtres à penser hanno recitato da protagonisti o uomini di paglia in un’arena partitico-mediatica che è l’ultimo luogo in cui si può cercare la verità diderotianamente, “senza riguardo”: al suo interno, per non soccombere, si è infatti costretti a inseguire la doxa e a rovesciarla continuamente come una frittata, con uno pseudoanticonformismo da coatti, senza poter distogliere gli occhi dalle sue gibigianne effimere. Gli intellettuali si sono cioè ritagliati un ruolo, un potere e una visibilità che costano la perdita della misura critica, perché le energie spese nell’autorappresentazione pubblica sviliscono le lotte emancipatrici che sole potrebbero legittimare questa autorappresentazione. Il colpo di scena, la rivendicazione identitaria, il riposizionamento spettacolare sono divenuti così il loro perpetuo eccitante, la loro unica ragione di vita. “Mi piacerebbe che esistesse una specie di affaire Dreyfus permanente, che permettesse di riconoscere sempre chi è della nostra razza morale rispetto agli altri”, ha confessato con la sua atroce limpidezza il vecchio Benda, che pure lotte coraggiose e lungimiranti ne ha fatte parecchie. “Devo convenire, del resto, di essere stato servito bene: il 6 febbraio, la questione etiopica, l’avvento del governo Blum, la guerra civile spagnola hanno prodotto in casa nostra un vero affaire Dreyfus permanente, che spero durerà sino alla fine dei miei giorni”.
In questo desiderio puerile, raccapricciante e ridicolo, si riflette una deriva che i nostri media tentacolari hanno esponenzialmente accresciuto, riducendo la cultura moderna e postmoderna a un chiacchiericcio senza più limiti di nessun genere. Come si esce da questo dantesco talk-show, da questo inferno della ripetizione degradata senza tramutare l’uscita nel gesto pubblico e identitario di chi ostenta il Gran Rifiuto, o senza alzare pateticamente lo stemma delle Minoranze, ma anche senza una mimesi dell’invisibilità così perfetta da costare la perdita di ogni incisività critica? Forse la prima illusione o finzione da liquidare è quella di poter parlare a tutti, anziché alle comunità a misura d’uomo in cui soltanto si può dialogare senza seppellire i temi d’interesse pubblico sotto un trollaggio pubblicitario. Forse bisogna dare alla “bestia sociale” solo il contributo indispensabile a essere cittadini dignitosi e niente più, specie là dove lo sbandierato “agire” è in realtà un comunicato stampa dell’azione, o l’incarnazione mostruosamente bovaristica di un pensiero che se preso sul serio non sopporta applicazioni immediate. Da questo punto di vista i moderni e gli antimoderni, giudici implacabili del kitsch, ne sono stati produttori quasi inarrivabili ogni volta che hanno creduto di poter tradurre brutalmente le visioni del mondo in allestimenti reali, come se la società fosse un meccanismo fabbricabile da una schiera di ingegneri o artigiani illuminati. Hanno dimenticato che un confine oscuro separa le idee e gli eventi, e che le utopie sono modelli destinati a nutrire la vita interiore, cioè a ricadere solo mediatamente o per vie inimmaginabili nei comportamenti pratici. E dopo il fallimento dei loro progetti “fabbrili”, quando l’enfasi ideologica si è spostata su uno spiritualismo di ritorno, hanno dimenticato anche che le credenze e il sacro non si possono restaurare per pura forza di volontà, se la realtà attorno a noi ci rimanda esperienze e convinzioni che quelle credenze e quel sacro rendono incredibili: in un contesto del genere si può al massimo propagandare o mimare una religione, cioè diventare dei predicatori in malafede o girare pittoreschi film in costume.
Nelle ultime frasi non ho fatto che parafrasare la lezione più viva di Nicola Chiaromonte, autore che da decenni nessuno vuole ripubblicare perché le sue idee sono radicali ma non esibite, esattamente come il suo stile spoglio, e dunque la nostra cultura non si accorge del valore né delle une né dell’altro. Amico di André Malraux, che come Mary McCarthy ne fu impressionato al punto da farne un personaggio di romanzo, Chiaromonte ha sempre onorato la statura del francese, ma al tempo stesso ha criticato in lui un esempio tipico dell’estetizzazione della politica e dell’idolatria del Moloch storico. Amico di Albert Camus, ne ha condiviso il culto della limpidezza meridiana, ma il suo rigore “greco” lo ha allontanato dall’umanismo di compromesso – altra faccia dell’assurdo – di cui l’autore dello Straniero è divenuto un generoso ma poco convincente ambasciatore, tentando di amalgamare letteratura, accenti personali e astrazioni politiche in quello che Susan Sontag ha chiamato il suo “pathos delle azioni morali”. Le critiche radicali di Chiaromonte alla cultura moderna sono al tempo stesso critiche radicali alla cultura antimoderna: oltrepassando entrambe, questo “filosofo al modo antico” rifiuta con fermo coraggio i risarcimenti ideologici che le legano in un solo nodo. Chissà se Compagnon lo ha mai letto.