Imm. Annotare, immaginare, stupirsi / Ciò che Paul Auster non ha mai detto
“Ciò che non è in mezzo alla strada è falso,
derivato, vale a dire: letteratura”.
(Henry Miller, Primavera nera)
La qualità angosciante di un incubo consiste nel fatto che in esso tutto è completamente reale. E non c’è nulla che appaia all’inizio più irreale della nostra normale posizione nell’esistenza.
Allo stesso modo, la stranezza senza eccezioni di ciò che accade nei libri di Auster è il segno della presenza esclusiva e completa del reale in tutto ciò che scrive. L’irriducibile “senso di irrealtà” evocato a più riprese in Leviatano, ad esempio, pone la dimensione letteraria sotto il segno del fantastico. E, infatti, il libro racconta la storia di un uomo a cui le cose accadono come se la sua vita fosse un racconto fantastico: cioè tutto avviene prima che lo si possa rappresentare. Da qui deriva l’interesse per il riferimento, o l’omaggio, fatto nel testo a Rip Van Winkle.
Il sentimento del fantastico implica tutte le caratteristiche di un fondamentale stupore ontologico. Lungi dal generare l’immaginazione – come accade invece con il meraviglioso –, esso la “coglie” (e la sorprende) per mezzo del sorgere di ciò che, per definizione, non lascia nulla all’immaginazione: l’aspetto esistente (attuale) di ciò che è, considerato in se stesso. Sul modello di Benjamin Sachs – “il fantasma” –, i personaggi di Auster provocano la stessa impressione che generalmente fanno i colossoi grandiosi bloccati eternamente nella posa pietrificante del loro esserci. In ogni istante gli eroi austeriani sono sempre e soltanto “tali”, e le loro azioni sono rette a priori da un eleatismo di principio. Anche Il taccuino rosso (1992) si presenta come un piccolo trattato di eleatismo applicato alla vita quotidiana: è qui, è così, è reale. “È andata proprio così. Come ogni cosa scritta su questo taccuino rosso, questa storia è una storia vera”, e questo è tutto. È la taleità stessa del reale a diventare il vero eroe del romanzo, e ciò che è costante non è più il desiderio ma l’evento. Che cosa succede? Niente, ciò accade.
“Il nostro modo di fare l’amore era muto e intenso, un deliquio negli abissi dell’immobilità”. Nel corpo a corpo amoroso il senso coincide con la cosa: l’amore non significa altro che ciò che accade quando lo facciamo.
Leggere Auster equivale a prendere l’abitudine di far coincidere ciò che sarebbe potuto accadere e ciò che effettivamente è accaduto. D’altronde è proprio per questa ragione che nei suoi libri si ha sempre l’impressione che le cose sarebbero potute andare diversamente! Qualsiasi cosa poteva accadere; prova ne è che una cosa qualsiasi è davvero accaduta. Ecco allora che nulla nel testo sembra prestarsi all’analisi o alla critica letteraria: non si può indagare di cosa parli Auster perché non dice mai nulla di più di ciò di cui parla. Se parlare bene è “saper trovare belle metafore”, ciò equivale a “dire qualcosa riguardo a qualcos’altro”.
Ma Auster, dal canto suo, non riferisce più niente a niente (d’altro), salvo ripetere che “A. è A.”. A. è sempre necessariamente il centro del romanzo, e chiedersi cosa questo voglia dire significa mancare il bersaglio: cercare dei temi (la solitudine, il complotto, l’autoreferenzialità) laddove il testo affronta invece il muro eleatico. “Ciò che esiste esiste, ciò che non esiste non esiste”: quali sono i sentimenti espressi dall’autore in questo passaggio? Dire che una cosa esiste equivale a dire una qualsiasi cosa su di essa? Per esempio, nel caso di La stanza chiusa (1986) il narratore – una voce fuori campo – finisce per sposare la moglie e adottare il figlio del personaggio di cui racconta la storia. In seguito pubblica anche i suoi manoscritti (gli stessi che leggiamo noi?). Senza dubbio c’è un labirinto, ma su una linea retta. Sicuramente c’è una storia di doppi, ma nella misura in cui il doppio non è tanto una rappresentazione del reale quanto piuttosto la confusione panica tra la rappresentazione e il suo
referente: la figura compiuta del reale nella sua “idiozia”.
In un altro caso, l’eroe di Città di vetro (1985) sceglie lo pseudonimo di William Wilson: da un fondo oscuro, reso impenetrabile a forza di affiorare e di non nascondere nulla, sorgono ovunque delle repliche caravaggesche. Ogni volta c’è almeno una cosa che Paul Auster non dice mai: ed è ciò che potrebbe significare quello che ci mette sotto gli occhi. La ragione è che ciò che leggiamo
deve essere preso alla lettera.
“Qualunque cosa è possibile, ed è come [non dire] niente”, si legge in conclusione di Nel paese delle ultime cose (1987): “La lettera uccide”. Solo il reale è reale, nel suo progredire, mai prima, e ancor meno dopo. Niente è mai possibile, perché tutto è sempre reale. Ogni volta, la cosa più probabile è che qualcosa di reale accadrà. Letteralmente. Nient’altro. Dopo tutto, Auster si accontenta di replicare ciò che Clément Rosset ha definito “l’insignificanza del reale”:
Chiameremo insignificanza del reale quella proprietà inerente a ogni realtà di essere sempre indistintamente fortuita e determinata; di essere sempre, allo stesso tempo, anyhow e somehow: in un certo modo, in tutti i modi [...]. I principi di questa insignificanza generale si possono riassumere in due semplici formule: 1) Ogni realtà è necessariamente determinata. Ciò è evidente in base al principio di identità. 2) Ogni realtà è necessariamente qualsiasi. Essa non è necessaria in quanto è questo e non quello, né in quanto è questo o quello, ma piuttosto in quanto non può sfuggire alla necessità di essere qualche cosa, cioè un qualsiasi.

L’insignificanza del reale non è assurdità o impertinenza verso le regole della significazione: non contraddice quest’ultima e nemmeno la deride. Non sono cose impossibili ad accadere. Non c’è assenza di senso (aberrazione semiologica) ma assenza dal senso (neutralità ontologica). Nel confondere l’avvenimento delle cose con la sua interpretazione Auster è nietzschiano. Così, in senso proprio, la sua “opera” non è composta di libri, ma di taccuini e di diari: collezioni di istantanee “scattate” giorno per giorno. Leggerla significa quindi essere immediatamente ostacolati da ciò che, per sua stessa natura, resiste alla finzione: ovvero l’immediata insignificanza di ciò che esiste, e che, non avendo storia, non può essere drammatizzato; qualcosa che non ha durata ma che accade ogni volta: letteralmente, l’universale vicissitudine.
La nostra “ignoranza di ogni cosa” (Leviatano) non è quindi né epistemologica né critica. Essa non dipende dal fatto che le cose siano difficili da conoscere (indisponibili alla ragione), ma dal fatto che sono sempre e soltanto presenti a loro stesse. La vicissitudine interseca il piano dell’immanenza nuda, e quindi non ci sono mai delle cause perché queste sono sempre immerse negli effetti. In questo modo, l’onnipresenza della fotografia nei testi di Auster segnala la volontaria confusione filosofica tra gli epiteti “vero” e “reale”. “Il terzo uomo poteva essere chiunque”, o ancora: “qualsiasi cosa poteva trovarsi nascosta” da qualche parte. L’insieme di una vita non dà nient’altro che una somma. La logica del qualsiasi implica che il tutto non sia più grande della somma delle parti. Che cosa succede ogni volta? Niente di più di quel che succede. Così Auster può vantarsi di aver risolto il mistero dell’universo: la natura fortemente irreligiosa del mondo di cui parla non lascia spazio ad alcun messaggio criptato, perché i rapporti non vi precedono e non vi trascendono le cose. Non c’è un legame (re-ligio) oltre le cose. Ciò che è straordinario quindi non è che sia accaduto questo piuttosto che altro, ma che sia accaduto qualcosa piuttosto che niente. Ecco perché, una volta che qualcosa è accaduto, non ci si può più stupire di nulla.
È dunque interessante concentrarsi sul notevole fascino della narrazione austeriana, poiché non è così ovvio. Wittgenstein rifletteva su questo punto dicendo che il fascino di un testo – e in generale di un discorso – dipende dalle relazioni che esso è in grado di stabilire. In particolare, il fascino del discorso critico ed esplicativo riguarda la capacità di far sorgere delle relazioni pertinenti altrove rispetto a dove abitualmente potremmo aspettarcele. E, per esempio, “è affascinante, distruggere pregiudizi”. Il fascino della psicanalisi, di gran lunga superiore alle pretese resistenze che susciterebbe, si spiega senza dubbio con l’attrazione irresistibile verso lo spirito critico in generale. La psicanalisi come forma di persuasione strappa consensi – fino al punto che le sue spiegazioni sembrano subito fondamentali e insostituibili – per il semplice fatto di essere in grado di produrre frasi del tipo: “questo non è ciò che pensate” e soprattutto “questo in realtà è quello”. Quindi, per definizione, una frase come “ciò che è è soltanto ciò che è e nient’altro” non è mai persuasiva. Eppure, contro ogni attesa, quello che scrive Auster è affascinante. Nel suo caso, l’assenza ostinata di spiegazioni equivale a una spiegazione per mezzo dell’inspiegabile, inteso come ciò che è estraneo a ogni spiegazione. Non c’è nulla da spiegare, e questo spiega tutto. Il segreto dell’universo è il suo non avere segreti. Auster cerca continuamente di convincerci, ma vuole convincerci di niente. A ciò che accade non manca nulla, tanto meno un principio esplicativo. Infatti, in ultima analisi, se il reale si “esplicasse”, il suo senso si troverebbe fuori da esso, solecismo logico rispetto alla sua stessa definizione di essere interamente ciò che realmente è.
Al limite, tra le righe della grande opera-documento di Auster si potrebbe leggere che “il reale non lascia le cose a metà”. Ma non è un mistero, perché non è un messaggio: è così.
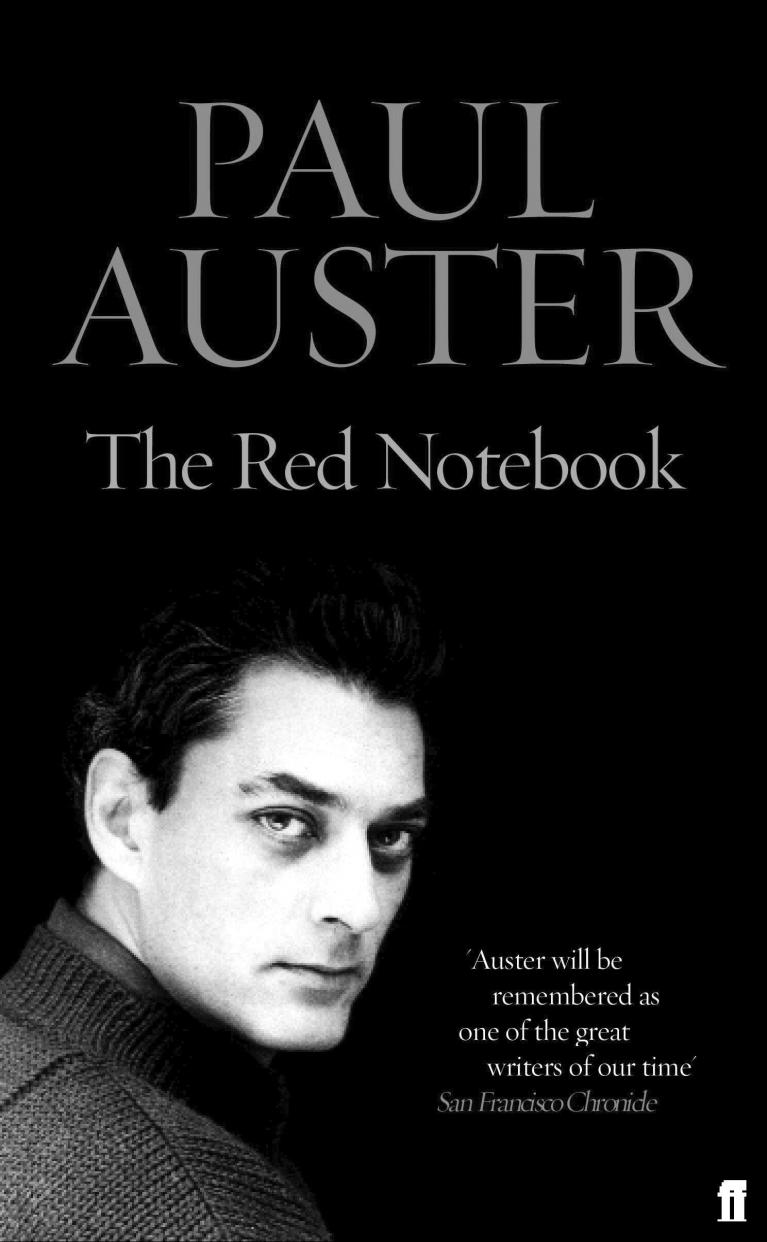
La realtà supera sempre ciò che riusciamo a immaginare. Per quanto sfrenati pensiamo che possano essere, i frutti della nostra fantasia non potranno mai tener testa all’imprevedibilità delle cose che il mondo reale erutta in continuazione. Adesso questa lezione mi sembra inevitabile. Tutto può succedere. E in un modo o nell’altro, succede sempre.
Il sistema filosofico hegeliano ha realizzato nel modo più completo la tendenza incontenibile dello spirito umano ad assimilare “reale” e “vero”, e a considerare come maggiormente reale ciò che noi concepiamo come migliore. Ma, nei termini precedenti, il reale si manifesta soprattutto quando le nostre concezioni falliscono! Anche la più piccola frase di un romanzo o di un racconto di Auster indica il rifiuto di una netta distinzione tra il tutto e la parte, in qualsiasi ambito. Da qui deriva l’ontologia della “goccia d’acqua” che vi regna sovrana. Siccome non accade mai nient’altro che il reale, una goccia può far traboccare un vaso senza che accada nulla di diverso da ciò che aturalmente avviene. “La questione è la storia in sé: che abbia significato o meno, non spetta alla storia spiegarlo”: l’innesco di ciò che accade è imprevedibile, proprio come il modo in cui le cose evolvono è necessariamente qualsiasi. “Cominciò con un numero sbagliato”. Il caso non implica lo straordinario ma la banalità del reale, perché l’imprevedibilità definisce l’esistenza in modo universale.
“Il reale è sempre ciò che non ci aspettavamo”, quindi. E non in modo circostanziale, ma per sua natura, poiché esso è ciò che non è soltanto pensato (pensabile) o rappresentato (rappresentabile). L’accidente, il puro fatto di arrivare (accedere), è il modo di essere di ciò che esiste per il solo fatto di esistere. Accidentale non significa aleatorio ma imprevisto, è ciò che sfugge alla possibilità di essere previsto o anticipato mentalmente. Il reale di una cosa o di un avvenimento è proprio quel qualcosa che fa sì che essi non siano soltanto delle idee. Piccolo niente che cambia tutto, perché non c’è alcun denominatore comune tra il fatto di essere idealmente e il fatto di essere realmente. Dall’uno all’altro interviene la distanza abissale che esiste tra il concetto e l’esistenza.

Ciò che accade in Auster è quindi l’incredibile in quanto tale: ciò che sfugge a ogni credenza. “Le cose sono come sono”: non c’è nulla di più da credere. Il taccuino rosso fa dell’incredibile il criterio per valutare il tenore reale di un avvenimento attraverso la sua capacità di restituire il suo tasso d’indipendenza rispetto alla rappresentazione in generale. Che ne siano consapevoli o no, cosa incredibile, le due sorelle di due amiche che s’incontrano casualmente a Taipei, dormono allo stesso piano dello stesso edificio di Manhattan, credendosi a migliaia di chilometri di distanza l’una dall’altra, perse ormai di vista. Allo stesso modo, un’altra cosa “vertiginosa” per il semplice fatto che rappresenta la realtà fuori dalla rappresentazione è la vicenda di una bambina a cui un giorno si è salvata la vita senza che lei lo sapesse. Che oggi sia ancora viva e che abbia potuto diventare una donna per una ragione che ignora e ignorerà per sempre. La cosa austeriana mette implacabilmente alla prova la nostra credulità.
In fondo, la poesia di ciò che scrive Paul Auster risiede nella disinvoltura con cui egli accetta la disinvoltura del reale. I suoi eroi farebbero la felicità di Cioran quando si augura finalmente l’avvento di un uomo capace di “fregarsene di tutto”, dove questo menefreghismo significa lasciare che accada l’immensa positività del mondo. Forse le figure di Auster sono i discepoli di Henry Miller dopo che ha deciso di accettare il “caos” di ogni presenza come una benedizione:
Oggi è il terzo o quarto giorno di primavera e me ne sto seduto nella Place Clichy in pieno sole. Oggi, seduto qui al sole, io vi dico che non importa un fico se il mondo sta andando o no alla malora; non importa se il mondo è nel giusto o nel torto, nel bene o nel male. È – e questo basta.
Paul Auster si diverte a far ridere. Al limite non fa nient’altro e si accontenta di questo. I suoi libri raccontano di strane storie prive di senso, cioè senza uno scopo né una ragione. Così, l’antologia ha il valore di un’ontologia, come dimostra in modo emblematico Il taccuino rosso. Gli accidenti che vi affluiscono alla rinfusa costituiscono delle sequenze autonome paragonabili alle gag dei film di Buster Keaton, dei fratelli Marx o di Chaplin – tutte figure che abitano l’opera di Auster. Le difficoltà e gli attriti di Charlot con il mondo degli oggetti costituiscono una delle istanze principali della comicità chapliniana analizzata da André Bazin: “Sembra che gli oggetti accettino di aiutare Charlot solo al margine del senso che la società aveva loro assegnato. Il più bell'esempio di queste sfasature è la famosa danza dei panini in cui la complicità dell'oggetto esplode in una coreografia gratuita”. Nel caso di Città di vetro è un foglio del taccuino rosso su cui Quinn annota le sue osservazioni che viene usato come carta igienica. In un’altra occasione il quaderno è usato come cuscino. Dopo tutto, un libro è forse soltanto una cosa qualsiasi tra le altre. Stillman stesso è un vagabondo che colleziona le cose da buttare di cui le strade sono piene. La via del comico è dunque quella che porta dall’oggetto alla cosa. “Cosa succede quando una cosa non svolge più la propria funzione?”, si chiede Auster. E la risposta è che essa si mostra e suscita uno scoppio di risa allo stesso tempo. Sotto l’aspetto del suo utilizzo, la cosa resta inosservata, ma quando è rotta, la stessa cosa smette di nascondersi. Paul Auster pone l’equazione tra il visibile e il risibile. Le cose più visibili sono paradossalmente quelle meno guardate: è per questo che non si ride mai del reale, ma con il reale. La maschera cade, dice Lucrezio, ma la cosa resta. Il riso è qui inteso come l’“altro” del divertimento pascaliano.
L’effetto comico culmina nell’effetto di sorpresa. Le cose accadono senza preavviso, provocando delle strane coincidenze a nostra insaputa. Nonostante tutto noi ci ostiniamo lo stesso a prendere le misure sulla realtà. La nostra vanità si spinge fino al punto di pretendere di anticipare gli eventi così da poterne neutralizzare l’effetto perturbante. Da qui derivano le nostre necessarie delusioni, che ci offrono immediatamente delle eccellenti occasioni per ridere di noi stessi. Lo humour di Paul Auster ha consapevolezza di una verità semplice e tuttavia sempre celata: che le cose non sono mai possibili prima di essere reali. Per definizione, il reale si prende gioco del possibile. Il taccuino rosso potrebbe allora essere definito come un De Rerum Natura messo in scena dai fratelli Marx, poiché in esso non smettono mai di capitare degli incidenti assolutamente improbabili; episodi reali non a dispetto della loro inverosimiglianza, ma piuttosto proprio in virtù di essa. Lo strabiliante si rivela la sola “categoria” ontologica pertinente. Mentre il familiare non può essere che fittizio. Soltanto il quotidiano, cioè l’improbabile, esiste realmente. L’avventura è sempre dietro l’angolo. Paul Auster ritrova così il Truman Capote di Colazione da Tiffany, dove questa stupefacente confusione tra il reale e l’incredibile è espressa in una formula lapidaria: “Era troppo poco plausibile per non essere vero”. Siccome tutto accade sempre contro ogni attesa, la definizione di caso si sovrappone perfettamente a quella di esistenza e le storie strane si confondono completamente con quelle vere.

In L’uomo senza qualità Musil si prendeva gioco dell’ambizione filosofica di spiegare ogni cosa, proponendo un Principio di Ragione Insufficiente: “nella nostra vita reale, cioè personale, e nella nostra vita pubblico-storica succede sempre quello che in fondo non ha una causa ragionevole”. “Reale” è quindi ciò di cui non sapremmo nemmeno come immaginare di cercare il perché. Il pleonasmo del presente contingente trionfa ogni volta su un possibile ragionevole o razionale. Nella lingua di Auster “realtà” si dice happening. La sua visione del mondo ha questo di paradossale che non ce n’è una soltanto poiché le cose vi si mostrano sempre tali e quali. Oppure si tratta di una visione semplificata all’estremo, dove non si fa che prendere atto del casuale accadere dell’essere. In tutti i casi, in Auster c’è sempre una fascinazione etilica di fronte al mondo così come va. Ci si innamora proprio come si resta senza benzina, e viceversa. La scrittura si esaurisce nella sua dimensione assertoria. Città di vetro acuisce, nella sua stessa formulazione, l’impensabile semplicità dell’esistere: “Insomma, c’è un mucchio di cose”. C’è una serie di “c’è”, invece che niente.
“Questo non è un romanzo”. Bisogna prendere alla lettera l’incipit dell’opera di Paul Auster. L’autore lascia il posto al cronista. La delimitazione dello spazio proprio del romanzo che Maupassant traccia nella prefazione di Pierre e Jean esclude prima del tempo Il taccuino rosso:
Inoltre la vita è composta dalle cose più diverse, più impreviste, più contrarie, più disparate; è brutale, incoerente, priva di concatenazione, piena di catastrofi inspiegabili, illogiche e contraddittorie che vanno sotto la voce fatti di cronaca. Ecco perché l’artista, una volta scelto il suo tema, dalla vita ingombra di casi fortuiti e di futilità prenderà solo quei particolari caratteristici utili al suo sgomento, e tutto il resto, tutto quel che non è essenziale, lo respingerà.
Un esempio tra mille:
Il numero delle persone che muoiono ogni giorno in un incidente è rilevante. Ma possiamo nel bel mezzo di una storia far cadere una tegola sulla testa del protagonista, o buttarlo sotto le ruote di una carrozza col pretesto che bisogna dare all’incidente la parte che gli spetta?
Ecco che, con Il taccuino rosso, il dettaglio insignificante diventa il personaggio principale del romanzo. Ciò che è marginale occupa da solo il cuore del libro, che pertiene maggiormente al registro delle notizie del giorno piuttosto che a quello del romanzo propriamente detto. In una moltitudine di istantanee – in senso fotografico –, l’autore vi sprigiona la prodigiosa confusione dell’esistenza così com’è. Pertanto l’inventario soppianta giustamente l’invenzione letteraria. “Io non invento nulla”, ripete incessantemente Paul Auster contro gli amanti della fiction. Il reale è insensato. “Cosa posso farci?” “Questa non è una storia, dopo tutto. È un fatto, qualcosa che succede nel mondo”. È per questo che Auster non si prende nemmeno il disturbo di scrivere le cose. O piuttosto è la ragione per cui si ostina a scrivere l’attualità del mondo come se non fosse appunto scritta, cioè inventata da qualcuno. Ecco perché, infine, i suoi libri sembrano essere tanto più scritti quando meno appaiono esserlo.
Imporre forzatamente la letteratura al reale nella sua stessa insignificanza vuol dire liberarla da se stessa e dalla sua ossessione rispetto al suo ambito specifico. Lo spazio letterario coincide stranamente con lo spazio della realtà. Dopo tutto “la letteratura non c’entra”. Pertanto si comprende che un libro come Il taccuino rosso, dove la penuria di un senso nascosto raggiunge il suo apice, fa disperare l’amante di enigmi. Alla rinfusa Auster presenta pagine intere di aneddoti insoliti di cui la semiologia più ricercata non saprebbe che farsene. Per la sua opera valgono esattamente le stesse parole che Jean Laude ha riservato alla pittura di Paul Klee: “L’opera è ingannevole nel senso che ogni decifrazione non si rivela soltanto difficile o provvisoriamente insormontabile, come accade per una scrittura reale di cui mancherebbero le chiavi, ma impossibile proprio perché non vi sono chiavi. L’assenza di chiavi sta a significare che non ci sono segreti”. Proprio come il reale cessa immediatamente di significare per non fare altro che essere, lo scrittore, a sua volta, si astiene dal voler-dire e dagli evidenti pericoli a esso connessi. Allora scrivere potrebbe forse essere l’arte di imparare che non c’è assolutamente nulla da dire riguardo alle cose. Paul Auster realizzerebbe così, in modo prosaico, le parole di René Char secondo cui “la parola scritta si insedia nell’avvento dei giorni numerati, su una tavoletta casuale”.
Per concludere, dunque, Auster mostra nel dettaglio l’evento sempre rinnovato del clinamen epicureo. L’infinito scorrere del fuori, senza alcuno scopo. È tutto lì. Il minimo. Il minimo dicibile, proprio come in Lucrezio esiste un minimo sensibile. Il libro contiene molto esattamente tutto ciò che non è potuto rientrarvi: le cose come sono quando non le vediamo, quando non le diciamo. L’assenza del reale al discorso, alla leggibilità. Esso è fatto perché non se ne parli. Il mondo non sfugge al testo ma dal testo, e ne rifugge come esistenza pura.
Ciò che Auster non ha mai detto è esattamente quello che noi leggiamo nei suoi libri.
Ce que Paul Auster n’a jamais dit: une logique du quelconque, in Annick Duperray (textes rassemblés par), L’oeuvre de Paul Auster. Approches et lectures plurielles, Actes Sud, Arles 1995. Traduzione dal francese di Andrea Pitozzi. Questo contributo si legge nell'ultimo numero della rivista Imm: Carnet. Annotare, immaginare, stupirsi, a cura di Elio Grazioli e Riccardo Panattoni.







