Speciale
Il riso e la sua ombra / Ridicolo, vergogna, imbarazzo
Aveva terminato gli studi all’accademia di arte drammatica da parecchio tempo. Accadeva spesso che gli chiedessero del suo lavoro. Con imbarazzo rispondeva: faccio l’attore, ma sapeva che subito dopo sarebbe arrivata la domanda più difficile: dove reciti? Farfugliando diceva sottovoce che era in attesa di una parte che stava per arrivare, ma il telefono non suonava mai, né qualcuno lo cercava, neppure per un provino. Fu in un pomeriggio in cui tentava di non pensarci più che suonò il telefono e dall’altra parte una voce gli disse: è lei l’attore. Sì, sono io rispose, col cuore in gola. Avremmo una parte da proporle per… Certo, certo, va bene, va bene, rispose trafelato. Ma no, aspetti, si tratta di una piccola parte... Accetto, accetto, va bene. Deve recitare la parte di un maggiordomo nella seconda scena del terzo atto di una commedia… Sicuro, certo, sento che è la mia parte!... Ma guardi che si tratta di poco meno di un minuto in cui entrando in scena deve aprire una porta e vedendo un uomo a terra deve dire una sola battuta: “cielo, un cadavere!”. Ma è perfetto, accetto immediatamente, attendo il copione, le detto l’indirizzo e attendo per le prove. Nei tre mesi successivi, tra prove e ripassi del copione, l’attore andava in giro per casa e per la strada ripetendo la battuta in varie versioni recitative: Cielo un cadavere! Cielo un cadavere! e simulava le diverse posture per preparare la propria entrata in scena. La sera della prima era agitato fino all’inverosimile e non stava nella pelle per riuscire a fare finalmente l’attore. Dovette attendere gli interminabili primi due atti e la prima scena del terzo atto. Quando arrivò il suo momento aveva il cuore in gola e finalmente gli fecero cenno che toccava a lui. Aprì la porta e entrando in scena, alla vista dell’uomo a terra esclamò: cazzo, un morto!
Era la prima stagionale della messa in scena de Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, a Trento. Attrice protagonista Ottavia Piccolo. Nella prima scena la protagonista piange e si dispera appoggiata a un tavolo di un soggiorno liberty, mentre la fantesca scopa il pavimento e cerca di consolarla. La signora è convinta che il signore suo marito si rechi così spesso a Palermo non proprio per affari, ma perché ha un’amante. All’insistenza consolatoria della fantesca la signora, come prevede il copione, reagisce con un gesto di stizza e, toltasi una pantofola, la lancia verso di lei. Ma, inavvertitamente, in quella situazione sbaglia il lancio. La pantofola assume una strana parabola e rotolando nell’aria si posa su un lampadario, che è parte dell’allestimento scenico. Noi del pubblico scoppiamo a ridere e, cosa ben più impegnativa, inizia a ridere anche Ottavia Piccolo che stava piangendo, secondo il copione. Prova a trattenersi ma non ci riesce e ride sonoramente. La situazione è difficile e il tentativo di ricomporsi risulta goffo e ridicolo, tanto da suscitare ulteriore ilarità. A quel punto l’attrice si siede e, raccogliendo la testa tra le gambe, si concentra e, alzandosi, viene verso il pubblico e dice: “vi prometto che ce la farò!”. Si fa silenzio e lei riprende a recitare con la massima efficacia il proprio pianto e la propria disperazione tra un applauso scrosciante a scena aperta.
“… tra l’ultima parola detta
e la prima nuova da dire
è lì che abitiamo”
[Pierluigi Cappello]
Mentre il riso e il comico sono il successo dell’inatteso, il ridicolo e l’imbarazzo sono il fallimento dell’atteso.
Mentre il riso e la risata, il comico e l’umoristico, sono un lampo nel buio, un’esplosione del senso, il ridicolo si propone come una rovina del senso, una dinamica rovinosa rispetto alle aspettative.
Il gioco del riso e del ridicolo si fa comunque nel linguaggio, verbale e non verbale. Del resto, come ci ricorda il poeta Pierluigi Cappello, è lì che abitiamo e l’atteso imprevisto che emerge al prossimo giro del gioco del linguaggio ci riserva di tutto.
Dalla conferma delle aspettative, alla totale negazione, con in mezzo una varietà sterminata di possibilità. Tra le altre emergenze semantiche e pragmatiche del gioco del linguaggio verbale e non verbale e, a seconda del contesto, del tempo e della relazione in atto, di quando in quando spunta il ridicolo, col suo portato di vergogna e imbarazzo, ma anche con gli esiti di discontinuità a volte generativi.
Accade quando la comicità o la satira si prendono sul serio, ad esempio, diventano ridicole. Ma quando una seria normalità diventa ridicola può aprire alla scoperta che da vicino nessuno è normale.
Il senso di vergogna, che pure è una risorsa fondamentale per l’individuazione di sé e per riconoscere i confini delle proprie azioni possibili e del proprio essere e divenire, per l’imbarazzo con cui spesso si accompagna, vive oggi una crisi rilevante e non sempre è sodale del ridicolo.
Ad esempio, per l’arroganza spesso esibita, certe forme di esercizio del potere mostrano di non conoscere la vergogna.
Lo stesso accade per molte forme di giovanilismo o di esibizionismo dei corpi manipolati o restaurati o trasformati che, in assenza di ironia, non accedono alla vergogna che potrebbe essere un calmiere per non scadere nel ridicolo.
E tuttavia il ridicolo provoca riso e ilarità, tranne che in chi lo genera, che vive di solito imbarazzo e vergogna.
A distinguere perciò il comico e l’umoristico dal ridicolo è forse una sorta di “effetto di ritorno” che coinvolge in modo diverso chi scade nel ridicolo e i suoi osservatori che di lui e della sua azione ridono. Certo, non senza un certo imbarazzo e magari vergognandosi per lui, ma da una posizione diversa che è anche carica di una certa soddisfazione per non essere lui, per il fatto che è capitato a lui e non a loro.
Il ridicolo sta alla risata, secondo un certo approccio, come la luce sta all’ombra. La risata e la sua ombra emergono, considerando il ruolo di simboli archetipici e la loro storia, esemplificati dal riconoscimento mediante l’approccio della Gestalt nello studio del volto umano, mentre sorride, ride e sperimenta la paura di essere ridicolo (Perry, C., Marcus, M., Laughter and its shadow, Analytische Psychologie, 21: 171-198. 1989).
Mentre scrivo del ridicolo mi sento però all’improvviso ridicolo nel ridicolizzare il ridicolo; il ridicolo si vendica di me e mi fa sentire ridicolo nella mia seriosità: mi viene allora da tracciare un elogio del ridicolo, della vergogna e dell’imbarazzo
Perché il ridicolo, l’imbarazzante, il vergognoso sono anche ciò che si pone al margine di un centro in cui tutto è in ordine e tutto è a posto. Per certi aspetti si può sostenere che non è mai ridicolo chi mai si espone, chi mai stona con la coralità della verità dominante.
Se consideriamo la verità come perfezione data una volta per tutte, l’aletheia greca, ritroviamo i principi che dovrebbero qualificare la “vera vita”. Innanzitutto alethes è ciò che non è nascosto, ciò che non è dissimulato, ciò che è completamente visibile. Alethes è anche ciò che non riceve nessuna aggiunta, che non subisce nessuna commistione con qualcosa che è altro da sé. Il terzo significato di alethes è ciò che è dritto, retto. Infine, il quarto significato corrisponde a ciò che esiste e che si mantiene immutabile, che non subisce alterazioni.
In questo scenario la verità coincide col medesimo e non ci sono scarti o discrepanze. Siamo però nel mondo immobile e sempre uguale a se stesso, dove il possibile coincide perfettamente con il reale.
Quante possibilità ci sono in un mondo simile di vivere cambiamenti e trasformazioni, di sperimentare quello che sostiene Michel Foucault quando dice: “la verità non è mai il medesimo”, nel manoscritto dell’ultima lezione tenuta al Collège de France?
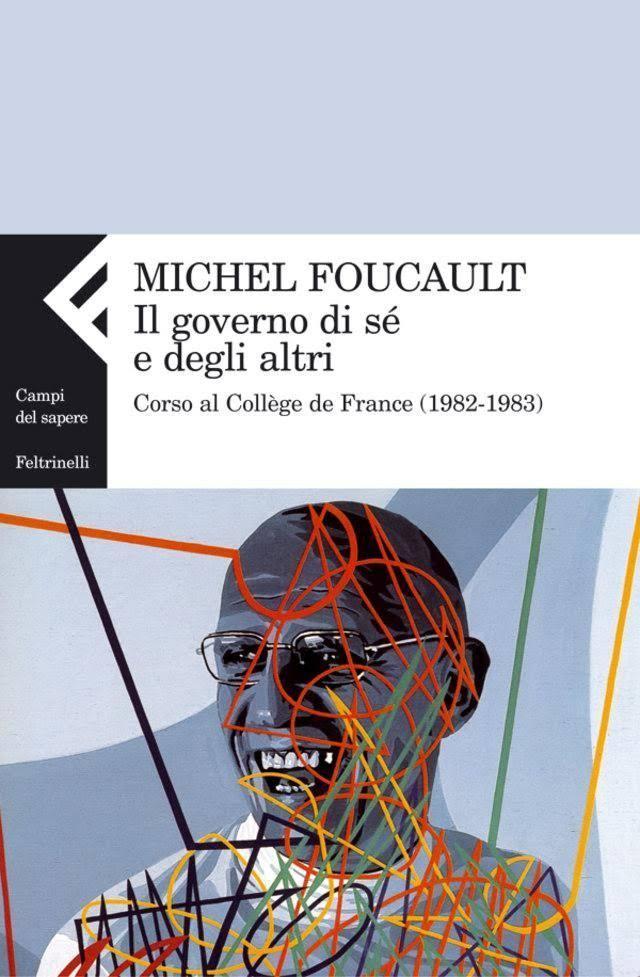
I break-down creativi sono dovuti principalmente al motto di spirito e al riso, ma in forma umile e costosa anche il ridicolo, per quanto agendo al margine, svolge una sua funzione in proposito.
Chi si mette in una posizione ridicola apre con sacrificio a una possibilità; la vergogna è una forma di vigilanza sull’arroganza e l’indifferenza; l’imbarazzo può essere un antidoto verso comportamenti che sarebbero altrimenti inopportuni e volgari. Così come la messa in ridicolo, ad esempio mediante la comicità, può aprire varchi in regimi di significato totalitari.
Pensiamo a quello che ha fatto Charlie Chaplin rispetto alle espressioni totalitarie, ne Il grande dittatore, evidenziando non solo i tratti ridicoli, appunto, del totalitarismo espressivo al potere, ma anche il ruolo del contesto e del tempo nella sottile distinzione tra il tragico e il comico, mediante la messa in ridicolo.


Essere o sentirsi ridicoli è diverso che mettere in ridicolo. La forma attiva del ridicolo, mettere in ridicolo, appunto, assume una dimensione asimmetrica verso la forma passiva, essere messi in ridicolo o divenire ridicoli. Più articolata appare la forma riflessiva: non sempre chi è ridicolo agli occhi degli altri si sente tale. Accade che, come si dice a Napoli, “nun ten scuorn”, non ha scorno, non ha vergogna e persiste nei suoi comportamenti e atteggiamenti che finiranno per porlo in ridicolo. L’esercizio del potere, nelle sue forme problematiche, narcisistiche o patologiche, come sono spesso le forme totalitarie, raggiunge picchi, nei momenti dell’apogeo e della massima affermazione, che saranno spesso il preludio alla caduta in ridicolo, con esiti a volte tragici, al cambio del contesto e della contingenza temporale. È difficile stabilire il momento in cui ciò accade e se prima si svela l’esasperazione del potere e poi interviene il ridicolo, oppure se sia l’avvento del ridicolo a svelare l’arroganza e l’eccesso di certe forme di potere.
Con Pulcinella, ad esempio, la comicità, il riso, l’umorismo e il senso del ridicolo si confondono e assumono connotazioni che vanno dal grottesco al comico esilarante.

Scornare, da corno, richiama difatti il rompersi le corna, che si associa allo svergognare e al mettere in ridicolo, allo schernire, al fallire in qualcosa che si è intrapreso traendone delusione e vergogna. Questa famiglia di significati che ruota intorno al ridicolo non è facilmente riducibile a forme attive o passive. Il ridicolo e le beffe sono connesse a sconfitte, a fallimenti, a umiliazioni, in cui c’entra però direttamente il comportamento e l’atteggiamento di chi cade in ridicolo. Le sfumature sono davvero molte e si riconducono al turbamento e alla mortificazione che si provano per azioni, pensieri o discorsi, propri o altrui, che si ritengono sconvenienti, indecenti e simili e che possono essere causa di disonore o rimprovero, o generare senso di forte imbarazzo per ciò che si considera poco decoroso o rispettabile. Si può sostenere che sia dal ridicolo che scaturiscono la vergogna e l’imbarazzo, ma che questi ultimi sentimenti non siano solo associabili al ridicolo. La vergogna, infatti, può derivare da un senso di soggezione, o timore dovuti in particolare alla timidezza, all’impaccio, o al turbamento, ma anche alla modestia e al pudore. Il rossore del viso provocato dalla vergogna può essere associato all’onta, al disonore, all’infamia, ma anche al sentirsi ridicoli in una situazione imbarazzante. Le vergogne, peraltro sono anche gli organi genitali, allorquando si tratti di coprirli per motivi di pudore. Il ridicolo, del resto, spesso emerge in relazione alla sessualità nel momento in cui si sperimentano situazioni di fallimento o prove di virilità, in particolare nei comportamenti e nei sentimenti maschili. Se il ridicolo è ciò che è oggetto di derisione, perché strano, goffo o insulso e scioccamente presuntuoso, richiama cose e situazioni di scarsa entità o valore, insignificanti o esigue.
In ogni caso c’entra la manipolazione lessicale, se si genera il grottesco, l’osceno, il ridicolo. Sul filo del rasoio delle parole, dove principe è il contesto. Al cambiare del contesto, infatti, le condizioni del ridicolo subiscono importanti metamorfosi, fino a neutralizzarsi. Ciò riguarda ogni esperienza umana che abbia a che fare con la discontinuità e che comporti un significativo o importante coinvolgimento emozionale, come è il caso dell’esperienza estetica.
Di tutte le esperienze, quella estetica è probabilmente correlata contemporaneamente a una profonda partecipazione empatica al mondo e, allo stesso tempo, a una tensione a trascenderlo: una istantanea e provvisoria apertura nella continuità e compattezza del senso, un rilancio trascendente che si esprime e crea o riconosce per risonanza un’espressione e una creazione inedite, ridefinendo e ricodificando il senso. Un lampo nel buio, appunto, una ferita nel senso.
“I nostri sistemi linguistico-concettuali sono estensioni e complicazioni di combinazioni sorte nella vita”. Così Aldo Giorgio Gargani situa impareggiabilmente la possibilità e il vincolo del linguaggio e della conoscenza per noi umani (A. G. Gargani, 1976, Il sapere senza fondamenti, Einaudi, Torino; nuova edizione, 2009, Mimesis, Milano – Udine; p. 128).
La vita come la conosciamo sorge dall’evoluzione. La stessa teoria dell’evoluzione è un nostro modo, denso, di descriverci e raccontarci. Di tutte le estensioni sorgenti nella vita, l’esperienza estetica è forse una delle più incerte e dense di discontinuità e conflitti e, proprio per questo, tra le più generative. Un’esperienza in cui emozione, linguaggio e cognizione si fondono al massimo grado. L’umorismo nelle sue varianti molteplici, dall’ironia al comico, ci appare come una discontinuità immediata del senso, tanto densa quanto esplosiva, simultanea e improvvisa.
Nell’umorismo e nelle sue molteplici espressioni è all’opera una particolare tipologia di estensione che si scrolla di dosso la pressione del senso del mondo e apre a fessure, a sguardi fulminei, a simultanee emergenze capaci di detonazioni improvvise in grado di aprire a inauditi orizzonti di senso, a nuovi domini di significato.
“La satira non sceglie né conosce i suoi oggetti”, scrive Karl Kraus, “Nasce nella fuga da essi, che le premono addosso” (K. Kraus, 1955, Spruche und Widerspruche, Pro Domo et Mundo, Nachts, vol. Beim Wort genommen, Kosel-Verlag KG., Munchen; trad. it. parziale in Detti e contraddetti, a cura di R. Calasso, Adelphi, Milano 1972; p. 250).
Uno dei caratteri distintivi dell’assurdo charmsiano è la crisi del sistema conoscitivo, ossia la crisi del flusso corrente del senso della conoscenza (Daniil Charms, 1990, Casi, Adelphi, Milano; p. 11). Un uppercut al senso. L’interruzione del dominio di senso vigente è una detonazione improvvisa e provvisoria nella ricerca di significato. La nostra predominante propensione a persistere nell’immersione nel senso che distingue noi esseri umani come animali sense-makers, a un certo punto, per un processo preparato e allo stesso tempo imprevisto, per una interruzione del senso, si apre a un vuoto, uno scarto, che in un intervallo che dura un istante, prima dell’avvento di un senso conflittuale, libera una vaghezza da cui esplode il riso. La liberazione provvisoria da un dominio di senso pone in crisi l’ordine cognitivo e affettivo. Quel corto circuito del senso è una delle frontiere delle possibilità della mente umana e delle sue caratteristiche distintive protese alla ricerca di se stessa, al proprio margine e oltre.
Arthut Koestler sostiene che umorismo e creatività hanno strutture simili riconducibili alla “bisociazione”, percezione simultanea e improvvisa di una situazione e di un’idea (A. Koestler, 1964, The act of creation, Hutchinson, McMillann Publishers, 1964). Tutte le attività creative, lo humour, la scoperta scientifica e l’arte hanno in comune un processo di base, lo scarto del pensiero. Nel tentativo di comprendere l’umorismo come tratto espressivo distintivo della nostra storia evolutiva, il contributo di Koestler assume un rilievo particolare perché identifica un campo, un ambito, quello affettivo e cognitivo, che accomuna e ricomprende l’esperienza artistica, quella scientifica e quella umoristica.
Il programma di ricerca con cui stiamo tentando di comprendere per via storico-evolutiva e neurofenomenologica qualcosa di più di quell’area dell’esperienza umana che si esprime ai margini di noi stessi e del nostro cosmos, ma anche ai margini delle frontiere di noi, il nostro caos, che abbiamo proposto di chiamare tensione rinviante (U. Morelli, Mente e bellezza. Arte, creatività, innovazione, Allemandi & C, Torino 2010), cerca di individuare alcune caratteristiche distintive dell’emergenza estetica nella nostra vita relazionale-individuale e di specie. È in quell’ambito che si situa, con ogni probabilità, la capacità relazionale, linguistica ed emotiva dell’umorismo e dell’ironia con le loro molteplici varianti. Comprendere l’ironia e l’umorismo insieme alle loro varianti molto variegate significa giungere a riconoscere aspetti importanti della nostra distinzione di specie; vuol dire avere una possibilità in più per rispondere a domande cruciali su noi stessi.
In un’occasione Ludwig Wittgenstein osservò che “sarebbe possibile scrivere un’opera filosofica seria e di buona qualità che consista solo ed esclusivamente di barzellette”. Basterebbe prendere in considerazione il rapporto tra ambiguità e umorismo per accogliere questo orientamento. Se l’ambiguità è una proprietà costitutiva del vivente e non un difetto interveniente nelle relazioni, allora l’ironia e l’umorismo, con tutte le loro articolazioni, sono un’evidenza emergente dalle potenzialità generative dell’ambiguità. Non si tratta, infatti, con ogni probabilità, di prestare attenzione alla “meccanica”, per così dire, della preparazione-esplosione del riso nell’umorismo, bensì di riconoscere che la polisemia del senso e le sue crisi, i suoi break-down, sono generativi delle possibilità di emergere dai domini di senso effettivi e vigenti, nonché di aperture verso l’inedito e l’inaudito. L’ambiguità può certo divenire la melmosa e agglutinante palude in cui l’individuazione annaspa, scivola e si mortifica ma è, allo stesso tempo, la condizione sollecitante la tensione verso possibilità inedite. L’umorismo è una delle vie dell’elaborazione dell’ambiguità, una terra aperta al possibile.
È estendendoci che ci conosciamo, rivolgendo da quel punto di estensione contingente un altro sguardo ancora a noi stessi, andando oltre ed essendo sempre noi.
L’andare oltre dell’umorismo e del comico sembra il reciproco dell’insabbiamento e del melmoso in cui si caccia e ci caccia spesso il ridicolo.
L’umorismo e la satira, infatti, non coincidono col ridicolo. Far ridere non è ridicolizzare. Il ridicolo può manifestarsi come un fallimento, un degrado di quello che avrebbe potuto essere un risultato atteso: una possibile manifestazione di successo si trasforma in un tentativo mal riuscito di affermare un’idea o una posizione. Può manifestarsi anche come disagio o tentativo di un malcapitato che prova a fare una cosa senza riuscirci. Agli occhi di un umano il tentativo di accoppiamento delle tartarughe narrato da Italo Calvino in Palomar assume i caratteri del ridicolo.
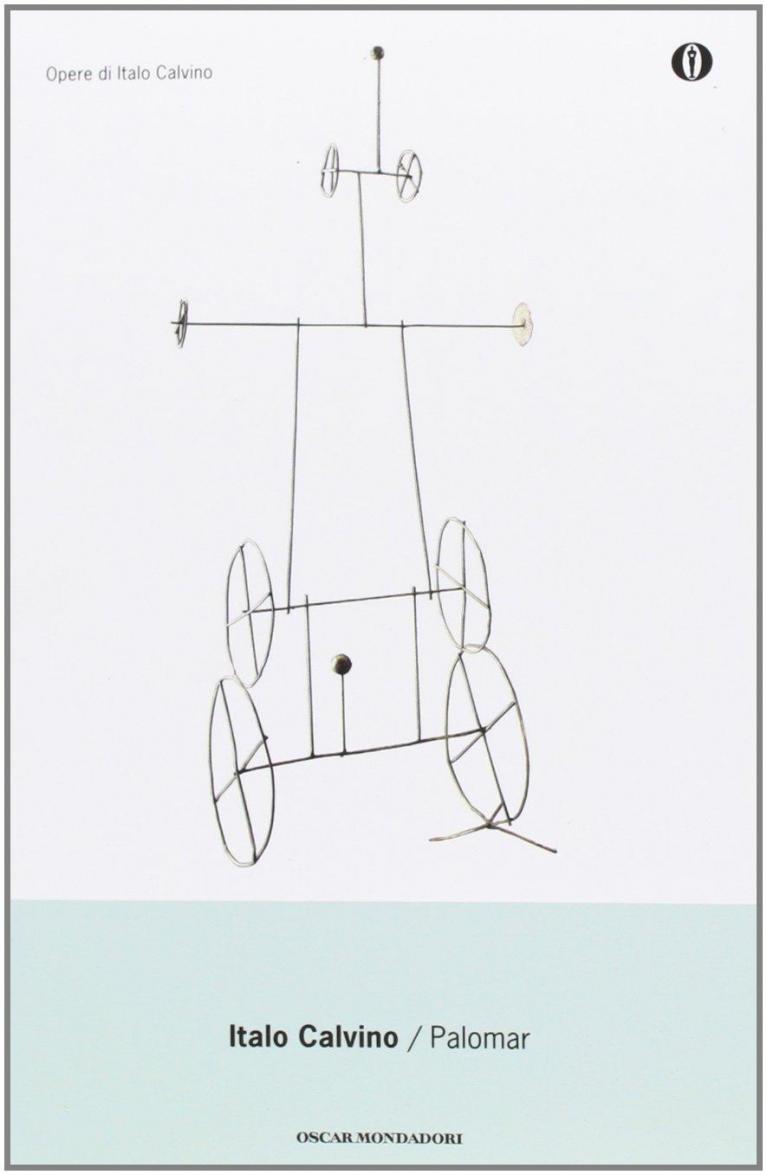
“Ci sono due tartarughe nel patio: maschio e femmina. Slack! Slack! I gusci sbattono uno sull’altro. È la stagione degli amori. Il signor Palomar, non visto, spia. Il maschio spinge la femmina di fianco, torno torno al rialzo del marciapiede. La femmina sembra resista all’attacco, o almeno oppone un’immobilità un po’ inerte. Il maschio è più piccolo e attivo; si direbbe più giovane. Prova ripetutamente a montarla, da dietro, ma il dorso del guscio di lei è in salita e lui scivola. Ora dovrebbe essere riuscito a mettersi nella posizione giusta: spinge a colpi ritmici, pausati; a ogni colpo emette un ansito, quasi un grido. La femmina sta con le zampe anteriori appiattite sul terreno, il che la porta a sollevare la parte di dietro. Il maschio annaspa con le zampe anteriori sul guscio di lei, tendendo il collo in avanti, sporgendosi a bocca aperta. Il problema con questi gusci è che non c’è modo d’afferrarsi, e del resto le zampe non fanno nessuna presa. Ora lei gli sfugge, lui la rincorre. Non che lei sia più veloce né molto decisa a scappare: lui per trattenerla le dà dei piccoli morsi a una zampa, sempre la stessa. Lei non si ribella. Il maschio, ogni volta che lei si ferma, tenta di montarla, ma lei fa un piccolo passo avanti e lui scivola e batte il membro per terra. È un membro abbastanza lungo, fatto a gancio, con cui si direbbe lui riesca a raggiungerla anche se lo spessore dei gusci e la positura malmessa li separano. Così non si può dire quanti di questi assalti vadano a buon fine, quanti falliscano, quanti siano solo gioco, teatro. È estate, il patio è spoglio, tranne un gelsomino verde in un angolo. Il corteggiamento consiste nel fare tante volte il giro del praticello, con inseguimenti e fughe e schermaglie non delle zampe ma dei gusci, che cozzano con un ticchettio sordo. È tra i fusti del gelsomino che la femmina cerca d’intrufolarsi; crede – o vuol far credere – che lo fa per nascondersi; ma in realtà quello è il modo più sicuro per restare bloccata dal maschio, immobilizzata senza scampo. Ora è probabile che lui sia riuscito a introdurre il membro come si deve; ma stavolta stanno tutti e due fermi fermi, silenziosi”.
Quando il gioco linguistico si fa esilarante e riesce a coinvolgere e tirare al limite equivoci e ambiguità, il ridicolo, il comico, l’umoristico, il satirico, si confondono e i confini tendono a scomparire in un vero e proprio calembour esplosivo. Il dizionario Treccani definisce calembour una freddura fondata su un gioco di contrapposizione o dall’accostamento di parole omografe o polisemiche (per esempio: “un professore che anziché fare lezioni di economia, fa economia di lezioni”; “un cretino può scrivere un saggio, ma non viceversa”) o dalla sostituzione, in una frase nota, di una parola con altra di suono simile ma di significato molto diverso.
Nella costruzione del ridicolo, attraverso il linguaggio, intervengono contemporaneamente i codici affettivi che reggono le espressioni verbali e non verbali (coinema); le caratterizzazioni culturali e valoriali dei linguaggi (etnema); le manifestazioni linguistiche e gestuali (fonema).
Tutto questo si può verificare con una delle più conosciute canzoni del repertorio napoletano, in cui il ridicolo è il tema stesso del testo: Ciccio Formaggio di Pisano-Cioffi, di cui riportiamo solo i ritornelli:
Si mme vulisse bene overamente,
nun mme facisse 'ncujetá da 'a gente,
nun mme tagliasse 'e pizze d''a paglietta,
nun mme mettisse 'a vrénna 'int''a giacchetta...
Si mme vulisse bene, o mia Luisa,
nun mme rumpisse 'o cuollo d''a cammisa...
Si mme vulisse bene overamente,
nun mme facisse 'ncujetá da 'a gente...
Nun mme tirasse 'e pile 'a dint''e rrecchie,
nun mme mettisse 'o dito dint'a ll'uocchie,
nun mme mettisse 'a neve dint''a sacca,
nun mme squagliasse 'ncapa 'a ceralacca!
Si mme vulisse bene overamente,
nun mme facisse 'ncujetá da 'a gente...
Nun mme menasse 'e streppe 'e rafanielle,
nun mme mettisse 'a quaglia 'int''o cappiello,
nun mme facisse stá, pe' n'ora sana,
cu 'a pippa 'mmocca e cu 'a cannela 'mmano!
Si mme vulisse bene overamente,
nun mme facisse 'ncujetá da 'a gente...
Nun mme pugnisse areto cu 'o spillone,
nun mme mettisse 'a colla 'int''o cazone...
Nun mme screvisse, cu nu piezzo 'e gesso,
aret''o matinè: "Ciccí' si' fesso!"
L’auto-ironia, nel caso di Groucho Marx, è un altro esempio degli sconfinamenti tra umorismo e ridicolo: “…zio Julius risolse ogni cosa tirando le cuoia e facendo di me il suo unico erede. Il suo patrimonio, alla verifica, risultò consistere in una palla da biliardo numero nove (rubata), una scatola di pasticche per il fegato e uno sparato di celluloide” (G. Marx, 1959, Groucho e io, Adelphi, Milano 1997; p. 41).
Condensazione, spostamento dei significati, rappresentazione delle cose tramite i loro opposti, trionfo della fallacia sulla logica; questi e altri appaiono i caratteri costanti dell’umorismo e della risata, che secondo Baruch Spinoza “altro non è che piacere e in quanto tale è buona di per sé”. Forse l’umorismo si associa principalmente al piacere e un aspetto peculiare del ridicolo è che si associa più facilmente al dispiacere (U. Morelli, Mente e bellezza. Arte, creatività, innovazione, op. cit.).
Il ridicolo a un certo punto si atteggia a sconfinare persino con l’assurdo, non perché sia incomprensibile quello che propone o perché offenda il senso comune, ma perché si colloca al margine, e relega in un margine chi ne è protagonista.
Un muro fortificato grava spesso sui significati consolidati fino a diventare canoni totalitari. L’umorismo e il comico ne sono potenti scardinatori, ma anche il melmoso ridicolo fa sovente la sua parte per aprire spiragli di dicibilità dell’inedito, magari in forma clandestina, come accade con l’uso combinatorio di ridicolo e assurdo. Il ridente, scrive Umberto Eco, è “colui che ha avuto coscienza della caduta, e quindi della provvisorietà dell’ordine dato” (U. Eco, Diario minimo, Bompiani, Milano; p. 94. Cfr. anche di U. Eco, 1983, Sette anni di desiderio, Bompiani, Milano; p.253 e segg.; e: 2001, Sugli specchi, Bompiani, Milano; p. 261). Anche il ridicolo e persino il ridicolizzato, per quanto situati al margine, possono essere almeno un poco elogiati per la loro funzione disvelante di un ordine di significati totalitario e oppressivo.
Diventa così, ridicola nella sua assurdità, la posizione corrosiva verso il potere del protagonista di questo racconto:
“C’era un uomo con i capelli rossi, che non aveva né occhi né orecchie. Non aveva neppure i capelli, per cui dicevano che aveva i capelli rossi tanto per dire.
Non poteva parlare perché non aveva la bocca. Non aveva neanche il naso.
Non aveva addirittura né braccia né gambe. Non aveva neanche la pancia, non aveva la schiena, non aveva la spina dorsale, non aveva le interiora. Non aveva niente! Per cui non si capisce di chi si stia parlando.
Meglio allora non parlarne più.”
[Daniil Charms, 1990, Casi, Adelphi, Milano; p. 11]








