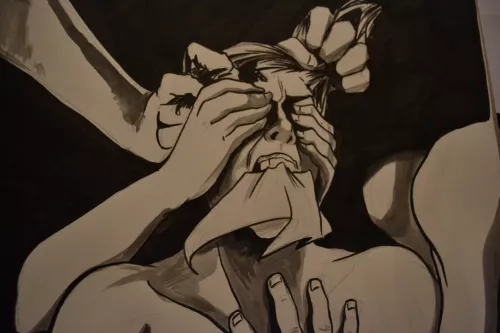Autosacrificio: il cambio di paradigma / Il martirio nell’Islam
Majd Ibrahim, giovane studente siriano fuggito in Europa, ha detto a Scott Anderson nel reportage pubblicato su “La Repubblica”, che “lo stato islamico non è soltanto un’organizzazione, è un’idea”. Da dove nasce questa “idea”? Meir Hatina, studioso israeliano, prova a rispondere a questo interrogativo in un libro, Il martirio nell’Islam moderno (ObarraO). Dal febbraio a oggi si contano 90 attacchi suicidi realizzati da ragazzi minorenni, compreso l’ultimo sventato in questi giorni. Benché la pratica del suicidio sia stata condannata per secoli nella cultura islamica, non c’è alcun dubbio che essa sia diventata da due decenni una vera e propria icona culturale. La parola “martire” significa testimone. Nella cultura cristiana lo sono gli apostoli testimoni delle parole e delle azioni di Cristo, e a maggior ragione i credenti uccisi per la loro fede durante le persecuzioni dei primi secoli. Un significato puramente religioso, che non si applica alle lotte politiche o etniche. Solo con la Riforma protestante il termine ha assunto un significato più ampio riferendosi a tutti “coloro che morivano o venivano torturati per motivi religiosi e politici”. Come mostra il cristianesimo, il martire non esiste senza la sua commemorazione e narrazione, prodotta da una comunità sia nella forma orale che scritta, e oggi video. Nelle tre religioni del Libro esiste quella che è definita “la rinuncia volontaria alla vita per amore di Dio”; il martire ha il compito, scrive Hatina, di “ristabilire la dimensione metafisica dell’esperienza umana” ridotta a causa del laicismo e dell’edonismo dominanti. Non si può negare che nonostante il “suicidio altruistico” sia stato svuotato di significato dai teologi cristiani, nel passato il sangue dei martiri è stato il seme della Chiesa, come scriveva Tertulliano. Nel Corano il termine arabo shahid compare con il significato di testimone: il mussulmano deve agire come testimone vivente per il resto del genere umano.

Una successiva lettura esegetica ha ampliato il significato della parola: al plurale, shahada, il termine sottolinea ora i piaceri del Paradiso destinati ad accogliere coloro che muoiono per la fede. In modo differente rispetto all’ebraismo e al cristianesimo, l’Islam ha santificato il martirio in battaglia contro gli infedeli, rovesciando la visione passiva che del martirio aveva il mondo cristiano: la Jihad. Su questo elemento s’è innestata la lettura del martirio proposta dalle varie organizzazioni estremistiche islamiche nel corso del XX secolo. Per Hasan al-Banna, fondatore dei Fratelli Mussulmani, la jihad ha un valore più sociale che militare. Per i Fratelli gli aspetti religiosi e educativi prevalgono su tutto, a controprova della superiorità morale dell’Islam contro le forze dell’eresia. Grazie alla predicazione e ai testi di vari leader religiosi il concetto di jihad si è esteso superando la distinzione tra una lettura difensiva e una aggressiva. Il cambio di paradigma riguardo l’autosacrificio avviene nel corso degli anni Settanta. ‘Abd al-Salam Faraj, un ingegnere egiziano della seconda generazione dei radicali sunniti, lega l’idea di jihad verso il nemico esterno alla jihad contro gli ipocriti governanti mussulmani dediti all’Islam solo in modo nominale, sostenitori delle corrotte leggi occidentali.
In un suo libretto spinge alla lotta contro i mussulmani stessi, spazzando via in questo modo il timore reverenziale verso la guerra civile che aveva dominato nei decenni precedenti. In parallelo a questo in Iran la vittoria degli ayatollah porta alla predica del martirio tra gli sciiti quale strumento di rivincita. Nel 1979, durante la guerra contro l’Iraq, Khomeini permette l’arruolamento dei ragazzini con più di 12 anni. Con le “chiavi del Paradiso” al collo ne muoiono a migliaia nelle battaglie, correndo contro le trincee degli irakeni quasi a mani nude. L’attesa del Paradiso, la promessa delle settantadue vergini dagli occhi neri che li attendono con il Profeta, diventa persuasivo. Sono gli Hezbollah libanesi, seguaci di Khomeini, a usare subito dopo questo strumento a colpi di attacchi suicidi. Il contagio si trasmette alla Palestina, dove l’occupazione israeliana, scrive Hatina, consolida dal punto di vista teologico l’autosacrificio, mettendo in sordina il divieto islamico del suicidio. Senza una comunità che l’accetta e sostiene, la pratica del martirio non attecchisce. Nel corso degli anni Ottanta il movimento di Jihad Islamico ha prodotto una teologia della liberazione avversa a Israele, che ha legittimato l’ethos dell’autosacrificio. Citando un versetto del Corano che recita: “Non uccidete il vostro prossimo che Dio ha reso sacro, eccetto che per la giusta causa” (Sura VI, 151), i teologi della jihad hanno promosso l’idea della “giusta causa”. La “bomba umana” è stata santificata anche da Hamas, trasformata in una “norma sociale”. In questa prospettiva si è inserita Al-Qa’ida. Con il suo messaggio millenaristico venato di utopismo, l’organizzazione di Bin Laden ha portato l’idea di un’entità sovranazionale.
Le polemiche interne all’islamismo radicale hanno messo in luce quanto fosse impossibile il progetto di Al-Qa’ida dell’jihad universale contro il mondo degli infedeli, spostando così l’obiettivo verso la creazione di uno stato islamico base di una futura lotta. Lo scopo è quello d’impiantare una teocrazia islamica territoriale, cosa che è avvenuta con l’Isis, senza però cessare gli attacchi suicidi come mostrano gli avvenimenti di questi giorni. A quali conclusioni arriva il libro? La prima più evidente è che l’Occidente, a causa della sua secolarizzazione, ha smesso da tempo di considerare la religione una priorità fondamentale; la violenza “santificata” dell’Islam radicale appare incomprensibile agli occidentali. In un contesto di forte individualismo culturale e pratico, morire per una causa non solo suscita incredulità, ma è visto “come lo spreco di una vita preziosa”. La definizione di “fanatismo” da sola non riesce a spiegare la pratica del martirio.
Uno psicologo, Mordechai Rotenberg, sostiene che l’Islam estremistico ha indotto nei suoi fedeli “una resistenza metafisica alla paura della morte grazie soprattutto alla particolareggiata enumerazione ed esaltazione delle ricompense future”. C’è in questo credo il timore della vecchiaia e del trapasso, e anche l’aspirazione a un’eterna giovinezza nell’aldilà incorporata nella tradizione coranica, quale risposta alla tormentosa questione sulla fine della vita e alla corruzione del corpo; quest’ultimo aspetto, presente anche nel cristianesimo delle origini con la resurrezione dei corpi, è oggi quasi scomparso. Ha ragione Majd Ibrahim: sono le idee che determinano il destino dei singoli e dei popoli. Noi occidentali, dopo averne fatto largo uso fino all’altro ieri, ora le minimizziamo nel nostro pragmatismo, mentre altre culture, forti della fede religiosa, le accentuano così da condizionare la nostra stessa esistenza.
Una versione più breve di questo testo è apparsa su La Repubblica.