Cervelli diversi
“Professoressa ti ho sognata! Ho sognato che eri una ciambella!”
Questa è la frase con cui E. mi saluta tutti i giorni. È un’affermazione che mi fa sorridere, ma che allo stesso tempo mi porta a interrogarmi.
Perché mi vede come una ciambella?
Ho iniziato a lavorare nell’ambito del sostegno più per necessità che per vocazione poiché, nel mondo della scuola, tocca adattarsi.
Come spesso capita però ho completamente rivalutato le mie convinzioni.
Le ore di sostegno, inizialmente ritenute un passaggio obbligato per arrivare all’ambita cattedra di lettere, si sono rivelate preziose ed entusiasmanti.
Sono incappata quasi casualmente in Neurodivergente. Capire e coltivare la diversità dei cervelli umani (Edizioni Tlon), il bel saggio di Eleonora Marocchini (psicolinguista e ricercatrice in psicologia e scienze cognitive) che analizza la complessa questione delle neurodivergenze con un’attitudine, oltre che inconsueta, brillante e originale, facendo dialogare scienze mediche, studi sociali, post su blog e social network, celebri studiosi e movimenti dal basso.
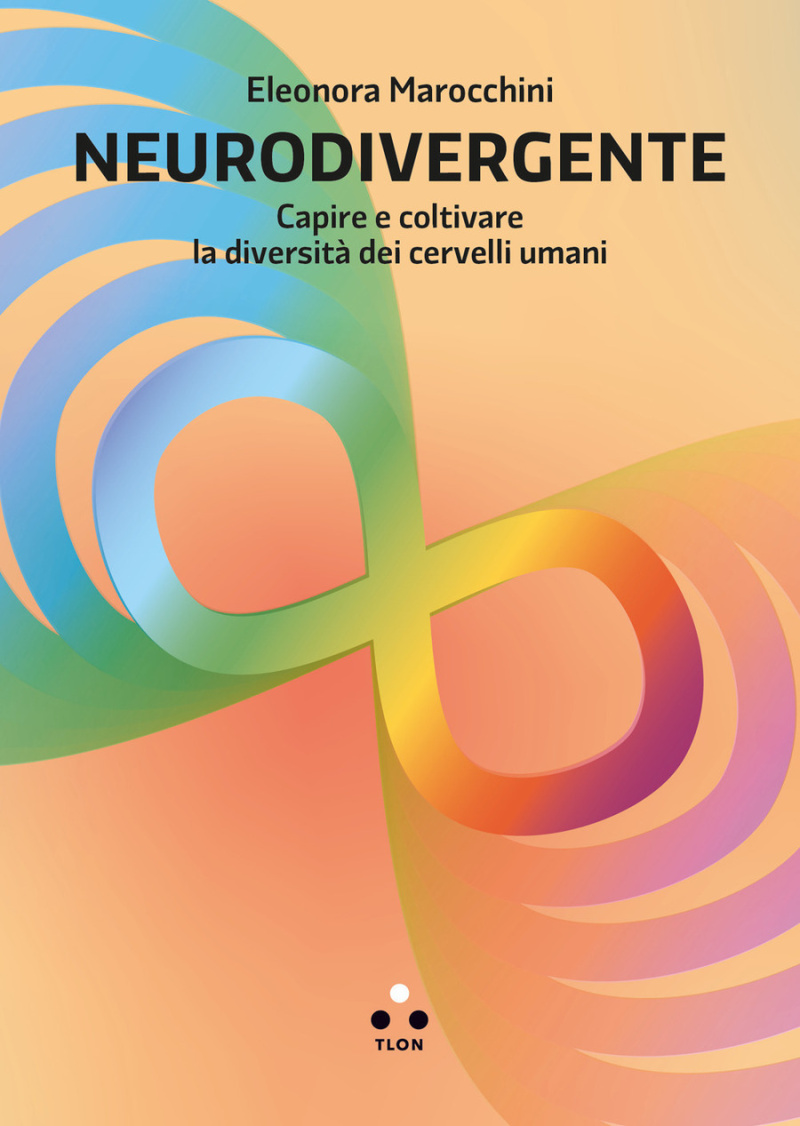
Il saggio inizia spiegando che cosa si intende per neuroatipicità, vale a dire la parola che la comunità medica e psicologica utilizza per distinguere ciò che è tipico a livello cerebrale e cognitivo (nel senso di statisticamente comune) e ciò che non lo è.
Nel grande recipiente semantico che implica il termine neuroatipico, ritroviamo tutte quelle condizioni sia presenti dal neurosviluppo (autismo, disprassia, ADHD, DSA ecc.) sia acquisite in seguito a un trauma fisico o causate da una psicopatologia.
Un altro valore acquisisce invece il termine neurodiversità, attribuito alla sociologa Judy Singer secondo alcuni e allo scrittore Harvey Blume per altri. Non è importante chi dei due abbia per la prima volta generato questa espressione quanto l’idea comune ai due studiosi che ha portato a coniare la parola in questione.
“Proprio come la biodiversità è importante per la sopravvivenza della specie, così doveva essere la diversità umana per la specie umana”.
Neurodiversità è infatti un termine che affonda le sue radici nella volontà di dare vita a un movimento sociale, una comunità per gruppi neurologici marginalizzati che segua il modello e si inserisca tra i movimenti femministi, per la disabilità, per la liberazione omosessuale ecc.
Questa parola infatti, sin dalla sua nascita, si costituisce con il desiderio di integrare una pluralità di vissuti traducendosi quindi in un movimento sociale.
Estremamente influente è anche la sua diffusione attraverso i social network, che come ricorda l’autrice, hanno grandi effetti sulla cultura psicologica. I social per definizione sono accessibili a un’utenza vasta e variegata, a differenza della ristretta cerchia di contesti relativi alle scienze mediche e psicologiche.
Il termine neurodivergente diventa simbolo di un senso di appartenenza, di un vissuto intimo e spesso di una questione identitaria.
Inizialmente sul web ed in seguito offline, questa parola si è connessa all’attivismo e all’advocacy sulla disabilità. Oggi è diventata di uso comune tra le persone (anche non appartenenti alla comunità), nelle scuole e in ambito sanitario.
Un altro aspetto che è bene segnalare è come la nascita di comunità neurodivergenti abbia sollecitato una ricerca sul linguaggio anche in ambiente accademico e che in contemporanea molti gruppi scientifici abbiano iniziato a utilizzare paradigmi di ricerca più o meno partecipati o partecipativi volti a ridare equilibrio o quantomeno a interrogare gli squilibri di potere tra chi fa ricerca e chi è oggetto di studio.
Per quanto ancora (purtroppo) questa attitudine risulti rivoluzionaria, vi è stata una spinta all’ascolto, spesso anche complesso, delle comunità neurodivergenti (che sono molteplici e a volte anche in disaccordo tra loro) soprattutto per quanto riguarda la ricerca di un lessico adeguato, fondamentale non solo per questioni etiche, ma anche perché spesso alcune classificazioni desuete risultano inefficaci nel descrivere le sfumature dell’esperienza individuale.
Dopo lo scioglimento di questa importante questione linguistica, l’autrice sposta il focus su un discorso ancor più complesso, vale a dire il tema della funzionalità.
Nel 1980 venne pubblicata la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), che definisce il funzionamento di ogni persona in ogni dominio specifico come «un’interazione o una relazione complessa fra la condizione di salute e i fattori contestuali (cioè i fattori ambientali e personali)». L’ICF riconosce che l’interazione tra queste entità è dinamica e specifica e non sempre in una relazione biunivoca prevedibile.
Una persona può infatti avere “menomazioni” senza che queste abbiano influenza sulla sua performance (ovvero la difficoltà che incontra nel fare ciò che desidera nel suo ambiente) oppure può avere problemi nella performance senza menomazioni (un buon esempio può essere quello di una persona neurotipica, le cui abilità sociali sono diminuite in maniera significativa a causa di una lunga permanenza in un carcere o in un istituto di cura).
L’ICF si dichiara infatti neutrale rispetto alle cause, ma più interessato al funzionamento dell’individuo rispetto al suo ambiente.
Questo approccio dal quale non si può prescindere, anche nell’ambito del sostegno a scuola, rivela però dei limiti; è infatti complesso applicare questo sguardo nella pratica quotidiana che sia clinica o educativa.
Spesso l’ambito sanitario (medico, psichiatrico, psicologico) ha una visione chiara del contesto in cui l’utenza è immersa. D’altra parte chi ha un ruolo educativo (genitori compresi) o di docenza, di rado ha avuto una formazione (anche clinica) sulla disabilità.
L’autrice osserva inoltre che questo approccio, definito biopsicosociale, non è ancora realmente impiegato sul piano pratico. Continua ad essere prevalente un metodo, e allo stesso tempo una terminologia, più o meno medicalizzata (come si diceva prima), che relega il contesto sociale in una posizione di minore importanza.
A questo proposito trovo interessante e illuminante il ragionamento sul tema dell’ADHD, acronimo che, tradotto in italiano, sta per Disturbo da Deficit di Attenzione.
In molti ritengono che l’ADHD sia sovradiagnosticato nell’infanzia con l’intento di patologizzare una persona estremamente vivace (ADHD iperattivo) o particolarmente pigra (ADHD disattentivo).
È infatti piuttosto comune leggere articoli che spiegano come in una società caratterizzata da un grande aumento di stimoli e distrazioni, siano inevitabilmente aumentati i problemi di attenzione, che in fondo sono estendibili alla maggioranza della popolazione.
Sicuramente le pressioni capitalistiche alla produttività, l’impatto dei social media, della pubblicità e dell’uso costante di smartphone e altri dispositivi tecnologici ha aumentato il calo dell’attenzione. Velocità, intrattenimento, immersività, sono tutti aspetti che hanno reso la popolazione più deconcentrata e affaticata. Inoltre sia a scuola che nel lavoro è aumentato il bombardamento informativo e produttivo; la maggior parte dei lavori richiede capacità attentive maggiori rispetto al passato, fini competenze di pianificazione, abilità nelle relazioni sociali (pensiamo alle call continue che pretendono predisposizione a persone, situazioni e richieste diverse).

Infatti, non a caso, molte domande nei test di screening per l’ADHD riguardano abilità scolastiche e lavorative, la difficoltà a concentrarsi su lavori ripetitivi, attività pianificate ecc.
I problemi a gestire tutte queste richieste – che è vero, sono aumentate per tutta la popolazione – esistevano prima ed esisterebbero anche in una società priva di questo bombardamento. Le richieste sono maggiori e faticose per chiunque, ma lo sono maggiormente per chi diverge dalla norma sempre più restrittiva che la nostra epoca richiede.
Qui si torna al modello biopsicosociale; la neurodivergenza sussiste, ma il funzionamento potrebbe essere ottimale, ad esempio, per una persona con ADHD che invece di lavorare in una metropoli, in un ufficio affollato e rumoroso in cui si richiede ai dipendenti una frenetica pianificazione e organizzazione, fosse impiegata ad esempio in una società rurale in cui la maggior parte della popolazione si occupa di attività agricole.
La comunità interessata risponde stringendosi attorno alla creazione di una cultura neurodivergente fatta di suggerimenti su come aggirare la paralisi che costringe sul divano o come rispondere alle conversazioni vuote sul lavoro, su come organizzare i compiti durante la giornata, come non dimenticare per l’ennesima volta le chiavi di casa.
Di recente, suscitando in me una sensazione di impotenza e dispiacere, G., adolescente a me estremamente vicina non in ambito lavorativo, ma familiare, ha avuto un momento di forte scoraggiamento emotivo causato dalla banale perdita di una matita.
Disperata mi ha detto: “non ce la faccio più, sono stanca di perdere ogni cosa”.
Un’altra tematica interessante, fortemente interconnessa alla nostra società, è quella relativa alla percezione dell’autismo. Da una parte questa parola evoca l’idea di una grave patologia che porta incomunicabilità e sofferenza (anche se fortunatamente oggi sappiamo che l’autismo è uno spettro dalle infinite combinazioni di caratteristiche sensoriali, comportamentali e intellettive e che soprattutto non ci dice nulla di certo sulla vita di una persona). Dall’altra vi è una cultura di massa – soprattutto amplificata da film e serie TV, che rappresenta la persona autistica o come disumana in quanto fredda e priva di empatia o come intelligente (troppo?), eroica e geniale.
Le rappresentazioni mediatiche sono figlie del tempo e dello spazio in cui sono pensate, ma troppo frequentemente sono caratterizzate da una disumanizzazione.
Spesso le persone nello spettro autistico vengono recepite e “comunicate” in accezione strumentalmente positiva laddove le loro peculiarità li portano ad eccellere e funzionare “meglio” rispetto alla norma per quanto riguarda ciò che richiede la società capitalistica. Si pensi a casi come quello di Steve Jobs o di Elon Musk.
Il tema delle neurodivergenze si interseca anche con le questioni queer.
Sempre a proposito di funzionalità non si può non porre l’accento su uno dei presupposti più citati delle teorie queer, vale a dire che il concetto di genere è interconnesso alla capacità di performare, in altre parole è legato al funzionamento dell’individuo.
Secondo Judith Butler infatti il genere non è altro che una performance sociale, si apprende a “fare” e “impersonare” il proprio genere in base alle norme del binarismo di genere e di come i generi binari imposti dalla società (il maschile e il femminile) dovrebbero interagire tra di loro.
Secondo molti Studi Queer infatti le azioni che intraprendiamo per performare il nostro genere (modi di vestirci, truccarci, muoverci ecc.) costituiscono di fatto il nostro genere. Azioni a cui dobbiamo aderire sin dall’infanzia.
In relazione all’autismo è emerso che vi sia una fatica nella comprensione del genere come costrutto sociale e che quindi la capacità di emulare socialmente ciò che cultura e educazione ci hanno portato a definire maschile o femminile risulti estremamente più difficile.
In una società neuronormativa, eteronormativa, cisnormativa ecc., le persone neurodivergenti attuano un ribaltamento perenne con ogni azione che compiono, spesso sfidando più di un binarismo.

Troppo funzionamento o troppo poco, ciò che è certo che tutti coloro che faticano a performare e a camuffarsi abilmente in ciò che è ritenuto la norma incappino spesso in sofferenze ed estenuanti difficoltà.
Mi accorgo con le ragazze e i ragazzi a scuola quanto sia complesso avviare un reale processo di inclusione, quante siano le frustrazioni dovute alla difficoltà di eseguire compiti standardizzati e ragionati sulla maggioranza, quanto sia complicato far comprendere in profondità alle classi (costituite da neurodivergenti e neurotipici) che l’uso di una calcolatrice o delle mappe per alcuni di loro è un diritto e non un vantaggio.
Credo che il tema della neurodivergenza debba coinvolgerci tutti e tutte, come dovrebbero coinvolgerci tutte le lotte per l’acquisizione di diritti che portano avanti le comunità marginalizzate.
Tutti i giorni a scuola mi relaziono a persone che nel non aderire a compiti e richieste di una società sempre più competitiva, omologata e consumistica, è come se ne svelassero i limiti; è come se attraverso il loro sguardo, le loro parole o i loro comportamenti riuscissi a vedere gabbie e frustrazioni di cui io stessa sono prigioniera.
Le mie ore di sostegno sono una lotta con me stessa, con una visione a volte estremamente rigida che cerco di rimodellare per coinvolgere culturalmente i miei studenti attraverso canali diversi.
La neurodivergenza è una lente per osservare un sistema economico e sociale che non ammette differenze, introversione, inclinazioni, orientamenti sessuali e molto altro e che spesso obbliga le persone a soffocare fastidi e sofferenze in virtù della neurotipica capacità di adattarsi e performare anche sacrificando il proprio benessere psichico. Un sistema spaventato da ciò che ne mette in luce le falle a cui penso dovremmo iniziare a ribellarci.
E. mi vede come una ciambella, probabilmente soffice e dolce, ma con un buco al centro. Quel buco mi interessa e continuerò a interrogarmi su quale significato abbia per lei, su quali siano i miei buchi, quali voragini veda in me, circondate però da qualcosa che la rassicura.
In una ciambella mi ci rivedo in fondo.
In copertina, opera di Kate Cooper, We Need Sanctuary 2018.







