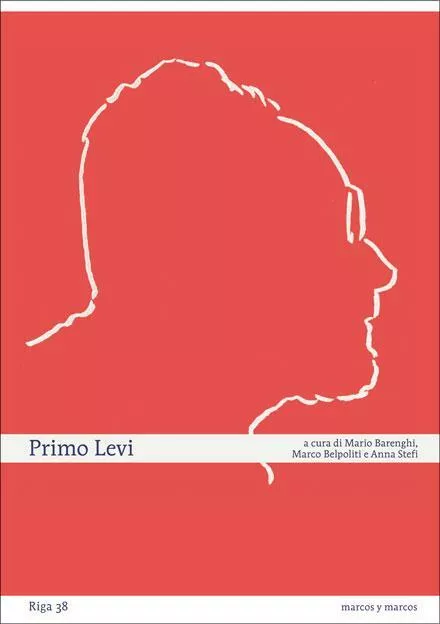Il nuovo volume della collana Riga / Primo Levi e Israele
Conoscere il rapporto tra Primo Levi e lo Stato di Israele a prescindere dall’esperienza tragica e pregnante di Auschwitz è impossibile. Quella che Levi stesso ha definito come l’esperienza della sua vita ha modificato certamente l’opinione dello scrittore, senza tuttavia modificarne la sua natura di uomo mite, pacato e riflessivo.
È interessante allora analizzare l’evoluzione di tale rapporto alla luce del suo essere un ebreo della Diaspora, sopravvissuto ai campi di concentramento e in virtù degli eventi storici che hanno segnato gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del Novecento.
A partire da tre racconti in particolare del Sistema Periodico: Argon, Zinco e Oro Levi mette in evidenza i primi momenti in cui la componente ebraica ha fatto capolino nella sua vita, designandolo come qualcosa di più rispetto a un italiano, borghese, di professione chimico.
Determinante sarà poi il periodo vissuto nel campo di concentramento di Auschwitz senza il quale non sarebbe emersa in maniera determinante la coscienza divisa che Levi avrebbe finalmente attribuito non solo a se stesso, ma anche alla moderna identità ebraica nella Diaspora come tale. Durante la sua permanenza tragica nel Lager, Levi avrà modo di entrare in contatto con l’ebraismo come mai lo aveva conosciuto. Un ebraismo diverso da quello occidentale, che va oltre la componente culturale e che, come dice Amos Luzzatto, “aveva caratteri di una congregazione religiosa minoritaria rappresentata soprattutto da un ceto medio commerciale e professionale, che si riconosceva nelle proprie tradizioni e nelle ricorrenze, ma generalmente si assimilava alla maggioranza nella vita di tutti i giorni”. Qui Levi scopre la grande realtà ebraica dell’Europa centro-orientale e con essa tutte le sue sfumature religiose.
Ma gli incontri con il mondo ebraico orientale non si fermano all’inferno concentrazionario. Il più significativo incontro che fece Levi nel suo viaggio di ritorno fu quello con dei giovani sionisti diretti in Palestina che attaccarono il loro vagone al treno di Levi e dei suoi compagni. Questi ventenni, liberi e pieni di speranze verso una Terra Promessa mitica e millenaria, rimasero profondamente impressi nella mente dello scrittore. Non a caso saranno una delle fonti di ispirazione per il suo romanzo sugli ebrei orientali Se non ora, quando? Pubblicato nel 1982.
Certamente Levi conosceva già il sionismo e la propaganda sionista avendola ascoltata in gioventù quando i molti pionieri lasciavano la Palestina per invitare gli ebrei della Diaspora a fare ritorno in Terra Promessa e realizzare il sogno mai sopito dello Stato d’Israele. Secondo il suo stesso resoconto, Levi era stato presto attratto dagli ideali sionisti e tuttavia non provò mai il desiderio di unirsi a loro. Sentiva che, a differenza di molti altri ebrei, lui aveva già un posto da poter chiamare “casa” e aveva in quella terra, l’Italia e più in generale l’Europa occidentale, i padri culturali che contribuirono a formarlo come uomo e poi come scrittore.
Io sono ebreo come anagrafe, vale a dire che sono iscritto alla comunità Israelitica di Torino, ma non sono praticante e neppure sono credente. Sono però consapevole di essere inserito in una tradizione e in una cultura. Io uso dire di sentirmi italiano per tre quarti o per quattro quinti, a seconda dei momenti, ma quella frazione che avanza, per me è piuttosto importante. E so benissimo che esistono infinite altre culture, degne di essere studiate e seguite. Fra queste c'è anche la cultura ebraica, in Italia non molto fiorente, per ragioni numeriche, se non altro, molto fiorente altrove, ed era molto fiorente proprio nell'Europa orientale al tempo dello scatenamento della seconda guerra mondiale. E una delle fonti di questo mio libro Se non ora, quando?, è proprio il desiderio di imparare io stesso a portare davanti al lettore italiano alcuni aspetti meno noti di questa cultura, per esempio l'autoironia; per esempio questo desiderio straordinario di gioia attraverso la miseria, la persecuzione, la strage.
Il rapporto che intrattenne Primo Levi con l’ebraismo e con lo Stato d’Israele fu in continuo divenire per tutta la sua vita. Quando dopo la guerra, la prospettiva di uno Stato ebraico si fece sempre più reale, alla luce anche della consapevolezza dell’Olocausto, Levi si mosse in una concezione della Diaspora che sempre aveva sostenuto: l'attaccamento al principio di una patria ebraica che non comportava un impegno a emigrare o vivere lì. È importante ricordare che anche durante il periodo di undici mesi tra la liberazione di Levi dal campo di concentramento di Auschwitz e il suo ritorno a casa, quando ancora ignorava ciò che avrebbe trovato della sua famiglia e della sua casa a Torino, Levi non riferì mai di considerare la Palestina come opzione personale. Questo atteggiamento persistette anche dopo la Guerra d’Indipendenza di Israele del 1948. Quando la prospettiva di uno Stato ebraico diventò reale, Levi si trovò sempre ad agire e pensare all’interno della Diaspora stessa, come se quella fosse la sua vera patria ebraica. Tuttavia, il suo impegno per sostenere il nuovo Stato d’Israele, tra la schiera di personalità ebraiche italiane che si impegnarono in tal senso, non fu minoritario. Si unì infatti a manifestazioni pubbliche di solidarietà a causa della preoccupazione per la prospettiva di una guerra con l’Egitto nella primavera del 1967, che come molti, considerava come una minaccia per l’esistenza di Israele. Il corrispondente senso di sollievo per la vittoria dello Stato ebraico nella Guerra dei Sei giorni culminò nella sua unica visita in quella terra. Durante il suo soggiorno ebbe modo di fare un primo confronto tra la cultura ebraica che conosceva e quella che si stava creando in Israele, un paese molto diverso dalle sue aspettative. La prima impressione che ebbe lo scrittore fu che “Israele non è Europa”. Sebbene avesse raccolto al suo interno tutte le genti che erano sono mosse da quei luoghi dopo la Seconda guerra Mondiale, Israele era uno stato che mancava di quel “sedimento storico che rende una l’Europa da Gibilterra agli Urali”. La natura di questa Israele era duplice: nuovissima e antichissima allo stesso tempo. Ma non poteva essere considerata un baluardo dell’Occidente a Oriente.
In ogni caso, dopo la sua visita, Levi non era più incline a considerare l'emigrazione in Israele di quanto lo fosse in precedenza; se non altro, la visita rafforzò la sua visione della vitalità della Diaspora ebraica e anche della sua importanza per sostenere in sé Israele, un ruolo che, agli occhi di Levi, si ribalta a quello previsto dal tradizionale sionismo. Quindi, se da una parte la necessità dello Stato d’Israele è evidente e sotto gli occhi di tutti, dall’altra non va sottostimata l’importanza storica della Diaspora che è densa di storia di persecuzioni ma anche di scambi e rapporti interetnici e rappresenta una scuola di tolleranza. Questa prospettiva della Diaspora non era rara né nel tempo né in quel momento ed è stata intensificata per Levi dai suoi ideali politici generalmente antinazionalisti e dall'umanesimo morale che sentiva sempre più in conflitto con quello che considerava una crescente tendenza nazionalistica in Israele.
L’impegno di Levi nel difendere l’ebraismo e lo Stato ebraico continuarono negli anni ma da una prospettiva diversa. Se prima il pericolo era esterno, a partire dagli anni Settanta Levi vede in Israele il nodo del problema. Levi non esita, insieme ad altri ebrei italiani, a condannare pubblicamente le decisioni prese dal governo israeliano di Menachem Begin che, oltre ad aver perso di vista i principi alla base di Israele, stava trasformando il Paese in uno stato militarista.
L’evoluzione del pensiero leviano circa lo stato di Israele e la Diaspora segue di fatto un percorso cronologico ed è strettamente legata alle questioni storiche e politiche che interessarono il mondo ebraico. Dopo la fondazione dello Stato di Israele avvenuta nel 1948 i rapporti tra il giovane stato e i paesi arabi confinanti non furono mai del tutto pacifici. Il problema, agli occhi degli stati arabi del territorio, era che l’Islam aveva sempre tollerato le diversità religiose, ma questo era qualcosa di diverso. Veniva chiesto loro di accettare una sovranità ebraica in pieno territorio islamico. Quando le tensioni scoppiarono e i paesi arabi iniziarono a parlare di “sterminio del nemico” a Primo Levi tornarono in mente le parole usate dai nazisti contro gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 31 maggio 1967 alla Sinagoga di Torino la Comunità Israelitica promosse una manifestazione a cui parteciparono migliaia di persone, ebrei, ortodossi, cattolici, valdesi, cittadini normali e autorità. Durante la manifestazione parlò anche Primo Levi. Il suo intervento ebbe come titolo Più d’ogni altro paese Israele dovrà vivere. In questo discorso, Levi si mostra preoccupato per la situazione in Israele, rifiuta di invocare l’aiuto di Dio per una strage e respinge ogni idea di guerra santa.
Nell’intestazione si trova già il primo spunto di riflessione. Perché Levi dice che Israele ha diritto di vivere più di ogni altro paese? Qual è il valore speciale che lo scrittore attribuisce allo Stato ebraico? Israele è nato in un momento storico unico, per cambiare le sorti del popolo ebraico. L’obiettivo era creare un Paese che fosse una zattera di salvataggio, “un santuario a cui avrebbero potuto accorrere gli ebrei minacciati negli altri paesi”. Israele era dunque, agli occhi di Levi il rifugio per eccellenza, un luogo sicuro, lontano dall’odio e dai conflitti. L’azzardo di Levi nell’attribuire un compito così importante a uno Stato così giovane deriva forse dall’ideale millenario di patria di uno stato ebraico che ogni israelita si portava dentro. E sebbene egli non sia mai stato sionista né tantomeno subì il fascino dei primi pionieri che colonizzarono quelle terre e crearono i primi kibbutz, in cuor suo non può far altro che appoggiare quello Stato che per millenni fu solo una chimera e che ora invece stava giungendo a piena realizzazione. Minacciare l’esistenza di Israele voleva quindi dire minacciare l’umanità stessa e i suoi tentativi per superare dispersione, discordia e sofferenze e realizzare una comunità in cui lingue, origini e razze diverse possano infine arrivare a una convivenza civile.
Ma perché Levi si sente così legato ad Israele sebbene non sia sionista? Nell’appello, lo scrittore risponde anche a questa domanda. Come lui, ogni ebreo è legato intimamente allo Stato ebraico perché esso nasce a garanzia e suggello che quanto accaduto non si ripeta mai più. Israele è quindi “il paese del ritorno” unico e insostituibile, nel quale ogni ebreo può trovare un posto da chiamare casa.
Quando il timore di una guerra per Israele si concretizza, Levi interverrà di nuovo. Nei giorni del conflitto che “segnerà lo spartiacque nella coscienza politico culturale della diaspora ebraica”, Levi sarà ancora una volta in prima linea a manifestare il suo sostegno per Israele. Il documento, pubblicato sulla rivista «Il Ponte» è collocabile nell’area di sinistra di cui faceva parte il gruppo di ebrei torinesi firmatari dell’appello.
La difesa che questi intellettuali fanno di Israele è moderata, certamente non oltranzista, che riconosce cautamente la situazione araba così come le responsabilità dell’imperialismo, arrivando anche a menzionare la guerra in Vietnam. Per Levi e gli altri ebrei torinesi, il fatto che Israele fosse alleato degli Stati Uniti non doveva assolutamente essere una giustificazione per l’odio anti-ebraico. Se era vero che gli Usa stavano portando avanti una guerra terribile, condannata da molti, nelle vesti di “superpotenza imperialista”, Israele non ne era responsabile né tantomeno stava partecipando al conflitto e quindi era erroneo definirlo “una pedina dell’imperialismo”.
I timori di Levi cambiarono quando, al termine della Guerra dei Sei giorni, fu chiaro ormai a tutto il mondo che Israele era diventato una potenza militare che non solo sapeva difendersi ma anche attaccare e vincere. In una lettera, scritta il 17 giugno 1967 alla bibliotecaria tedesca Hety Schmitt-Maas, lo scrittore espresse un nuovo tipo di timore che, per un attimo, fece passare in secondo piano “i problemi di Auschwitz” nel quale era solito vivere. Certamente Levi non negava che una sconfitta sarebbe stata quanto di più atroce potesse accadere, ma era la guerra in sé che egli rifiutava e detestava. Infatti, dopo una prima sensazione di sollievo alla notizia della vittoria di Israele, Levi rifletté sull’evoluzione che, a vent’anni della sua nascita, Israele aveva subito. Israele non era più, agli occhi di Primo Levi, il paese modello, la terra dell’uguaglianza e della giustizia e del lavoro ma era divenuto un Paese come gli altri “buono a combattere e litigare, incline all’orgoglio nazionale”. Scrisse Levi, nella lettera a Schmitt-Maas “Israele, dal suo inizio, ci ha abituati a tali miracoli che noi speravamo potesse compiere il meglio, il solo vero miracolo, quello di stabilire una pace permanente con i propri vicini”. In quel momento Levi aveva come l’impressione che Israele avesse perso il suo vantaggio morale. Quel vantaggio che portava con sé dai tempi del Nazismo e del Fascismo e che vedeva gli ebrei schierati completamente dalla parte della ragione. Sebbene non avesse grandi colpe, qualche errore, secondo lui, Israele lo aveva commesso. La preghiera di Levi era che il processo di pace, ancora tutto in divenire, avvenisse senza errori.

Il sentimento di delusione che visse in Levi dopo la Guerra dei Sei giorni si alimentava anche di un’altra questione, quella degli stati amici e nemici di Israele. L’Unione Sovietica rimase delusa dall’esito della guerra dei Sei giorni: la vittoria di Israele aveva disatteso le speranze di un maggior controllo sull’area araba così ricca di petrolio. Al termine del conflitto si realizzò quindi un’insanabile rottura delle relazioni diplomatiche tra Israele e i paesi del blocco sovietico (fatta eccezione per la Romania). Da quel momento l’Urss cercò con tutti i suoi mezzi politici e diplomatici di isolare Israele mentre il Cremlino ribadiva il suo appoggio al mondo arabo. Parallelamente alla propaganda antisemita e antisionista di Stalin, anche nella sinistra italiana le cose cambiarono. Il Pci fu il primo partito italiano a professare la sua vicinanza al mondo arabo e le motivazioni non erano da ricercare solo nella vicinanza con Mosca. Tra gli intenti vi era anche quello di accentuare le divisioni interne al Psu, il partito rivale nell’area di sinistra che aveva come leader Pietro Nenni, la cui linea filoisraeliana non era pienamente condivisa da tutto il partito. A Israele venne imputata una natura bellicosa che impediva di fatto ogni tipo di coesistenza pacifica con il popolo arabo. L’Unità, il 5 giugno 1968, primo anniversario della guerra dei Sei Giorni, arrivò persino a sostenere che la tesi secondo cui “gli ebrei israeliani hanno rischiato e rischiano lo sterminio” era “un’abile mossa propagandistica”.
Levi guardava con grande delusione ai comunisti italiani e a tutti coloro che in gran fretta avevano sentito il desiderio di schierarsi dalla parte dei sovietici e di sposare le loro opinioni in politica estera. Il dolore nasceva dal ricordo di Levi di un’alleanza ormai lontana tra i comunisti e gli ebrei nella Resistenza italiana e ora, sentenzia lo scrittore, “davanti alla ‘Ragione di Stato’ sono pronti a dimenticare i sentimenti umani e anche il buonsenso”.
L’ebraismo italiano, in virtù delle sue forti tendenze comuniste e socialiste, ebbe reazioni differenti. Alcuni scelsero la strada del socialismo, altri rilanciarono il sionismo socialista, altri ancora scelsero di non rompere con il Pci. A partire dal 1967, con l’obiettivo di mantenere i rapporti tra ebrei e comunisti, si crearono dei gruppi di “ebrei di sinistra” a Roma, Milano e Torino. Gli obiettivi di queste organizzazioni erano diversi, in primo luogo volevano contribuire a diffondere un’informazione corretta nella sinistra sia sugli ebrei che su Israele; secondo obiettivo era quello di favorire sempre il dialogo fra arabi e israeliani; infine, volevano evitare ad ogni costo che gli ebrei della Diaspora si avvicinassero alle posizioni della destra israeliana. La volontà di ogni ebreo di sinistra era quella di evitare uno slittamento a destra dei loro correligionari ma allo stesso tempo si scagliavano con personaggi quali Piero Della Seta e Guido Valabrega che, rimasti nel Pci, assumevano severe posizioni antisraeliane, inaccettabili per molti ebrei. Non mancavano però anche figure come Leo Levi che vedeva questa permanenza nel Pci come una possibilità sia di mantenere aperto il dialogo con i paesi arabi, sia di tenere lontani gli ebrei della Diaspora dai partiti della destra italiana.
Negli anni Settanta, i numerosi eventi che concorsero a “movimentare” la vita della Comunità ebraica italiana e internazionale contribuirono anche ad aprire una nuova fase nel dibattito pubblico in Occidente. Le notizie, che venivano presentate dai Mass-media, sotto la luce a loro più congeniale, altro non fecero se non aumentare i punti di vista sulla questione israeliana. Secondo quanto scrive Matteo Di Figlia, per alcuni, Israele restava il fortino di un mondo anticomunista minacciato dall’avanzata sovietica nei paesi arabi; per altri la questione palestinese permetteva invece di spostare l’interpretazione del conflitto mediorientale dalla cornice della guerra fredda in quella dello scontro fra Nord e Sud del pianeta. L’effetto fu uno stravolgimento degli equilibri dell’ebraismo italiano. All’interno della Comunità si svilupparono due tendenze opposte ma ugualmente problematiche: quella di chi credeva in un ebraismo attivo e dinamico, politicamente impegnato e cosciente della propria ideologia e quella di coloro che invece preferivano un ebraismo più mite per evitare scontri controproducenti.
Nel decennio in questione si assistette in primo luogo a una recrudescenza dell’antisemitismo comunista. All’interno delle comunità ebraiche italiane la polemica principale che stava alla base di tutte le altre che seguirono era dunque una sola: l’antisionismo era antisemitismo? Tale dibattito coinvolgeva tutte le comunità già a partire dal 1967 ma divenne ancora più sentito negli anni Settanta quando gli ebrei in Europa furono oggetto di sanguinosi attentati per mano di gruppi terroristici arabi e palestinesi.
Durante gli anni Settanta Primo Levi si impegnò attivamente per contrastare questa nuova ondata di antisemitismo. Carole Angier scrive, a proposito dell’esperienza dello scrittore:
all’inizio degli anni Settanta, il pericolo maggiore sembrava chiaro, soprattutto a Primo e a quelli della sua generazione: il fascismo con la sua prepotenza, intolleranza e adorazione della forza fine a se stessa, stava tornando. E non accadeva solo a Milano o in altre città, ma sotto i suoi occhi, a Torino. A partire dal 1969, i fascisti erano ricomparsi, deturpando monumenti e tombe della Resistenza, disturbando incontri di sindacalisti, operai e partiti della sinistra, e prendendo d’assalto con incursioni e bombe le loro sedi. Concentravano poi gran parte dei loro sforzi sui giovani. Gruppi di giovani fascisti aspettavano fuori dalle scuole e distribuivano volantini tra gli studenti; chiunque li rifiutasse veniva subito malmenato. Col passare del tempo le aggressioni crebbero di numero e di intensità (…) Qualcosa era già stato fatto in altre città con problemi simili, a Milano e Roma per esempio. Genitori e professori antifascisti si erano riuniti in un’organizzazione chiamata Cogidas, per aiutare i loro figli a difendersi.
La violenza che percorse tutto il decennio in questione arrivò a sfiorare persino un animo mite come quello di Levi. Nell’intervista per Lotta Continua rilasciata a Virgilio Lo Presti, lo scrittore sorprende tutti con un giudizio piuttosto lassista circa i metodi usati nella lotta ai fascismi: “quando si bruciavano le sedi del Msi ero contento…Questo sì, forse non è molto democratico dirlo, però mi sembrava illegale la presenza stessa del Msi…”. Levi più volte durante altre interviste parlò del pericolo di un ritorno al fascismo, non necessariamente identico a quello del passato ma pur sempre un fascismo. Nell’aprile del 1978 inoltre fece sentire la sua voce su «La Stampa» per mettere in guardia contro il pericolo di una nuova violenza di stampo nazista. Sulle pagine del quotidiano torinese denunciò come solo nel 1977 fossero avvenute in Germania ben tre adunate di ex appartenenti ai corpi delle SS; ad allarmare ancora di più lo scrittore fu il fatto che esse non si fossero svolte solo in Germania ma anche in luoghi insanguinati dalle loro gesta come la Francia e l’Italia. Se da una parte, avvertì Levi, il governo tedesco non sembrava essersi accorto dalla pericolosità dei fatti, dall’altra le associazioni antifasciste d’Europa lanciarono da Bruxelles un appello per chiedere lo scioglimento delle associazioni di veterani SS. Levi e gli altri antifascisti non chiedevano sanzioni a carico dei singoli veterani, non era infatti la vendetta che si ricercava, ma una giustizia etica e morale. L’obiettivo era togliere la credibilità e la legittimità della loro voce in modo che il mondo non potesse essere più inquinato dai loro messaggi. Si legge, nell’articolo, anche un certo stupore di Levi per il fatto che in Germania pochi avessero da ridire sulla nascita dell’organo della Hiag, un’organizzazione di Mutuo Soccorso dietro cui si celavano i veterani delle SS. Infatti era da questa organizzazione che pare nascessero iniziative terribili come le profanazioni dei cimiteri ebraici, le minacciose svastiche sui muri e gli attentati alle istituzioni democratiche. Era quindi doveroso, secondo Levi, richiamare il Governo tedesco alle promesse fatte e formulate da tutti i consiglieri, invitando i responsabili as una concreta azione politica e legislativa, in modo da poter scongiurare una rinascita del nazismo proprio in terra tedesca. Come scrive Martina Mengoni, la scrittura di Levi negli anni Settanta risente in pieno degli eventi che lo circondano, compreso quindi anche il rinnovarsi delle ideologie fasciste e naziste in Europa. Levi sente il bisogno forte e persistente di scrivere “come se il fascismo fosse ancora presente”.
E anche per questo motivo la fuga del criminale nazista Herbert Kappler, responsabile delle strage delle Fosse Ardeatine, è stato un evento molto sentito per Primo Levi tanto che intervenne diverse volte sui quotidiani, condannando in particolare il Ministro della Difesa italiano Lattanzio, responsabile primo dell’accaduto e più in generale la Democrazia Cristiana, colpevole di aver portato avanti nel dopoguerra un processo di rimozione del recente passato bellico, convinta che la società preferisse andare oltre e dimenticare. L’obiettivo della DC era riunire i cittadini facendo scordare la grave frattura che si era creata tra chi aveva aderito al regime fascista e chi invece lo aveva combattuto.
La vicenda di Kappler non fu quindi un caso isolato, ma faceva parte di un quadro antropologico italiano più ampio che Levi non vedeva di buon occhio. I segnali che leggeva erano “ambigui e problematici” e venne messo in evidenza quel senso di mancanza di responsabilità che sottolineava già nell’attacco al Ministro Lattanzio e che si manifestava anche in altri segnali come la delegittimazione della scuola italiana, derivata dalle lotte sessantottine, o l’ondata di violenza degli anni di piombo che terminerà con il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro il 9 maggio 1978 per mano delle Brigate Rosse. Levi aveva già condannato duramente le Brigate Rosse nel 1977. In occasione dell’omicidio di un caro amico e collega Carlo Casalegno, firmò con altri esponenti del mondo giornalistico e intellettuale un appello contro il terrorismo. In quell’appello si paragonò l’opposizione alle BR alla Resistenza, suggerendo un binomio terroristi-nazisti supportato dalla Stampa in più occasioni. Non a caso Levi e gli altri appellanti si rivolsero soprattutto agli uomini e alle donne che avevano combattuto il fascismo, come se l’opposizione al terrorismo diventasse una nuova Resistenza.
Se gli anni Settanta furono gli anni dello strappo definitivo su base politica tra sinistra ed ebrei, negli anni Ottanta si assistette a un incremento significativo della violenza nei confronti delle Comunità ebraiche della Diaspora in Europa. L’incubo dei crimini commessi da parte dei nazisti nei confronti delle comunità ebraiche europee parve, ai tempi, ritornare più vivo che mai. La matrice degli attacchi era quasi sempre arabo-palestinese. Gli attentatori, una volta giunti in Europa, si legavano ai gruppi eversivi del luogo senza badare all’indirizzo politico. Il loro obiettivo era uno solo: colpire gli ebrei. Nacque all’interno delle comunità ebraiche italiane un ampio dibattito che, come scrive Maurizio Molinari “modifica radicalmente il volto delle Comunità: ne risulta indebolita la tradizionale unità a favore di una frammentazione ideologica” che rispecchia pienamente il panorama politico italiano di quegli anni.
C’era chi, tra gli ebrei italiani, condannava la piega che stava prendendo in Israele il sionismo e chiedeva a gran voce che il popolo palestinese potesse giungere a un’autodeterminazione nazionale. Tale posizione fu abbracciata dal giornale ebraico di Torino Ha-Keilà che, sposando la tesi di Botteghe Oscure, scrisse della necessità di riconoscere l’OLP di Arafat, sebbene quest’ultimo fosse ancora lontano da un’apertura nei confronti di Israele. Quindi, da un lato Ha-Keilà e la Federazione Giovanile Ebraica d’Italia (FGEI) si univano alla sinistra nella condanna al governo israeliano con a capo il conservatore Menachem Begin, dall’altro il MCSE e le comunità di Roma e Milano si mobilitarono contro l’OLP, criticando apertamente la sinistra italiana che dava sostegno al gruppo di Arafat. Quello che molti ebrei, ma anche numerosi cattolici, non capivano era come fosse possibile che una frangia dell’ebraismo chiedesse di riconoscere la Palestina come uno stato-nazione quando uno dei suoi leader stava dando prova di voler sistematicamente attaccare, con atti sanguinosi e violenti, il mondo ebraico.
Se, per la base comunitaria, questi attacchi altro non erano che un antisemitismo mascherato da antisionismo, c’era anche chi, di fronte all’odio palestinese, rimaneva convinto che l’unica soluzione al problema fosse un avvicinamento all’OLP; solo cercando la pace con il mondo arabo si poteva mettere fine al terrorismo di matrice arabo-palestinese. Sulle pagine di Ha-Keilà non erano rari in quei tempi gli attacchi al Primo Ministro israeliano Begin e alle sue crude repressioni di civili in Cisgiordania.
Il dibattito ora si allargava alla centralità morale di Israele per gli ebrei di tutto il mondo. Gli ebrei della Diaspora, come Elena Ottolenghi Vita Finzi, reclamavano a gran voce il loro diritto di criticare Israele “per far vincere la pace in Medio Oriente”. Tale diritto non era scontato visto che molti esponenti dell’ebraismo italiano avevano in passato affermato che Israele era sì criticabile, ma dal suo interno e che nessun ebreo della Diaspora aveva il diritto di rimproverare Israele per la sua politica.
Nel corso degli anni Ottanta, scrive Ian Thompson, Levi venne profondamente coinvolto nella situazione ebraica molto più che in ogni altro momento dopo la guerra. Quando Israele mise in atto, nel giugno del 1982, l’operazione “Pace in Galilea” ed entrò in Libano con l’obiettivo dichiarato di distruggere le basi palestinesi dell’OLP, Levi non poté più rimanere in silenzio. Il caso volle che lo scrittore apprese la notizia dell’attacco in Libano proprio mentre era in viaggio verso Auschwitz in qualità di accompagnatore per un gruppo di visitatori. Levi rifletté su Israele e sul suo popolo, un popolo che si era unito ed era divenuto nazione a causa dell’eccidio hitleriano che aveva rinsaldato i legami fra i sopravvissuti. “In Israele” scrive Primo Levi “si sono identificati, in maggiore o minor misura, gli ebrei della Diaspora: era il Paese della Bibbia, l’erede di tutti i filoni della cultura ebraico, la terra redentrice, la patria ideale di tutti gli ebrei”. Furono i decenni successivi ad erodere e distorcere l’immagine di un Paese che era sempre meno Terra Santa e sempre più un paese militare. Fu la violenza con cui gli israeliani condusse l’attacco a spaventare tutto il mondo ma soprattutto a creare una profonda lacerazione nel cuore di ogni ebreo. Levi, come molti altri ebrei, vide in Israele una seconda patria per cui però ora provava vergogna. Assistette sconfortato al venir meno della solidarietà dei Paesi europei ma lui stesso prese le distanze da Israele, “un’Israele diversa, militare e spregiudicata”.
Secondo lo scrittore, ciò che non poteva essere perdonato al primo ministro israeliano Begin, oltre alla piega militarista che stava prendendo lo Stato sotto il suo governo, era l’uso del vittimismo e del richiamo costante al nazismo per giustificare l’uso della forza e della sottomissione dei palestinesi. Primo Levi fu quindi tra i promotori del documento firmato da moltissimi democratici italiani, ebrei e non: “Appello affinché Israele si ritiri dal Libano”. All’interno dell’appello si legge come, prima di tutto, si debba garantire a ogni stato “il diritto alla sovranità e alla sicurezza nazionale”. Sono le stesse parole che venivano pubblicate nel 1967 in difesa dello Stato d’Israele. Se allora si doveva difendere lo stato ebraico dalla minaccia degli eserciti arabi e quindi era necessario garantirne la sicurezza, ora tutti coloro che avevano difeso Israele devono “trovare il coraggio e la forza di opporsi al governo Begin e a tutto ciò che rappresenta per i destini democratici dello Stato d’Israele”. Begin era per Levi e gli altri firmatari “quanto di più nefasto per l’assetto democratico della società israeliana” poiché annettere la Cisgiordania, popolata da moltissimi arabi palestinesi, avrebbe minato ogni tentativo di raggiungere la pace tra ebrei e arabi. Palestina e Israele, arabi ed ebrei, dovevano potersi riconoscere reciprocamente: “Il problema palestinese esiste; non lo si può rimuovere. Non lo si può risolvere alla maniera di Arafat, negando ad Israele il diritto di esistere, ma neppure lo si risolve alla maniera di Begin”. Agli occhi di Primo Levi appariva ora un’altra Israele; il sionismo e la fondazione dello Stato di Israele erano una necessità politica ma il sionismo di allora pensava a un paese contadino e non al Paese militare e industriale che era diventato.
A meno di due settimane di distanza dalla pubblicazione dell’appello Primo Levi scelse di far sentire ancora la sua voce a livello nazionale e sempre sulle pagine de «la Repubblica». Si trattava di un’intervista condotta da Alberto Stabile dal titolo “Sì, Israele ha passato il segno ma non è giusto parlare di nazismo”. Allo scrittore venne chiesto se fosse possibile paragonare il dramma palestinese di quel periodo con le persecuzioni subite dagli ebrei quarant’anni prima ed egli affermò che, seppur con le dovute differenze, alcune analogie tra le due situazioni erano sotto gli occhi di tutti. In primo luogo i palestinesi erano una “nazione” che si era trovata senza territorio e poi esisteva una diaspora palestinese che un po’ richiamava alla memoria la Diaspora ebraica di duemila anni prima. Tuttavia una differenza sostanziale intercorreva tra le due diaspore e ciò impedì a Levi di assimilare completamente la situazione dei palestinesi a quella degli ebrei sotto il regime nazista: fortunatamente non esisteva nessun piano di sterminio del popolo palestinese e soprattutto “i guerriglieri dell’OLP non vengono uccisi in quanto palestinesi ma, appunto, in quanto guerriglieri”. La posizione di Levi esprimeva quindi una spaccatura: da un lato ha un atteggiamento critico verso la militarizzazione dello Stato d’Israele voluta da Begin, dall’altra cercava invece delle attenuanti per evitare il diffondersi di un odio indiscriminato contro gli ebrei. Levi non voleva demonizzare Israele e quindi voleva evitare di essere veicolo di idee che potessero portare a tensioni sullo scenario internazionale.
Quello che stavano vivendo molti ebrei della Diaspora, ma anche tutti coloro che risiedevano a quell’epoca in Israele e non appoggiavano Begin, era un sentimento di forte lacerazione. Da una parte vi era l’idea di un Israele nato come simbolo di pace, a memoria che quanto accaduto non accedesse mai più, dall’altra la sua evoluzione opposta, fatta di militarismo e aggressività. Quello che mancava, e che invece bisognava recuperare, era un centro geografico dell’ebraismo mondiale per far si che risorgesse il fenomeno cosmopolita dell’ebraismo. In sostanza, Levi aveva l’impressione che Israele si stesse chiudendo al mondo, perdendo quell’aurea di internazionalismo che da sempre aveva caratterizzato l’ebraismo. La conclusione che ne trasse Levi fu semplice: se Israele non poteva più rappresentare, almeno culturalmente, tutti gli ebrei del mondo, allora il baricentro ebraico doveva essersi spostato altrove. Il luogo designato non era l’Italia, bensì un Paese come gli Stati Uniti, dove viveva e si esprimeva un’“intellighenzia ebraica” numerosa e influente. Sono affermazioni forti quelle espresse da Primo Levi. E tuttavia lo scrittore continuerà, anche nelle interviste successive, a parlare di Israele come di un luogo con cui ha un legame emotivo e sentimentale molto forte. Egli non metterà mai in dubbio la legittimità, che definisce “storica” dello stato ebraico. Ma Israele non rappresentava più per lui la Terra Santa, il Paese della Bibbia e della pace. Quelle terre erano divenute un avamposto di guerra e la pace appariva a Primo Levi sempre più lontana. L’amarezza di Levi è comprensibile se si tiene presente l’immagine che si era fatto di Israele dopo la sua esperienza nei Kibbutz nel 1968. L’ideale “tolstoiano e egualitario” e il “senso comunitario utopico” che pervadeva lo Stato ebraico era scomparso. Essere ebrei è sempre stato difficile, dice a Fiona Diwan in un’intervista pubblicata su «Corriere Medico», ma oggi “essere ebrei significa avere la guerra civile in corpo. Significa accorgersi che ci sono spaccature profonde, mentre si fa luce l’idea che Israele non è più – anzi non lo è stato mai – il baricentro dell’ebraismo”. Sono parole dure e sicuramente sofferte ma Levi crede profondamente che il vero centro dell’ebraismo risieda fuori da Israele, nella Diaspora, e non perderà occasioni per esprimere questo suo pensiero.
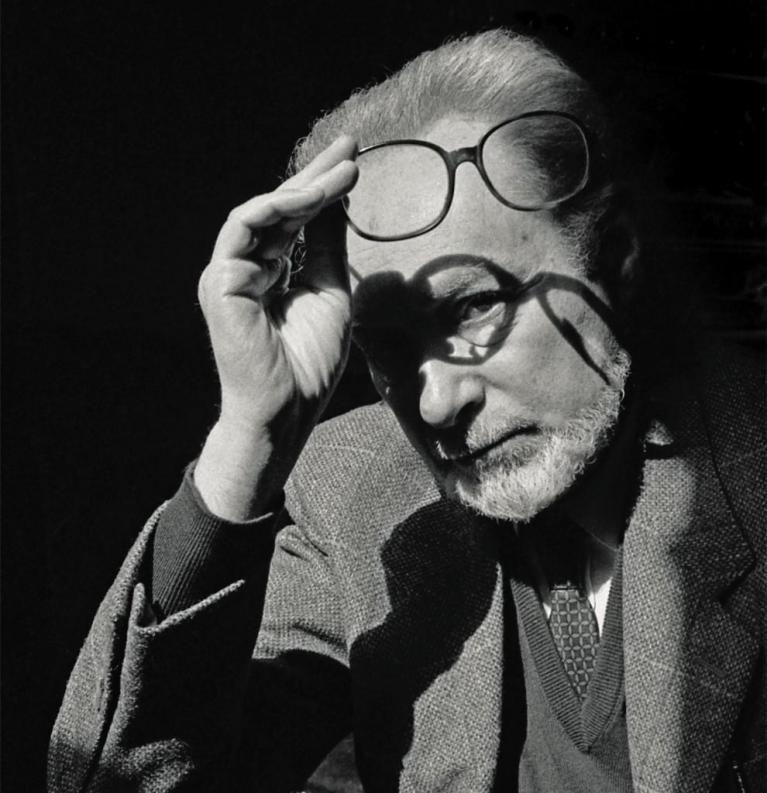 Primo Levi
Primo Levi
Le reazioni degli ebrei conservatori all’appello e alle successive dichiarazioni furono durissime. Chi era Levi per giudicare Israele e le sue azioni? Egli non era, secondo loro, abbastanza edotto in materia di politica israeliana e palestinese per poterne parlare in certi toni. Agli amici che scrivono a Levi da Israele, accusandolo di non vedere il sangue israeliano versato in tutti quegli anni, lo scrittore risponde che il dolore che prova di fronte a qualsiasi versamento di sangue umano è doloroso e straziante ma che tale argomento è stato portato da Begin come una giustificazione per compiere ogni atto di guerra e quindi Levi, a tale argomento, nega validità. Bisognava, secondo lo scrittore, provare dolore per ogni goccia di sangue versato, sia esso israeliano o palestinese, poiché anche nel dolore bisognava essere democratici. Nell’intervista a Stafano Jesurum su «Oggi» l’autore di Se questo è un uomo ripete per l’ennesima volta come sia stato difficile per lui assumere certe posizioni, e come il suo legame sentimentale con Israele, un legame mai rinnegato, gli abbia provocato turbamenti e sofferenze. Levi non è esente da dubbi ma ha una convinzione: “penso che se uno è democratico debba esserlo prima di tutto. (…) Ci possono essere alcune attenuanti ma i principi valgono sempre”. Ecco dunque come Levi riesce a superare l’impasse. Il suo essere ebreo, il suo essere un ex deportato, vengono e verranno sempre dopo il suo profondo senso della democrazia e la sua coerenza nei confronti di ciò in cui crede e che rispetta.
Qui l'editoriale e l'indice del volume.