Svante Pääbo: Neanderthal al Nobel
Un premio Nobel non è mai solo il riconoscimento di un astratto valore scientifico (o estetico, nel caso del Nobel per la letteratura). È anche la messa a fuoco di orientamenti più generali di ricerca: la sanzione dell’apertura di nuovi orizzonti, la presa d’atto di cambiamenti di passo e di paradigmi, la celebrazione di scoperte che si sono dimostrate negli anni eccezionalmente feconde.
Questo vale anche per il Nobel per la medicina assegnato a Svante Pääbo, che non può non avere una pluralità di significati. La motivazione, che chiama in causa «le scoperte riguardanti i genomi degli ominidi estinti e l’evoluzione umana» premia gli straordinari progressi fatti dall’indagine genomica (per molto tempo era stato dato per scontato che non fosse possibile ricostruire il DNA nucleare dei fossili), la riscrittura del passato profondo della nostra specie (gli episodici incroci degli ultimi Sapiens usciti dall’Africa con i Neandertaliani, ma anche l’individuazione del cosiddetto uomo di Denisova, sulla base di una documentazione paleontologica quanto mai esigua), le conseguenti attualissime prospettive riguardanti la lotta alle pandemie (nell’eredità genetica è nascosta la spiegazione delle diverse risposte immunitarie agli agenti patogeni, in particolare a quelli di nuovo conio).
Molte, dunque, le ragioni per cui il biologo dal falotico cognome estone, nato a Stoccolma e direttore di un formidabile gruppo di ricerca al Max-Planck Institut di Lipsia, si è meritato l’onorificenza assegnata dall’Accademia di Svezia; e non è difficile immaginare che molte future scoperte saranno debitrici del suo lavoro. Nella scienza, tout se tient. Ne erano convinti anche i nostri antenati molti secoli fa: l’edificio del sapere umano deve essere coerente, strutturato, compatto. La differenza è che loro erano orgogliosamente convinti di poterlo costruire per via deduttiva, sulla base di pochi arbitrari assunti metafisici pressoché svincolati dall’esperienza: e così hanno edificato sistemi tanto ingegnosi quanto inattendibili, e inutilizzabili sul piano pratico.

La scienza moderna – quella che noi siamo usi chiamare, a buon diritto, scienza – ha seguito un’altra strada, altri metodi e protocolli d’indagine: e procede un passo alla volta, componendo una sorta di immenso puzzle, che bisognerebbe immaginare non a due, ma a tre, quattro, n dimensioni. Quello che sappiamo è molto meno di quello che ignoriamo (o meglio, di quello che sappiamo di ignorare); in compenso, in alcune zone dove le tessere si sono ben incastrate, possiamo ben dire che le nostre conoscenze sono, pur nella loro parzialità e provvisorietà, le più solide che l’umanità sia arrivata finora a concepire. La conferma, qualora se ne sentisse il bisogno, è offerta dall’incredibile potenziamento delle tecnologie umane registrato negli ultimi quattro secoli. Che poi ne possiamo fare un uso catastrofico, è un discorso diverso. Almeno in parte: giacché le distanze, proprio grazie agli studi sull’evoluzione, si sono accorciate.
Agli occhi di un umanista l’aspetto più affascinante delle scoperte di Pääbo rimane l’inattesa parentela con i Neanderthal. Neanderthal, l’Altro per eccellenza, il tradizionale termine negativo di riferimento per la definizione della nostra identità: Neanderthal siamo, un pochino – dall’1 al 4% – anche noi. Fanno eccezione le popolazioni africane, cioè i discendenti dei nostri simili che dall’Africa non sono mai usciti. Ma i dati più rilevanti che ne conseguono sono altri. Primo: nella storia della nostra specie le zone d’ombra sono ancora estesissime.
Per lungo tempo la storiografia e l’archeologia hanno dovuto fare i conti con la carenza di informazioni sull’antichità, cioè sui secoli e i millenni precedenti la frattura che segnò l’inizio di quello che poi venne chiamato Medioevo; oggi dobbiamo prendere atto che per comprendere i comportamenti e le dinamiche sociali è necessario tener presente anche le decine, le centinaia di migliaia di anni della nostra filogenesi, di cui sappiamo pochissimo.
E dalle profondità di quella remota storia, della quale riusciamo a desumere qualche brandello di notizia solo grazie a sofisticatissimi procedimenti scientifici, emergono novità sorprendenti. Il carattere plurale del genere Homo, di cui siamo gli ultimi, ma non siamo stati affatto gli unici rappresentanti; gli incroci fra le diverse specie di ominidi, da cui discendono conseguenze di cui solo ora cominciamo a misurare la portata; i condizionamenti atavici di cui noi siamo ignari portatori, che investono sia la dimensione biologica (genetica), sia quella culturale.
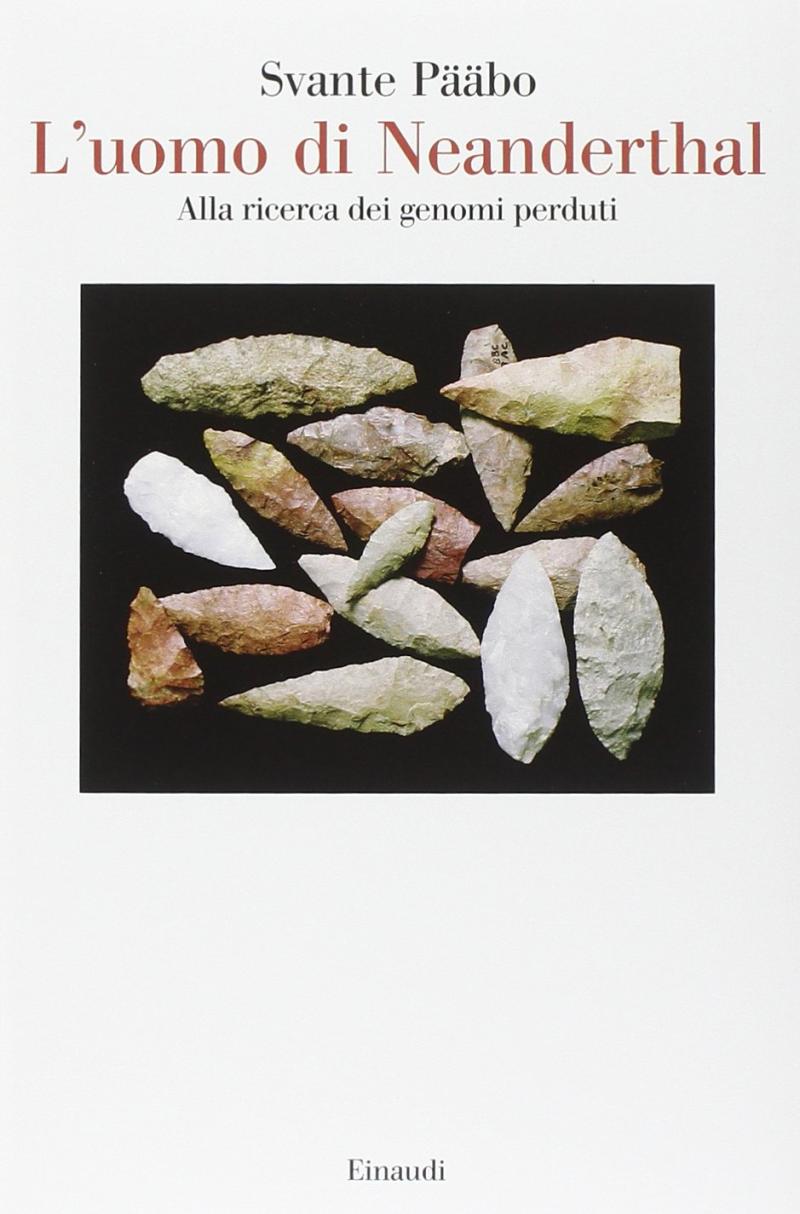
Non sto parlando di cose astratte o marginali. In gioco sono i principî stessi del nostro agire: la nostra maniera di rapportarci con chi ci sta attorno, la nostra carica di aggressività e la nostra disponibilità all’empatia, i modi in cui noi esplichiamo il nostro istinto gregario o il nostro desiderio di autoaffermazione. Il punto è che la sopravvivenza dei nostri progenitori è stata frutto – fra le altre cose – della selezione di tratti e di comportamenti che risultavano utili nel Pleistocene, ma che nel mondo odierno possono produrre conseguenze negative o incontrollabili. Noi non saremmo così esposti a patologie cardiovascolari, se l’evoluzione dei Sapiens non avesse avuto luogo in ambienti dove le risorse alimentari erano scarse, specie quanto a grassi e zuccheri.
Non saremmo così esposti all’ansia, e nemmeno così propensi a prestare attenzione alle notizie più mirabolanti e fantasiose, fino a dar credito alle bufale più cervellotiche, se per migliaia e migliaia di anni, vivendo tra mille insidie, non fosse risultato vantaggioso muoversi con cautela estrema, tenendo conto dei pericoli più improbabili.
Noi, discendenti degli ominidi che scambiavano il ramo per un serpente (e non viceversa), siamo oggi in ansia costante per il futuro, siamo esposti alle nevrosi, consumiamo psicofarmaci: non solo, ma abbiamo a che fare, nei paesi più avanzati, con quote rilevanti della cittadinanza che sono preda di deliri complottistici, incluse le fole di Q-Anon sui rettiliani, mentre solide evidenze scientifiche sono investite dai febbrili sospetti di un’opinione pubblica impaurita e sovreccitata dagli imprevisti.
Poco fa ho tessuto un (banale, probabilmente scontato) elogio della scienza. A questo vorrei aggiungere una considerazione meno ovvia: una parte molto cospicua delle scoperte scientifiche sono contro-intuitive, e quindi a volte difficili da comprendere, e di conseguenza anche difficili da accettare. Lo stesso vale per i riscontri statistici. Quanti nostri concittadini abbiamo sentito prendere posizione, negli anni dell’emergenza pandemica, sulla base della propria personale esperienza?
Se devo prestar fede a ciò che vedo, è il Sole che gira intorno alla Terra, a dispetto di quel che sosteneva quel cialtrone di Copernico (probabilmente ammanicato con i poteri forti e con la gauche caviar). Ci sono tantissime questioni rispetto alle quali l’esperienza personale è un riferimento prezioso, una guida insostituibile, ma ci sono altre questioni per cui vale poco più di zero. E il problema, allora, è imparare a distinguere le une dalla altre, cioè capire quando la nostra esperienza diretta è indispensabile e quando è meglio trascurarla, e affidarsi alle risultanze scientifiche.
Perché noi facciamo il miglior uso possibile del nostro cervello pleistocenico, allora, è più importante che mai il ruolo della divulgazione del sapere. E qui occorre ricordare che Svante Pääbo ha saputo dar conto delle proprie ricerche anche rivolgendosi a una platea più estesa degli specialisti.
L’uomo di Neanderthal. Alla ricerca dei genomi perduti (2014), tempestivamente pubblicata da Einaudi nella traduzione di Daniele A. Gewurz, è un eccellente esempio di come si possa parlare di problemi complessi in modo comprensibile ai profani, e raccontare una ricerca scientifica come un romanzo d’avventura. Del resto, non è davvero un’avventura, l’attività dello scienziato? Primo Levi ce lo ha insegnato nella maniera più persuasiva. Per questo, oltre a leggere i suoi libri, dovremmo prendere esempio dal suo comportamento di lettore.







