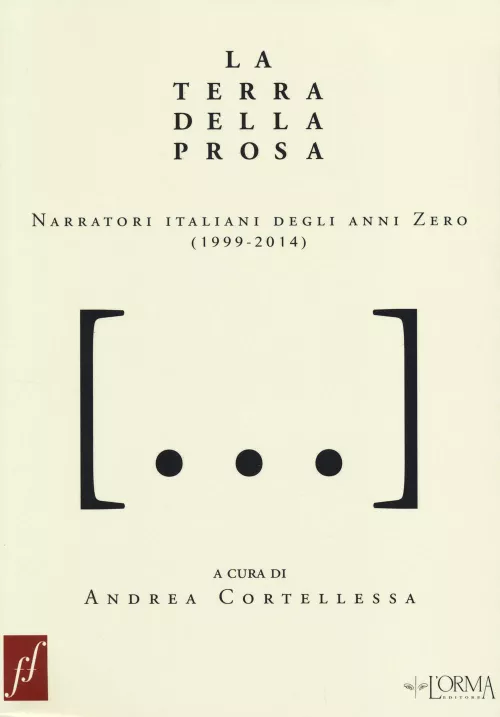Oggi alle 18 alla Fondazione Mudima (Milano) / Una cosa impossibile
Mani avanti: nelle pagine che seguono non tenterò di adeguarmi all’approccio dei due libri sulla letteratura italiana contemporanea che più hanno avuto successo negli ultimi anni, imponendo i rispettivi autori come i maggiori critici militanti di una generazione «che disgraziatamente è anche la mia». Parlo di Senza trauma di Daniele Giglioli (Quodlibet 2011) e della Letteratura circostante di Gianluigi Simonetti (il Mulino 2018). Non sfuggirà il paradosso per cui la “critica militante” che più si porta, oggi, è quella che prova un orrore sacro per quanto la civiltà letteraria d’antan definiva appunto (con termine, in effetti, di sovrana antipatia) militanza: la quale consisteva proprio nei «giudizi di valore» e nel «canone» (ridotto a «classifica» o «tabellina» da Giglioli), e nelle «ricette stilistiche» e nelle «poetiche» dalle quali rifugge con un brivido Simonetti, sino a distogliere il calice dall’idea di difendere una qualche «qualità letteraria genericamente intesa» (attitudine, questa della critica, da lui definita «poliziesca, normativa e paralizzante»).
Esplicito intento dei due (per molti versi stimabilissimi) autori citati è viceversa quello di usare i testi quali sintomi di una condizione post-postmoderna, diciamo pure di una nuova psicologia, nel primo caso; e, nel secondo, di una «società letteraria […] che sta ripensando, e a tratti capovolgendo, le basi umanistiche del proprio sapere». Anche la mole, di questi lavori, è molto distante dallo spazio ridotto che (per fortuna) ho a disposizione in questa sede. Nella quale dunque – con un quanto di provocazione, confesso – non offrirò a chi mi legga altro che giudizi di valore, depositando quindi la mia idea di qualità letteraria in quello che, protervia!, è un vero e proprio canone – seppur limitato alla finestra d’osservazione convenuta dei testi narrativi pubblicati in lingua italiana dal settembre 2017 all’agosto 2018. Dal momento che non sono intesi quali sintomi di alcunché – se non della qualità letteraria dei rispettivi autori –, i testi da ora in poi citati s’intendono segnalati, di qui in avanti, unicamente per loro stessi. (Chi vi sia interessato potrà trovare presupposti meno generici, di quanti possa fornirne qui, nella Terra della prosa, l’antologia che ho curato per L’orma nel 2014 e che comprende testi di autori italiani all’esordio fra il 1999 e il 2013; si può vedere pure il numero 64 di «Allegoria», luglio-dicembre 2011.)
Riprendendo appunto quel discorso, resto convinto che quello che altri chiama il «campo» della narrativa contemporanea si giovi a essere percorso, più che cartografato, seguendo logiche spaziali. Se insomma, come mi capita con una certa imbarazzante frequenza, mi si chiede “dove stia andando” la nostra narrativa più recente, rispondo che questa – con sempre più convinzione – va in direzione del dove. Se «la struttura dello spazio del testo diventa modello della struttura dello spazio dell’universo» – come ha insegnato Jurij M. Lotman nella Struttura del testo poetico (1970, Mursia 1972) –, la narratività di un testo è infatti definita dall’escursione all’interno del modello spaziale rappresentato dal testo stesso, valicando i suoi limiti esterni o le sue partizioni interne (sempre secondo Lotman «il movimento dell’intreccio, cioè l’avvenimento, è il superamento del limite»: laddove, si capisce – essendo quella del testo un’astrazione culturale –, il limite può essere inteso in senso strettamente spaziale ma anche, per esempio, morale o ideologico).
Non sono dunque a tutti gli effetti rubricabili quali testi di “narrativa” due dei libri più seducenti del nostro periodo, le Storie del pavimento di Gherardo Bortolotti (Tic edizioni, aprile 2018) e ollivud di Andrea Inglese (Edizioni Prufrock, luglio 2018): i quali però pongono in forma decisiva – con un grado di consapevolezza, cioè, che per tradizione pertiene più ai poeti che ai narratori – la perimetrazione degli spazi dell’immaginario. Fra le prose di ollivud Inglese riprende fra l’altro un suo testo del 2011, Quando Kubrick inventò la fantascienza, inclassificabile fuoriformato sospeso fra diarismo e saggistica, oltremodo discutibile quanto emozionante “stalking” di un film di culto come il 2001 di Stanley Kubrick, 1968, letto in primo luogo appunto quale «odissea dello spazio» oltre che «nello spazio». Mi piace definire stalking, questa forma di ossessivo corpo a corpo con un testo dato, perché a un altro caposaldo della fantascienza cinematografica, Stalker di Andreij Tarkovskij, del ’79, è dedicato quello che mi pare l’assoluto capolavoro letterario di questo genere (sempre che si possa definire un “genere”), cioè Zona di Geoff Dyer (uscito nel 2012, ma solo ora tradotto da Katia Bagnoli per il Saggiatore; per restare più o meno da queste parti, una pellicola narrativa esile al punto da apparire innecessaria avvolge le considerazioni personali, fra lo gnomico e il saggistico, di due maestri di diversa generazione come l’Aldo Busi delle Consapevolezze ultime – Einaudi, aprile 2018 – e l’Aldo Nove del Professore di Viggiù – Bompiani, aprile 2018).
In Storie del pavimento Bortolotti riscrive (come meno esplicitamente aveva già fatto uno dei più sorprendenti esordi degli ultimi anni, Mio salmone domestico di Emmanuela Carbè, Laterza 2013) un archetipo delle “altre scritture” come il celebre Voyage autour de ma chambre pubblicato da Xavier de Maistre nel 1794: in 42 brevissime lasse (quanti sono i capitoli, e i giorni di arresto nella sua stanza, dell’io narrante – o meglio scrivente – dell’indisciplinato soldato de Maistre) ritroviamo i migliori estri della microepica bortolottesca (quella che ha deliziato, per esempio, i venticinque lettori di uno dei più straordinari e misconosciuti libri italiani degli ultimi anni, Quando arrivarono gli alieni, pubblicato da Benway Series nel 2016), qui applicata all’«infraordinario» di uno spazio-tempo circoscritto sino alla microscopia (il «minutario» che invocava, in luogo del «diario», il “nullista” russo di primo Novecento Daniil Charms), ma parossisticamente dilatato su coordinate continentali e durate geologiche. (Esercizi insieme di commento personale e riscrittura metaletteraria sono anche quelli, dedicati al Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, di Una serie ininterrotta di gesti riusciti, Marsilio agosto 2018: opera prima del giovane e valente studioso di letteratura Alessandro Giammei.)
In un micro-spazio “reale” che, come la chambre di Bortolotti, ospita infiniti spazi virtuali (inscenati dal videogioco in cui s’inabissa uno dei personaggi) è ambientata la parte più ambiziosa (anche se non necessariamente la più risolta) del nuovo romanzo di Tiziano Scarpa, Il cipiglio del gufo (Einaudi, gennaio 2018): che si richiama, sin dalla prosodia del titolo, a uno dei più bei libri di narrativa degli ultimi anni, Il brevetto del geco (ivi 2015), senza però riuscire a ripeterne i formidabili virtuosismi.
Non è un caso che, sin dal titolo, sia dedicata alla micro-storia (o meglio, di nuovo, alla micro-epopea) di un micro-luogo una delle più interessanti “altre scritture” (quelle prose, cioè, che non si possano tout court rubricare nel modo della narrativa, ma che tuttavia fatichino a rientrare in altri “generi”) pubblicate nel nostro periodo: Gli 80 di Camporammaglia (Laterza, marzo 2018), libro d’esordio di Valerio Valentini (l’autore più giovane, nato com’è nel 1991, fra quelli qui passati in rassegna), è la registrazione asciutta quanto appassionata di una narrazione corale: quella delle persone che si ostinano ad abitare nel paese abruzzese del titolo, distrutto dal terremoto del 2009 (se vi appare indubbia un’eredità dalla non meno terremotata «paesologia» di Franco Arminio, purtroppo oggi dedito a tutt’altre forme di scrittura, molto diverso mi pare però lo spirito dell’operazione di Valentini).
Nel Tempo delle ciliegie (Eleuthera, aprile 2018) Marco Rovelli (autore in passato di notevoli reportage narrativi, come Lager italiani e Servi, a loro volta basati sulla registrazione di testimonianze orali) sceglie una testimone storica (la «santa anarchica» Louise Michel, già da Victor Hugo eletta a simbolo della Rivolta) per raccontare l’epos della Comune di Parigi del 1871. Che è anche, al cadere dell’anniversario, una mossa del cavallo per ragionare in modo non scontato (a differenza di infiniti altri) sulle «intensità collettive» di un evento che a quel precedente si richiamò come il Maggio ’68. Meno compatto strutturalmente, a dispetto dell’ardimentosa miscela linguistica italo-siciliana che è fra le sue attrattive, è Lo scemo di guerra e l’eroe di cartone (Spartaco, aprile 2018), curiosa opera prima di Alberto Maria Tricoli: che racconta le biografie immaginarie, ma ricalcate su storie realmente accadute, di un disertore del Regio Esercito e di un miliziano delle camicie nere che si aggirano nei paesaggi della Sicilia 1943 (quelli di Horcynus Orca, per intenderci) dove più forte tira il vento della Storia.
Un vento che infuria a tempesta in quello che è – a mio sindacabilissimo giudizio – il libro italiano dell’anno: Mio padre la rivoluzione di Davide Orecchio (minimum fax, settembre 2017). In una struttura segmentata e multiprospettica, che smonta e “rimonta” le prospettive temporali – e con esse, si capisce, i “set” geografici – (come nella stupefacente opera prima, Città distrutte, Gaffi 2012; il Saggiatore 20182), tormentosamente la pietas dell’historicus di oggi insiste sul “mito” della Rivoluzione. Non per “demistificarlo” – come stucchevolmente non si smette di fare, a rivoluzioni sconfitte e universalmente esecrate –, o non in prima battuta almeno: bensì per ri-modularlo (la metafora musicale è indotta dalla conduzione poematica – epicamente ritmata a tamburo eppure, spesso, delicatissimamente screziata – della scrittura di Orecchio) attraverso il dispositivo del what if. Emblematico l’atteggiamento nei confronti del personaggio più memorabile del libro: è una pia leggenda, un mito appunto, quello del “buon” Trockij: fu invece lui – soffocando nel sangue, nel ’21, la rivolta dei marinai di Kronstadt che proprio alla sua parola d’ordine della rivoluzione permanente s’ispiravano –, a spingere la storia oltre il punto di non ritorno dell’orrore. Orecchio, che su Trockij ha letto tutto, lo sa meglio di ogni altro. E ciò malgrado è alla forza del mito che si, e ci, consegna: immaginandolo sopravvissuto nel ’56 in cui Chruščëv denuncia i crimini di Stalin alla tribuna del PCUS. L’etimo fantastorico di Borges, lievito affabulatorio di Città distrutte, si tinge così d’una vena che pare uscita, piuttosto, da Philip K. Dick.
Narratrice “epica” (almeno da Le rondini di Montecassino, il romanzo che l’ha imposta a un pubblico più ampio nel 2010) è senz’altro Helena Janeczek, autrice del libro più premiato dell’annata (Bagutta, Strega, finale al Campiello), La ragazza con la Leica (Guanda, settembre 2017), la cui struttura compositiva non è così diversa, a ben vedere, da quella di Rovelli: anche in questo caso la personalità di un’insorta impenitente vittima della Storia (della guerra di Spagna, nella fattispecie), la fotografa ebrea tedesca Gerda Taro, viene raccontata da testimoni diversi che ne parlano a diverse “distanze” (in tutti i sensi, tanto temporali che geografici), con una prospettiva “cubista”, neo-modernista, che può ricordare Dos Passos (autore citato nel libro) o quella di un capolavoro cinematografico di quegli anni, Citizen Kane di Orson Welles. Il testo, non meno che appassionante nelle sue parti iniziali e conclusive (nelle quali attraverso una logica iconotestuale si mette a fuoco, è il caso di dire, la specificità dello sguardo di Gerda – evidente avatar della scrittrice ebrea tedesca, del pari déracinée, che ne racconta la storia), si diluisce invece eccessivamente nel suo troppo esteso corpo centrale: forse proprio per la fretta di seguire le “storie”, della protagonista e dei suoi suiveurs, senza radicarsi nei loro rispettivi, problematici luoghi.
Lo stesso difetto, forse, impedisce di salutare con piena convinzione quello che resta in ogni caso uno dei libri più sorprendenti dell’annata, La galassia dei dementi (La Nave di Teseo, marzo 2018) di Ermanno Cavazzoni. I suoi personaggi si muovono, senza tregua e senza direzione, in una Pianura Padana-waste land di proporzioni sterminate, come sterminata è l’ampiezza del testo e (almeno in apparenza) la distanza temporale di questo vero e proprio anti-epos che segue con puntiglio la ricetta del poema eroicomico sei-settecentesco trasportandola, però, in un futuro fantascientifico: quando cioè la razza umana è stata spodestata da androidi-badanti che accudiscono il suo irrimediabile rincoglionimento. Il presupposto sarcastico, per cui l’affidarsi alla tecnologia non può che far decadere l’umanità, è topico (dalla Macchina del tempo di Herbert G. Wells, 1895, a Wall-E della Pixar, 2008); ma vero intento dell’autore – come nei giochi di prospettiva d’ogni parodia, ma già della migliore fantascienza appunto – è quello di farci sorridere, non sulla demenza di un tempo più o meno lontano, bensì sulla nostra.
Fantasmagorie di un dopo-la-fine che più o meno simmetricamente regredisce ad antichità premoderne sono pure lo scarnificato Voragine, opera prima di Andrea Esposito – il Saggiatore, gennaio 2018 –, e i viceversa rutilanti History di Giuseppe Genna – Mondadori, settembre 2017 – e I vivi e i morti di Andrea Gentile – minimum fax aprile 2018. (Stilisticamente agli antipodi, ma del pari sospeso in un presente che in realtà è un elusivo non-tempo, è il raffinato apologo iperletterario che è Gli autunnali di Luca Ricci, La Nave di Teseo, febbraio 2018.)

Esplicita – come in tutte le sue storie, siano o meno ambientate nel futuro come il formidabile esordio di Sirene (Einaudi 2007; Marsilio 20172) – l’epoché del presente nella conduzione allegorica di Laura Pugno. Che nell’ultimo romanzo La metà di bosco (Marsilio, giugno 2018) distende una trama, come suo solito rasciugata sino all’osso, su abissi archetipici: chiamando in causa l’«intimità», e anzi la perturbante consustanziazione, «dei vivi e dei morti», e obbligando i primi alla presa d’atto che la propria metà oscura, arcaica e selvatica, non potrà mai essere del tutto bonificata dalla ragione, psicoanalitica o meno, e così civilizzata, rischiarata, addomesticata (si radicalizza così il discorso del precedente, notevolissimo La ragazza selvaggia, Marsilio 2016). Più esplicito il confronto colle contraddizioni del presente nell’ultima prova di un narratore importante che predilige a sua volta (specie nelle sue ultime prove) l’impianto allegorico, il Claudio Piersanti della Forza di gravità (Feltrinelli, giugno 2018): un contesto sociale, però, ben presto resecato dalla scena della narrazione – circoscritta a un serrato gioco di specchi inter-generazionale tra un esacerbato professore in pensione e una giovane che si affaccia alla vita – dall’allegoricissimo strumento alla cui eloquente costruzione il protagonista attende nel chiuso del proprio appartamento (e che figura sulla copertina del libro): una ghigliottina.
Eppure scommessa decisiva di una narrazione non può che restare quella di raccontare la nostra storia mentre si svolge. Cioè il nostro presente, appunto. Il difficile, si capisce, è farlo eludendo gli stereotipi della doxa sociologistica: quella che aduggia la stragrande maggioranza di narrazioni desolantemente subalterne nei confronti di una cronaca sensazionalistica, schiava dell’immediato come lo è l’agenda di una politica sempre meno capace di pensare davvero il presente, cioè di farlo in prospettiva: dando in tal modo rilievo stereoscopico, per così dire, alla nostra esistenza. Questo invece, precisamente, dovrebbe essere l’ufficio di una narrativa davvero realista: che risulta invece, a dispetto di intenzioni pressoché unanimemente sbandierate, merce rarissima.
Opera – come tutte le sue – assai singolare di uno degli autori più appartati ed enigmatici del nostro tempo, Franco Stelzer, è Cosa diremo agli angeli (Einaudi, maggio 2018). Metafisico, forse gnostico è il “set” di un piccolo aeroporto di provincia, in cui un anonimo addetto ai controlli scruta con animo sospeso, distante e insieme pietoso come quello di un angelo handke-wendersiano appunto, «le vite degli altri»: quelle dei viaggiatori che sfilano davanti ai suoi occhi. Eppure, in questo suo modo idiosincratico, Stelzer misteriosamente coglie un’aria dei tempi: una malinconia tanto sottile quanto pungente, il senso di uno svuotarsi dell’esperienza, di una vita che sfugge dai suoi luoghi più vividi quanto banali – quelli appunto della doxa che ci assedia – per rifugiarsi in una sorta di spazio cavo («non-luogo» da manuale, l’aeroporto: allegoria però, in questo caso, di una ben più radicale epoché).
E appunto uno spazio cavo, lo «sgabuzzino» in cui a un certo punto si rifugia il protagonista-narrante assediato dal mobbing di una mega-azienda disumanizzante, è il luogo-emblema di Ipotesi di una sconfitta di Giorgio Falco (Einaudi, novembre 2017): cioè quello che, insieme o subito dopo quello di Orecchio, è a mio parere il miglior libro italiano dell’anno. Nella parte centrale del testo (con effetto piuttosto simile a quello del maiuscolo Works di Vitaliano Trevisan, libro dell’anno del 2016), assistiamo a una specie di autobiografico dietro-le-quinte di precedenti exploits narrativi dell’autore, come Pausa caffè (Sironi 2004) e quello che resta il suo capolavoro, L’ubicazione del bene (Einaudi 2009). Ma nella parte iniziale (dedicata, con partecipazione assorta quanto commossa, all’esistenza di un padre conducente di autobus extraurbani) e in quella finale – che segue il vissuto di chi scrive sino a coincidere col momento della scrittura stessa –, laddove cioè non ci siano altri suoi testi ad adombrare la sua scrittura con effetti metanarrativi non perfettamente padroneggiati, la pietà oggettiva, di cui Falco ormai tante volte ha saputo dare prova, torna a splendere – tanto severa quanto struggente – su quella che non è la vita individuale di chi scrive (come nel caso, per antonomasia idiosincratico, di Trevisan), rivelandosi bensì come quella che una persona inevitabilmente plurale torna a designare come la nostra vita.
«Sta diventando una cosa impossibile» è la frase-refrain del padre-everyman novecentesco: una frase, «oscura pur nella sua semplicità» in cui, scrive Falco, «si era concretizzato […] il nostro vivere contemporaneo». Ossia il vivere che prosegue, malgrado tutto, in una post-società come quella in cui, appunto, viviamo – o ci illudiamo di farlo. Se “società” è per definizione quanto mette in relazione fra loro gli individui, sarà infatti difficile definire “associata” un’esistenza come quella che conduciamo oggi: «il capitalismo disconnette: presuppone una vita interiore fatta di segmenti eterogenei che convivono o che si succedono a brevissima distanza senza che questo sia un problema; presuppone quella blanda schizofrenia di cui ogni occidentale del XXI secolo fa esperienza ogni giorno, e che rappresenta l’equivalente psichico del consumo in quanto forma di vita e modo di essere al mondo» (Guido Mazzoni, I destini generali, Laterza 2015). Ma, date queste condizioni, quale potrà essere una narrativa – se è questo (è un’equazione che faceva già, all’indomani della sua pubblicazione, il maggior libro italiano sulla narrativa del secolo cui s’intitola, Il romanzo del Novecento di Giacomo Debenedetti) il nome letterario che diamo a quella che un grande maestro del tempo che ci precede, Charles Wright Mills, chiamava immaginazione sociologica (il libro del 1959, che reca questo titolo, è stato ripubblicato da poco dal Saggiatore)?
Se Bortolotti e Falco – i davvero-realisti più forti del nostro tempo – hanno scelto di rappresentare il nostro mondo di segmenti eterogenei in forme letterariamente frammentarie e blandamente schizofreniche, un narratore più giovane che senz’altro li ha letti come Francesco Targhetta (all’esordio con un romanzo straniantemente in versi come Perciò veniamo bene nelle fotografie, ISBN 2012), per dare forma narrativa a questo medesimo mondo ha scelto una strada paradossale per il suo esordio in prosa, Le vite potenziali (Mondadori, marzo 2018): quella del “vero” romanzo, dalla struttura unitaria e basato sulla costruzione di personaggi verosimili le cui vicende, in potenza appunto, potremmo viverle tutti noi. È quella che una volta si chiamava “tipicità”: date determinate condizioni sociali, e in generale storiche, il personaggio incarnava comportamenti che ognuno poteva riconoscere. Ma, venuta meno la società che quel modello aveva espresso (nonché, forse, ogni forma di società riconoscibile), gli individui hanno preso a vivere come particelle sub-atomiche, monadi senza qualità. E allora il movimento incessante su e giù per l’Europa dei personaggi delle Vite potenziali, informatici iper-cablati a tutto e a tutti in un’accelerazione parossistica che teme la stabilità come la morte (l’esistenza che inseguono non è quella che vivono in atto bensì quella in potenza), è dunque un falso movimento – come una falsa comunicazione è quella che allacciano alle «vite degli altri». (In una partitura stilistica differente ha inteso perseguire un simile paradosso narrativo l’Ernesto Aloia della Vita riflessa, Bompiani, gennaio 2018: che cala interrogativi identitari di sempre negli arcani macro- e microeconomici dei social network.)
In un saggio memorabile del 1909 il maggior predecessore di Wright Mills – ossia Georg Simmel, fondatore della sociologia moderna – emblematizzava la presenza umana sulla Terra in due figure-chiave, il Ponte e la Porta: i due dispositivi materiali, le due forme simboliche attraverso le quali l’uomo «di fronte alla natura possiede la capacità di unire e dividere» (il classico saggio di Simmel da ultimo è incluso nell’omonima silloge Ponte e porta, Archetipolibri 2011). Ma quello in cui ci è dato in sorte di vivere, come vediamo con sempre più allucinante brutalità ogni giorno che passa, è il tempo in cui i Muri si rialzano, le Porte si chiudono e i Ponti – per colmo di evidenza didascalica – provvedono addirittura a crollare. Davvero, sta diventando una cosa impossibile.
Forse non è un caso che pochi anni dopo la pubblicazione di Ponte e porta di Simmel il più grande e profetico fra i narratori moderni, Franz Kafka, abbia inserito nella suite narrativa che s’intitola Durante la costruzione della muraglia cinese quel formidabile apologo che è Il ponte. In cui a prendere la parola non è chi lo percorre, per una volta, bensì il ponte stesso:
me ne stavo e aspettavo. Dovevo aspettare. Un ponte, una volta costruito, non può cessare di esser ponte, senza precipitare.
Una volta, era verso sera – la prima? la millesima? non lo so –, i miei pensieri erano sempre confusi e giravano in tondo. Verso sera, d’estate, il torrente scrosciava più buio, udii un passo d’uomo. […] Chi era? […] mi girai per vederlo.
Un ponte che si volta! Non mi ero ancora voltato che già precipitavo e già ero straziato e infilzato sui sassi aguzzi che mi avevano sempre fissato così pacifici dall’acqua impietosa.
Nella delicata e insieme crudele suite di semi-onirici, circoscritti episodi di vita romana in cui Jhumpa Lahiri (narratrice indiana che ha scritto i suoi libri precedenti in inglese) ha racchiuso la sua fascinazione per la nostra terra con l’abbracciarne per la prima volta compiutamente la lingua, e cui ha dato un titolo eloquente come Dove mi trovo (Guanda, agosto 2018), un pezzo emblematico inscena proprio su un ponte l’incontro ricorrente con «un uomo con cui avrei potuto avere una storia, magari una vita»: è in questa stazione allegorica che si capisce come l’Altro sia un fantasma dell’Io – «ombre […] proiettate sul muro lungo il fiume» – ma come pure sia non meno che vitale – per l’esistenza, prima che per il suo riflesso sulla pagina – dare, a questi fantasmi, un corpo.
Se quella che chiamiamo “narrativa” è la forma che assume in letteratura la relazione fra gli individui – l’immaginazione sociologica che «riconduce il disagio personale dei singoli a turbamenti oggettivi della società e trasforma la pubblica indifferenza in interesse per i problemi collettivi» (così suona la frase di Wright Mills che il Saggiatore ha estratto dal testo per il blurb in controcopertina) – è evidente che, nelle condizioni odierne, essa andrà ripensata radicalmente. Ma proprio per questo, in forme che al momento non possiamo prevedere, la sua esigenza si confermerà imprescindibile.
Questo saggio fa parte dell'Almanacco 2019 di alfabeta2, a cura di Nanni Balestrini e Maria Teresa Carbone, edito da DeriveApprodi, che verrà presentato oggi alle 18 alla Fondazione Mudima (Via Tadino 26, Milano); e a Roma, al Cinema Palazzo a San Lorenzo (Piazza dei Sanniti 9), domenica 2 dicembre, alle 16.