Dopo la pandemia del 1918-20 / Faulkner: una calcolata solitudine
Caliamoci nello scenario remoto e campagnolo di un paesino universitario del Mississippi dove il lento e maestoso fluire del fiume si traduce nei gesti pigri della quotidianità. I canti degli afro-americani riecheggiano nell’aria insieme agli spari dei cannoni della Guerra Civile, le cui le polveri ancora avvolgono le catene sepolte nei campi di cotone e di granoturco. Elvis è nato a una manciata di miglia da Oxford, prima di trasferirsi a Memphis nel Tennessee per sbiancare la musica nera nel Sun Studio dove nascerà il Rock ’n’ roll negli anni Cinquanta. In Mississippi, invece, il nero rimane nero e il rosso del partito repubblicano si imporpora con sfumature che tendono al livido. Gli schiavi deportati dall’Africa sin dal Seicento, una volta convertiti al Cristianesimo, cantano il loro dolore nelle piantagioni musicando i versetti dell’Esodo, libro biblico dedicato all’emancipazione dalla schiavitù. Il Gospel insieme allo Spiritual sono i generi musicali che daranno vita alla musica americana, come recita lo slogan dello Stato del Mississippi: Birthplace of America’s music.

Studio e camera da letto di William Faulkner a Rowan Oak, Oxford Mississippi. Sulle pareti la cronologia del romanzo Una favola, 1954
Il Blues, con il significato allusivo di malinconia e condizione di tristezza, è il ritmo che racconta la segregazione degli stati del Sud, e lo fa seguendo costantemente il ritmo del treno, la marcia liberatoria, il biglietto per il North East dove nella seconda metà dell’Ottocento si cominciavano a unire le prime forze dell’emancipazione antischiavista. In quegli anni nasce il Jazz, modulazione sincopata della musica afro-americana che, non seguendo più il ritmo di quei vagoni che per la maggior parte dei neri rimasero un miraggio, anima la sua musica seguendo la pulsazione del cuore, lo swing, il battito che dà voce e forza alla lotta contro l’emarginazione razziale. L’arteria principale di trasmissione della nuova musica è l’Interstate Highway 55 che collega il Golfo del Messico ai Grandi Laghi, ossia New Orleans a Chicago. La I-55 attraversa tutto il Mississippi e passa vicino a Oxford, dove l’umidità appanna le bottiglie di Bourbon semivuote e gonfia il legno delle sedie a dondolo che oscillano sotto coccigi costretti tutto il giorno alla semina, al raccolto, alla mietitura mentre tramonta un sole rovente che spossa perfino gli alligatori e gli armadilli della zona.
Questo preambolo serve a localizzare una solitudine, quella di William Faulkner (1897-1962), lo scrittore premio Nobel che, dopo aver vissuto l’isolamento forzato a causa dell’influenza spagnola, scelse di vivere a Oxford Mississippi perché, dice: «scrivere è un lavoro solitario». Calatosi in una realtà quasi recanatese, sistematosi sul suo «ermo colle», racconta nei romanzi la siepe che vieta la visione precisa e ampia dell’orizzonte. Narra le fronde invadenti dell’ignoranza, le radici del razzismo e dell’esclusione, i rami della povertà spirituale di esseri umani spinti come bestie dalla fame di sopraffazione verso i più fragili e gli sfruttati. Un’epidemia morale, etica, che invade gli Stati del profondo Sud tra Otto e Novecento. Per ripararsi, Faulkner scrive, beve, monta a cavallo e spezza la monotonia spingendola fuori dal perimetro della propria calcolata solitudine.
Writing is a solitary job – that is, no one can help you with it, but there’s nothing lonely about it. I have always been too busy, too immersed in what I was doing, either mad at it or laughing at it to have time to wonder whether I was lonely or not lonely. It’s simply solitary. I think there is a difference between loneliness and solitude.
(Conferenza alla Virginia University, 1957)
Scrivere, ci dice Faulkner, è un’attività solitaria che implicitamente porta a una domanda amletica: «lonely or not lonely»? Questo è il problema: in Italiano la differenza tra loneliness e solitude si rende, la prima, con “sentimento di solitudine”, la seconda con “condizione di solitudine”. Ma oltre alle sfumature che si possono dare, la parola in italiano è una sola, e così viene percepita e scritta. Sarà il contesto a definire di quale tipo di solitudine si tratta, come lonely significa al contempo solo e solitario, lasciando allo stato d’animo l’ultima definizione. Riuscire a sopportare una condizione di isolamento, ritrovarsi calati nella ripetizione sempre uguale degli avvenimenti quotidiani è di certo la sensazione predominante che provava Faulkner, come tutti quelli che hanno vissuto una pandemia. Ma è proprio l’aver fatto esperienza di quarantene che gli permetterà, negli anni successivi, di saper convivere con la propria loneliness. Da giovane, nel 1918, mentre prestava servizio nell’Aereonautica Militare della RAF in Canada, esplose l’influenza spagnola che per diversi mesi gli vietò di tornare in America.
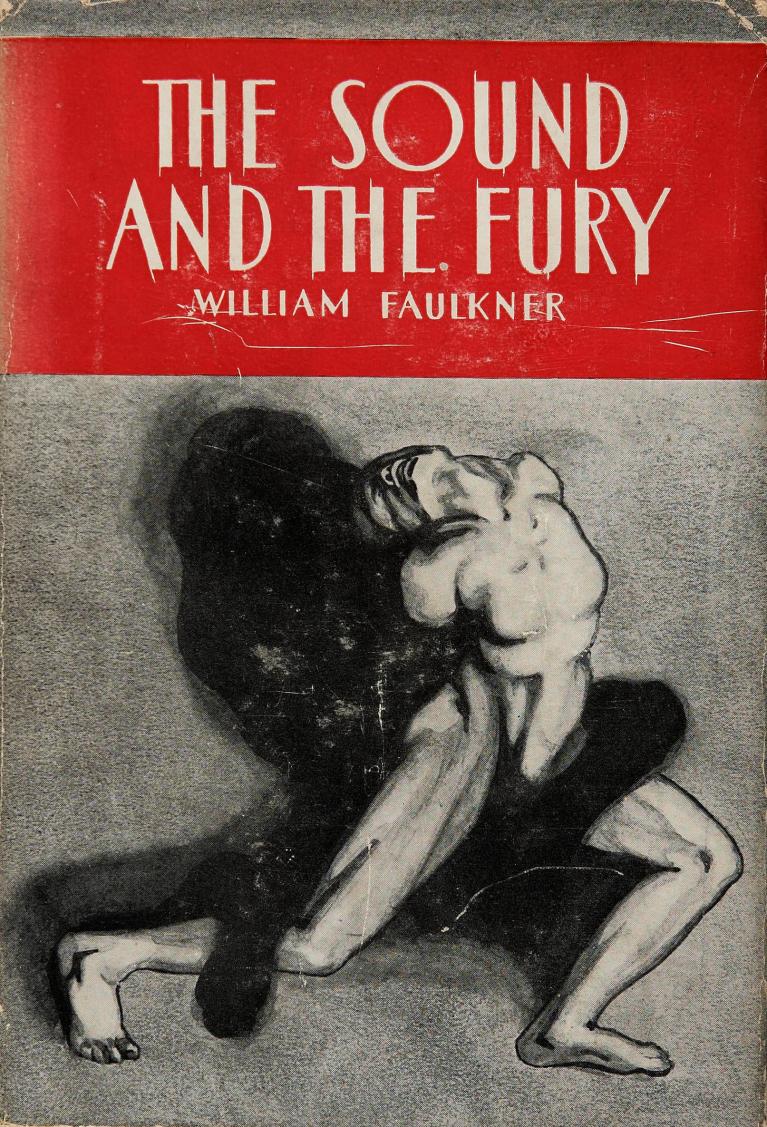
La quarantena non è ancora terminata, anche se si può ottenere un pass per visitare un parente in punto di morte […]. È stata parecchio pesante la morte di Vic. È strano quanto le persone che si pensa debbano vivere per sempre siano proprio le prime ad andarsene.
(Lettera alla famiglia del 21 ottobre 1918)
Victoria Oldham, sorella della futura moglie Estelle, morì a vent’anni mentre portava avanti la sua prima gravidanza. Nel 1918 il virus si stava propagando negli Stati Uniti falciando soprattutto i giovani. L’epidemia, definita “spagnola” perché annunciata dai quotidiani iberici non soggetti alla censura bellica in quanto paese neutrale, nasce in realtà proprio in Nord America con una velocità di diffusione e una percentuale di decessi che ora sappiamo riconoscere. Solo a metà dicembre Faulkner riuscirà a tornare in Mississippi da un Canada gelido, mentre si temeva una terza ondata epidemica che sarebbe poi esplosa nel 1919. Seppur meno mortifera delle precedenti, risvegliò negli animi il terrore dell’isolamento, dei contagi, mentre gli effetti della prima guerra mondiale dovevano ancora essere affrontati. Eppure, nelle opere di William Faulkner, come nella maggior parte degli scrittori americani o europei dell’epoca, la pandemia non compare mentre la guerra e le sue conseguenze sono quasi sempre presenti. Dove va ricercata, allora, la testimonianza e la narrazione di quegli anni pandemici? Dove la paura delle bombe invisibili, del nemico impercettibile che senza un ultimatum, o un fronte, attaccava chiunque?
In un’intervista rilasciata al quotidiano The Daily Princetonian nel 1958, lo scrittore consiglia: «Don’t be “a writer” but instead be writing», non cercare di essere uno scrittore ma vivi nell’atto della narrazione, si potrebbe tradurre, raccogli nella memoria l’esperienza della tua vita come se la dovessi raccontare in scrittura, ovvero rappresenta il tuo essere restituendogli una realtà. In effetti nel visitare Rowan Oak a Oxford Mississippi, la sua grande casa bianca ora museo, si è invitati a pensare che lo scrittore abbia saputo ricreare una condizione dove gli è stato possibile far scaturire l’ispirazione, l’introspezione dello spirito che cercava di ricucire gli accadimenti esterni.
Camminando nel suo giardino, passeggiando nella foresta che separa la casa dalle strade asfaltate, cercando l’ombra delle magnolie secolari da cui si intravede il vecchio maneggio, sembra di entrare nelle sue pagine dove viene descritta la segregazione, la povertà, la guerra, l’ingiustizia e la morte che dominano personaggi onesti o miseri. Siano buoni o cattivi, tutti si ritrovano riuniti sotto un’unica legge di natura, schiavi non del destino ma del caso, dell’opportunità che a ognuno è data e che può svanire in ogni istante, anche a causa di un’influenza letale. In questa sfumatura tra destino, che presuppone una determinazione, e il caso, legato alla fortuna, sembra sia stata essenziale per lo scrittore l’esperienza della pandemia, una tragedia inopponibile, spietata e necessariamente solitaria. Non è stata, infatti, la scrittura di Faulkner a cambiare, ma lo sguardo dei personaggi che portano negli occhi lo stupore inorridito di fronte alla forza del fato, una sorte che non penetra nelle trame narrative come evento, ma ne diviene l’antefatto. Se il conflitto bellico ha lasciato una cicatrice profonda che si cerca attraverso l’arte di rappresentare, di discutere e di superare, l’influenza spagnola ha lasciato una frattura intima tra sé e la realtà.
 Rowan Oak
Rowan Oak
Dopo un’ennesima brutta caduta da cavallo, William Faulkner si dovette trasferire in una stanzetta al piano terra. Fece allora accomodare un lettino, la sua scrivania con la macchina da scrivere, una piccola libreria e uno dei due giganteschi ventilatori metallici che areavano Rowan Oak. Ridotto nel movimento e impossibilitato a uscire, rimase per mesi rinchiuso in quella stanza, un nuovo lockdown fisico che gli ricordava le quarantene canadesi. Invece di deprimersi e di lasciarsi andare, come un carcerato che segna sul muro i giorni che passano, scrive sulle pareti la cronologia settimanale dei suoi nuovi personaggi. Ora che si ritrova a essere lonely in isolamento gioca con la sua solitudine e inizia un nuovo romanzo graffiando il muro con le unghie della sua ben conosciuta loneliness.
Difatti, il romanzo che scriverà in questa condizione, Una favola del 1954, riprende un fatto avvenuto durante la prima guerra mondiale quando i soldati francesi, sfiniti dalla trincea, decidono di ammutinare portando i soldati tedeschi a fermare per un attimo la guerra. Ma Stephan, il caporale sovvertitore, verrà fucilato perché la guerra non può cessare, è nella natura umana continuare a contrastarsi pur se, come suggerisce il romanzo, forse sarebbe sufficiente smettere questa incessante lotta e accogliere in pace i tanti problemi dell’esistenza. Una tregua, un rifugio nel quale sentire di appartenere e con dignità ritagliarsi la propria solitudine.
Appena si entra a Rowan Oak, uno dei primi pannelli riporta che William ha rifiutato per tutta la vita l’aria condizionata. Nella sua casa qui a Oxford ci sono solo due ventilatori e al piano di sopra, nella camera da letto della moglie, un condizionatore fatto montare il giorno dopo la sua morte. Questo aneddoto fa pensare che la vita sia stata per lo scrittore un miscuglio di solitudine e umidità, uno stato d’animo e una fisicità, un lockdown autoimposto per prevenire il contagio da ideali e modi di fare radicalizzati nella terra del Blues, concimata con tristezza e sopraffazione. La pandemia sofferta in giovinezza lo ha aiutato in età più adulta a definire i confini del suo spirito, del suo animo e quindi della sua scrittura.
È appena l’alba, appena giorno: quella grigia, solitaria sospensione piena del tranquillo e incerto svegliarsi degli uccelli. L’aria, all’inspirarla, è come acqua di fonte. Lui respira profondo, lento, e ad ogni respiro si diffonde nel neutro grigiore, diventa tutt’uno con la solitudine e la pace che mai ha conosciuto furore o disperazione. «Non volevo altro che questo» pensa lentamente, calmo, stupito. Quando pensa al tempo, adesso gli sembra di aver vissuto per trent’anni all’interno di un’ordinata parata di giorni noti e numerati come i paletti di uno steccato, e che un giorno si era addormentato e quando si era svegliato, se ne era trovato al di fuori.
(Luce d’agosto, 1932)







