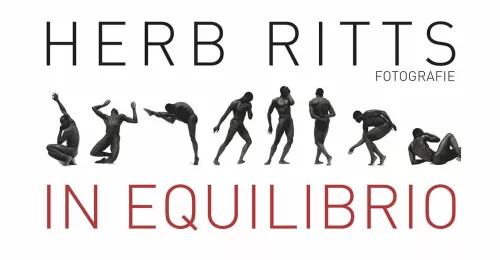20 febbraio - 5 giugno 2016 Ritts a Milano / Herb Ritts. L’equilibrista sul filo del tempo
L’impressione con cui esordisce la visita a questa mostra è che sia sorprendentemente facile capire o, per la verità, percepire la ragione per cui così tanti artisti, nel mondo del cinema, della moda o della musica, abbiano desiderato essere ritratti dall’occhio fotografico di Herb Ritts. I canoni classici sembrano farsi strada nel contemporaneo per coniugarsi con esso, per una copula che dà vita a una visione, anzi, a una veggenza. È facile, allora, innamorarsi di queste fotografie, e innamorarsi dell’idea di esserne il soggetto: esse sono delle spettacolari soste del tempo che, miracolosamente, aprono finestre sul domani, su un futuro dove però non c’è divenire, dove il declino e la catastrofe del corpo sono neutralizzati. Quel futuro è precisamente ciò che fa di Herb Ritts un artista che più di altri ha visto la propria fama superata di gran lunga da quella delle sue fotografie: esse costituiscono stabilmente, da quando sono apparse, l’immaginario del mondo dello spettacolo occidentale degli anni ’80 e ’90, e non possiamo sottovalutare, credendola banale, la riconoscibilità del ritratto di Dizzy Gillespie, o di William S. Burroughs, oppure della coppia di John Travolta o, ancora, della serie dedicata a Jack “The Joker” Nicholson.

Jack Nicholson I, II, III and IV, Londra, 1988.
Perché allora, vien da chiedersi spontaneamente, proprio queste opere hanno prenotato il loro piedistallo nel Museo del Contemporaneo, dormienti nello sguardo di ognuno di noi ma sempre pronte a ripresentarsi al ricordo? Perché Herb Ritts è stato capace di raggiungere questo risultato con una tale, straordinaria, frequenza? Un tentativo di risposta ci porterà nella dimensione vibrante e magmatica del corpo. E converrà partire da un’immagine.
 Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood, 1989.
Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood, 1989.
Le splendide ragazze mi guardano. I loro corpi mi guardano. Ogni dettaglio della composizione, dell’inquadratura e della posa, è curato e attentamente selezionato. Questa celebre fotografia esprime, a una sola occhiata e con una completezza inaccessibile anche a un’infinità di parole, la pletora di sensazioni che il Derrida di L’animale che dunque sono ha cercato di tratteggiare, dissestare e ricomporre: le cinque supermodelle, le loro membra delicate e, tuttavia, così armoniche da imporre il potere della soggezione, i loro occhi, così diversi tra loro e aperti su uno spettro di emozioni controllate e ingestibili, le mani, i piedi, tutto concorre a metterci prepotentemente alla prova dell’essere guardabili e guardati, proprio quando – non è questo il patto cui scendiamo con l’immagine? – eravamo noi quelli chiamati a guardare.
Ecco l’incantesimo di Herb Ritts: esercitare grazia e bellezza, entrare con successo ed efficacia nel territorio del glamour, e trascinarci nel contesto, farci abbandonare il compito di freddo osservatore, farci sentire guardati. La fotografia di Herb Ritts ci riguarda. Del corpo e del suo mistero, essa si fa profeta e insieme disvelamento. Sguardo analitico che scandaglia in profondità eppure porta il suo risultato con la leggerezza cui faceva riferimento Calvino. È un corpo incarnato eppure etereo, presente in terra eppure sospeso altrove, In equilibrio – appunto – tra la terra e il cielo, tra la vergogna e l’attrazione, non è in fondo questa l’essenza dell’erotismo, dello sguardo infine?

Queste immagini hanno assunto lo statuto di topoi dell’immaginario contemporaneo al punto che risuonano al nostro sguardo come una riapparizione, un ritorno costantemente reiterato. Corpi e forme che ci arrivano e ripartono, onde generate dalla riemersione di qualcosa che, tuttavia, in virtù di chissà quale acrobazia alchemica, non era mai esistito prima: la fotografia è qui una vera e propria citazione per anticipazione. Il futuro che si ripete.
Per provare a entrare nella dimensione temporale che cerchiamo di identificare, concentriamoci su una fotografia in particolare che, in effetti, lascia un segno indelebile nel visitatore, un’impronta permanente sulla corteccia morbida della memoria situata da qualche parte dietro il suo occhio: Liz Taylor, “preda” prediletta dell’obiettivo di Herb Ritts, aveva subito un intervento chirurgico al cervello e terminava allora la degenza ospedaliera. Le stesse parole del fotografo vanno dritte al punto:
L’ho fatta posare sul bordo della piscina, le ho steso dietro un telo nero e ho usato la luce naturale. Aveva il suo accappatoio nero. [La foto] le è piaciuta molto, perché è assai diversa dalla solita immagine glamour delle star. Quella foto è fuori dal tempo. Mi piace fotografare combattenti, gente che è stata in trincea ed è sopravvissuta.
Proprio l’ultimo termine ci indirizza ulteriormente – e non per una coincidenza – alla definizione che Aby Warburg diede di Nachleben, sopravvivenza, appunto. Il rivoluzionario storico dell’arte guardava alla grande arte del Rinascimento italiano e individuava dei ritorni di espressioni, modalità, forme o, più propriamente, “formule” (pathosformeln, formule della creazione originaria) che avevano come caratteristica eminente la completa imprevedibilità. Sopravvivenze imprevedibili, allora, perché capaci di ricomparire in contesti diversi, di fare di uno spazio-tempo radicalmente altro il palco del proprio ritorno alle scene.
Georges Didi-Huberman ha dedicato gran parte del suo lavoro a questa felice intuizione dello studioso tedesco e, in particolare, all’importanza di accogliere le immagini nella loro natura anacronistica, rifiutando le didascaliche riduzioni verbali che spesso discendono dall’individuazione di correnti e dalle affiliazioni artistiche attribuite su base biografica.

Herb Ritts, Backflip, Paradise Cove 1987.
Le immagini fanno il mondo in quanto orme disperse da luminosi traccianti, che attraversano il tempo; immaginiamo una matita che non tracci una linea più o meno retta su una facciata di un foglio ma, piuttosto, quando il foglio fosse avvolto a cilindro, lo attraversi da parte a parte, per lasciarci a contemplare, svolta nuovamente la superficie, una sequenza impredicibile di fori, identici e diversi da se stessi. Non è possibile e, forse, nemmeno tanto significativo chiedersi quale sia il “foro originario”: cogliere la sopravvivenza di un’immagine è stare nel flusso di espansione di una nebulosa, proseguire contemporaneamente in ogni direzione e da ogni direzione a ritroso. Ecco perché la foto di Liz Taylor è fuori dal tempo. Essa spezza la dinamica della linea temporale, quella cronologica, e si colloca, nello stesso istante della sua venuta alla luce, nel preciso attimo in cui la vediamo, al posto designato per la visione futura, per ogni suo prossimo avvistamento e per tutte le immagini di Liz Taylor viste da ora in poi, non fa differenza alcuna che siano state generate successivamente o in precedenza a quella. Ennesimo paradosso che dà la misura della potenza dell’immagine, e di queste fotografie, è costituito dall’assenza di qualsivoglia gerarchia, in questo rapporto tra esse: questo scatto esercita la sua influenza su ciascuno degli altri, ma non si esime dalla possibilità e dalla minaccia di subire da essi altrettanta energia.

Queste fotografie, allora, questi corpi, non sono venuti a noi per esserci di conforto bensì, se mai qualcosa, per insinuarci il dubbio: il grazioso e il grottesco, il mascolino e il femminino, la forza e la fragilità, sconfinano l’uno nell’altro (e tutti quanti uno sull’altro), in un trionfo armonico dello sconcerto e, inevitabilmente, del fascino.
Alla mostra curata da Alessandra Mauro va riconosciuto sopra tutti questo merito: l’aver messo in luce, con la selezione e l’allestimento, la cangiante dialettica dell’immagine di Ritts. Un’ultima risonanza mi tocca, pochi istanti prima di lasciare i locali di Palazzo della Ragione Fotografia. Vedo Mask, sintomo potente della dialettica appena citata: un corpo fresco, delicato e attraente; un volto, eccezionalmente, coperto da un drappeggio, ma organico; i connotati del viso che, sul traguardo, riemergono.

E si apre una piccola costellazione di richiami: in una direzione incontro l’autoritratto di Herb Ritts che avvolse il proprio capo nella pellicola fotografica, di nuovo facendo sì che solo gli espedienti della composizione permettano di individuare la posizione di occhi e naso, la pellicola stessa che si svolge come tessuto e scende con posa simile ai capelli della Maschera.
Nell’altro verso, un’immagine che certamente si porta in primo piano tanto per analogia figurativa quanto per essersi mostrata ai miei occhi proprio su queste pareti: un autoritratto, questa volta, di Henri Cartier-Bresson, scattato a Livorno nel 1933, il capo ancora invisibile, il drappo sempre protagonista, maschera improvvisata, velo autoimposto della e dalla soggettività.
Mi dico che, una volta di più, la questione fondamentale dello sguardo è la questione dell’Altro, dello sguardo dell’Altro, del mio sentirmi guardato, visibile, esposto. E mi godo la necessaria utopia, che Herb Ritts regalò al mondo, di stare in equilibrio su questo sottile crinale.
Herb Ritts, In equilibrio (Palazzo della Ragione Fotografia, Milano, 20 febbraio, 5 giugno 2016).