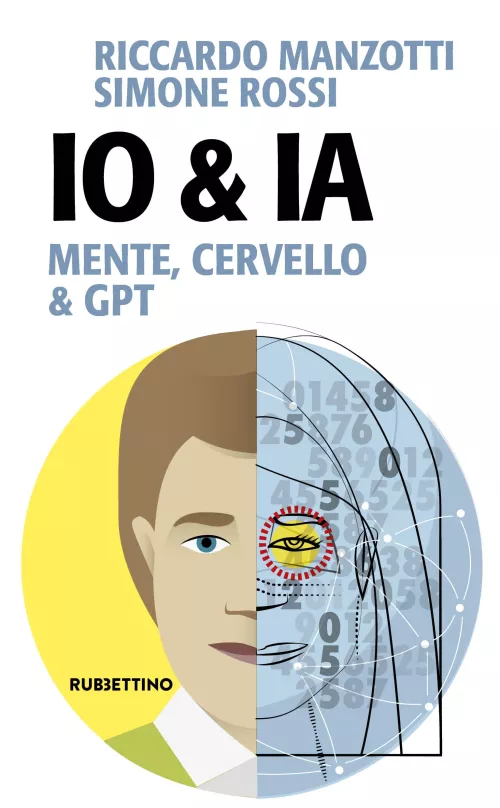Io e IA e la doppia parodia
Di ritorno da Nicea. Nell’articolo L’intelligenza parodica (Doppiozero, 10 giugno 2024) proponevo di risalire alla distinzione teologica tra generazione e creazione formulata al Concilio di Nicea del 325, considerandola un prezioso suggerimento per districarsi nella più risibile querelle sullo statuto «creativo» dell’artista e sulle minacce dell’automazione «generativa» portate dall’Intelligenza Artificiale. E così tiravo le fila dell’audace «paragone niceno»: generazione e creazione, Intelligenza Artificiale (automatica?) e Intelligenza Umana (autoriale?) sembrano disputarsi lo statuto di originalità; la prima perché ritiene che la sua opera partecipi all’origine in quanto generata dalla ri-produzione delle stesse fonti; la seconda perché ritiene piuttosto che la sua opera partecipi all’origine in quanto ne ri-attiva la facoltà creatrice. Chiedendo infine – al dubbioso lettore o alla paziente lettrice – di affrancare la parodia, almeno in queste pagine e per qualche giorno o mese, dai molti lacci etimologici o filologici che le tolgono il respiro, azzardavo l’idea che saremmo di fronte a due sue declinazioni, da cui discendono – per insistere con termini che rimandano al pensiero genetico o genealogico – due concezioni operative (nel senso delle «opere»): una concezione per mimesi parodica generativa, e una concezione per mimesi parodica creativa.
Miracolo in farmacia. Di Laurence Sterne, in quel primo articolo, dichiaravo di adottare, in una sorta di sfida soggettiva ai programmi dell’Intelligenza Artificiale, l’eccentrica destrezza digressiva e analogica shandyana quale procedura narrativa atta a certificare l’origine «creativa» del mio stesso testo contro la possibile accusa di una sua origine «generativa» automatizzata. E ora approfitto di nuovo del capolavoro letterario del clerico anglicano perché, a una successiva rilettura randomica del Tristram Shandy, balzando tra i suoi molti pali e molte frasche, in su e in giù, avanti e indietro, di pagina con orecchietta in altra intonsa, vi ho letto quanto segue: «Ditemi, o dotti, continueremo sempre così, aumentando di tanto la mole, di così poco il valore? Continueremo a fatturare nuovi libri come i farmacisti fatturano le loro misture, solo travasandole da un recipiente all’altro? Dovremo per sempre torcere e storcere la stessa corda? Per sempre sulla stessa pista, sempre allo stesso passo? Saremo destinati sino alla fine dei secoli, feste di precetto e giorni feriali egualmente, a mostrare le reliquie della cultura come i monaci quelle dei loro santi, senza produrre un miracolo, uno solo?»
Insomma, se i «libri» – come io pavento – non possono mai del tutto sottrarsi alla legge di gravità parodistica che li lega a «libri» precedenti, dobbiamo trattarli da farmacisti che li «generano» al pari di misture da travasare di recipiente in recipiente, o possiamo sperare – per parafrasare e correggere a nostra convenienza un antico proverbio – nel miracolo «creativo» che quanto vi è scritto non sempre e non tutto è già stato scritto? Questo il monito che Laurence Sterne ci regala nel Capitolo primo del Volume quinto (1762) di La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo. Nella mia edizione economica e ingiallita, con pagine qua e là scollate, pubblicato negli Oscar Mondadori, Milano 1974, lo troviamo esattamente in fondo alla pagina 243, alla quale, non so quando, ho come d’abitudine inflitto un’orecchietta del tutto simile a quelle apposte anch’esse anni addietro a varie pagine del libro di Edgar Wind che citavo all’inizio delle precedenti note, e in particolare alle pagine dove l’eminente storico dell’arte autore di Arte e anarchia parla di Meccanizzazione dell’arte traendo le confortanti conclusioni che comunque le arti sapranno salvarsi anche dalle tecniche più avanzate, e questo grazie a una «specie di asistematico rinnovamento» che ora trovo assomigli molto al «miracolo in farmacia» di Sterne.
(Qui mi fermo con i rimandi infra e intertestuali, che rischiano di avviluppare questo testo in una parodia colpita da compulsiva mania.)
Stazioni con corrispondenze. Certe idee o teorie hanno il potere di nutrirsi, sfruttando corrispondenze non necessariamente assennate, anche dei casi più banali e neutri dell’esperienza quotidiana. Le mie idee o teorie che riprendono la distinzione nicena tra generazione e creazione ne hanno dato prova finanche in metropolitana. Quanto mi è successo nella Metropolitana Milanese si conquista quindi una digressione, non per l’accaduto in sé, ma per come ne ha fatto un sol boccone l’appetito onnivoro delle mie divagazioni sulla parodia.
Qualche sabato fa – la cui data esatta lascio in sospeso perché irrilevante – sono partito, diretto alla fermata S. Agostino, dalla stazione Loreto, la cui titolazione religiosa si deve a una chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto che vi sorgeva nelle vicinanze e infine demolita nel secondo dopoguerra nel poco sopravvissuto ai bombardamenti degli alleati. Dopo sette fermate della linea MM 2 dalle denominazioni tutte mondane, mi attendevano le stazioni di nuovo «religiose» di S. Ambrogio e infine di S. Agostino, mia destinazione finale per fare compere al famoso mercato settimanale che si tiene nell’omonima piazza e nel contiguo viale intitolato al giurista romano Emilio Papiniano. Grazie ai richiami toponomastici, era inevitabile, in questo periodo di riflessioni sulla parodia generativa e/o creativa, che io richiamassi, anche in un vagone affollato, verso il mio mulino gli influssi in particolare di quell’Ambrogio nato come Karl Marx a Treviri in Germania, che, scontrandosi con l’imperatrice filoariana Giustina, lottò e vinse perché le basiliche milanesi non finissero sotto il controllo degli eretici ariani che il Concilio di Nicea aveva condannato pochi decenni prima...

Dato che agli intellettuali scappa di inseguire le loro grandi questioni anche quando sono presi da piccole faccende, i miei alti pensieri hanno pagato dazio a tre ragazzoni molto abili, più alti di me e delle mie divagazioni ambrosiane. Giunti alla fermata S. Agostino, uno di costoro mi aiuta ad aprire un passaggio nella ressa chiedendomi gentilmente se devo scendere – comportamento inusuale che interpreto come indizio che la civiltà può contagiare persino dei giovani immigrati giunti chissà da quali nazioni in difetto civile. Così, mettendo a riposo il segreto dialogo che avevo imbastito con S. Ambrogio, esco dal vagone per avviarmi verso la scala mobile con un di più di ottimismo. Raggiungo il tornello al mezzanino, dove l’ottimismo non mi permette però di uscire. Delle tre o quattro tessere, tra cui quella dell’abbonamento annuale a treni e pubblici trasporti regionali lombardi, che portavo riunite in una minuscola custodia di plastica trasparente, non v’era più traccia nel taschino della camicia e in nessuna mia tasca o altro anfratto del vestiario estivo, e non ve n’era traccia nemmeno sul pavimento, dove per un istante avevo sperato mi fossero cadute.
Il leggero panico che ci coglie in queste occasioni spariva presto: il bottino dello scippo era in effetti di poco conto. Nessuna carta di credito e tantomeno tessera sanitaria o di identità mi era stata sottratta. Bene bene! Non restava che presentarsi con la mia identità elettronica salvata nel portafoglio a uno sportello apposito per rinnovare la tessera del trasporto pubblico regionale, quella sì necessaria, urgente. Rifaccio lesto le fermate a ritroso, da S. Agostino e S. Ambrogio sino alla laica stazione intitolata al generale Cadorna, dove un giovane impiegato mi rifornisce all’istante, grazie alla velocità operativa di archivi ovviamente supportati dall’Intelligenza Artificiale, di nuova tessera annuale, con l’assicurazione che la precedente, rubata, è già annullata. I civilissimi scippatori, che i miei ricordi non sanno se attribuire di più a origini virate sul Nordafrica o su un Oriente slavo, si sono goduti poche stazioni a mie spese – penso rancoroso. Ma poi li ringrazio, quasi, perché mi hanno derubato non in un luogo qualunque, bensì alla stazione del S. Agostino d’Ippona mentre pensavo al S. Ambrogio di Treviri: una corrispondenza perfetta per alimentare con la linfa fresca dell’esperienza le mie idee o teorie nicene.
Apologia dell’esperienza. La vicenda dello scippo occorsami in metropolitana è stata dunque fastidiosa, eppure fruttuosa. È come se il S. Agostino delle Confessioni e il S. Ambrogio antiariano l’avessero confezionata apposta per aiutarmi a sviluppare, grazie ad aneddoti soggettivi, questi nostri discorsi su autorialità, creatività etc. etc. Nella fattispecie, io risulterei addirittura come doppiamente autore: dapprima autore (in ruolo di attore) nella realtà, e poi autore (in ruolo di scrittore) nella restituzione letteraria. Nel caso mi venissero richiesti, prometto che recupererò documenti atti a certificare che ne sono effettivamente l’autore-attore nella realtà; mentre per le prove che ne sono io anche l’autore-scrittore dovranno per ora bastare queste righe, che confesso e dichiaro essere tutte redatte da mio inchiostro «creativo».
Ma perché va giudicata fruttuosa l’esperienza dello scippo? Se, come nel caso specifico, l’esperienza reale viene convocata quale fonte di un testo narrativo e di varie idee connesse, che cosa comporta ciò rispetto alla regola – suggerita poco sopra – che i nostri «libri», le nostre opere e racconti e testi non possono in ogni modo sottrarsi al «principio di gravità della parodia»? Il succinto resoconto dello scippo assomiglia, o meglio «rioccupa» (verbo che prima o poi dovrò decidermi a spiegare) lo spazio letterario di chissà quanti racconti precedenti, rispetto ai quali si configura come una parodia intertestuale. Ma, introducendo l’esperienza tra le fonti genetiche (non generative!) del testo, ecco che nella parodia intertestuale si incunea un fattore che con la sua novità consente di affrancarsi dalla riedizione, per quanto variata o alterata a bella posta, di testi dettati dalla logica generativa da «farmacisti» che qui attribuiamo shandyanamente all’Intelligenza Artificiale automatizzata. Questa, infatti, non può che utilizzare – per rubare di nuovo le parole a Edgar Wind – una conoscenza «sistematica» già formalizzata, memorizzata, preordinata a monte, mentre la seconda sembra poter aprire, in virtù dell’esperienza, il gioco a valle del «rinnovamento asistematico». Poiché l’esperienza rappresenta per la conoscenza una novità non prefissata, anche laddove essa fosse tutt’altro che gradita, converrà salutarla almeno come un segno di affrancamento dal già saputo, già detto, già scritto.
Viene attribuito a Goethe l’aforisma che «l’esperienza, per gli individui giunge sempre troppo tardi, per i governi e i popoli non è mai presente» (ne ritrovo traccia nel saggio, di cui consiglio la lettura, «Spazio d’esperienza» e «orizzonte di aspettativa»: due categorie storiche, contenuto in Reinhart Koselleck, Futuro passato, Marietti, Casale Monferrato 1986, dove avevo sottolineato il passaggio). Propongo che a questa visione alquanto scoraggiante, con cui Goethe proclamava finita la possibilità di trarre lezione dall’esperienza storica, se ne aggiunga a margine un aspetto nondimeno positivo, perché, se l’esperienza fosse sempre maestra riconosciuta e puntuale di cui facciamo tesoro, rischieremmo di cadere dalla padella di un mondo dalla storia incorreggibile nella brace di un mondo senza storie – dove non è detto che si stia meglio.
Io e Ia e la doppia parodia. Io & Ia è il titolo di un libro scritto dal filosofo e ingegnere Riccardo Manzotti e dal neurologo Simone Rossi (Io & Ia. Mente, cervello & GPT, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023). È pregevole la combinazione di competenza e leggerezza con cui gli autori (che non mi sembrano automi) ci accompagnano nel contorto labirinto di similitudini e differenze che intercorrerebbero tra l’Io (come soggetto e coscienza umani) e l’IA (la ben nota Intelligenza Artificiale, che a quanto si dice non ha bisogno di alcun soggetto o coscienza, buona o cattiva che sia). Io e IA, un pronome e un acronimo: in questa nostra epoca dove il cognitivismo, dapprima filosofico-linguistico e poi tecnico-scientifico e infine neuro-epistemologico, pare annichilire ogni autorialità del soggetto e autorità della coscienza, lo scherzo lessicale che la lingua italiana ci offre è molto utile a tracciare possibili linee di demarcazione tra le due intelligenze, umana e tecnologica, che altrove ho riassunto anche come Intelligenza Artistica e/o Artificiale (dove il comune prefisso Arti-, per altro curioso scherzo semantico, finisce col fare da servitore di due padroni). Gli autori di Io & Ia scrivono – con mio sollievo – che «è facile supporre che l’essere umano abbia qualcosa di speciale, la scintilla, lo spirito vitale, la coscienza», ossia – per dirla di nuovo in parole shandyane – che «l’UOMO è dotato di poteri che lo lanciano dalla terra al cielo in un attimo». E per rafforzare quella che – quantomeno nelle mie impressioni – si presenta nonostante tutto come una legittima difesa del primato «umanistico» nelle forme di conoscenza, i due autori ci ricordano che filosofi cognitivisti e neuroscienziati concorderebbero che «due sono le forme dell’intelligenza umana: l’intelligenza cristallizzata, che consente la risoluzione di problemi basandosi essenzialmente sulle conoscenze pregresse e, come tali, acquisite, consolidate e memorizzate, e quella cosiddetta fluida, che corrisponde alla capacità, particolarmente sviluppata in alcuni individui, di arrivare alle stesse soluzioni dei problemi in modo più intuitivo, creativo» (corsivo nostro).
Per farla semplice: è come se l’intelligenza umana operasse già da sé tanto come IA quanto come Io. Mi permetto di convocare questa visione di una doppia forma di intelligenza (e conoscenza) umana a sostegno testimoniale, vista la chiara similitudine, dell’idea «nicena» di una doppia forma dell’Intelligenza Parodica: generativa e creativa. E ne approfitto per convocare a ulteriore sostegno, per altra chiara similitudine, un testimone d’eccezione: Denis Diderot, riaffiorato dalla mia memoria approssimativa grazie alla lettura di Io & Ia. Diderot, verso metà 1700, quasi tre secoli orsono, dal cielo di un genio che talvolta appare proiettato oltre le misure di qualsiasi intelligenza a noi nota, in una delle sue Lettere indirizzate a sordi e muti e ciechi che ora non posso ritrovare nella mia disordinata biblioteca domestica poiché sto trascorrendo qualche giorno di vacanza nell’amata Val Bregaglia, scriveva all’incirca che l’esprit de méthode suppone di aver trovato tutto, mentre l’esprit d’invention procede sregolato. Forse il mio è un abbaglio «umanistico», che si prende licenze creative causa mancanza in montagna di biblioteche-farmacie dalle facoltà generative, e causa mio rifiuto per principio di usare qualsivoglia memoria digitale. Ma, se non è un abbaglio, non sembra anche al paziente lettore o alla dubbiosa lettrice arrivati sin qui che méthode e invention denuncino una certa qual aria di famiglia con le categorie neuro-epistemologiche di intelligenza cristallizzata e intelligenza fluida, con l’IA e l’Io?
Che io chiami a testimoniare Diderot per le sue lungimiranti argomentazioni che sembrano annunciare quelle di filosofi cognitivisti e neuroscienziati odierni, non sorprenderà il lettore colto. Costui sa che, negli stessi anni in cui lo scrittore più menzionato e parodiato in queste pagine, Laurence Sterne, avviava la stesura del Tristram Shandy, l’ammirato enciclopedista e letterato parigino amava similmente – cito anche qui con licenza creativa – «cogliere sul fatto la propria mente», così inaugurando a modo suo con saggi e romanzi, in parallelo al collega britannico, quella che in seguito verrà definita «letteratura del flusso di coscienza» e che magari oggi potremmo rinominare «letteratura cognitiva». Lo stesso lettore, più colto di me, sa inoltre quanto Diderot e altri Illuministi abbiano disputato accesamente intorno all’«uomo-automa» o «uomo-macchina», una figura che, agli esordi storici dell’automazione tecnologica, non serviva tanto ai philosophes per interrogarsi sull’applicazione di questa al mondo del lavoro che si andava industrializzando, quanto per interrogarsi già allora sulle forme di conoscenza sistematica o automatica (méthode) e fluida o autoriale (invention) che oggi riemergono nel dibattito sull’l’Intelligenza Artificiale.
È per tutto questo che io vedo correre una certa qual «aria di famiglia» tra il Diderot settecentesco e i filosofi cognitivisti odierni. E chissà che non ripartano proprio da qui altre mie eventuali, prossime note sull’Intelligenza Parodica – IP.
Leggi anche:
Bruno Pedretti | L'intelligenza parodica