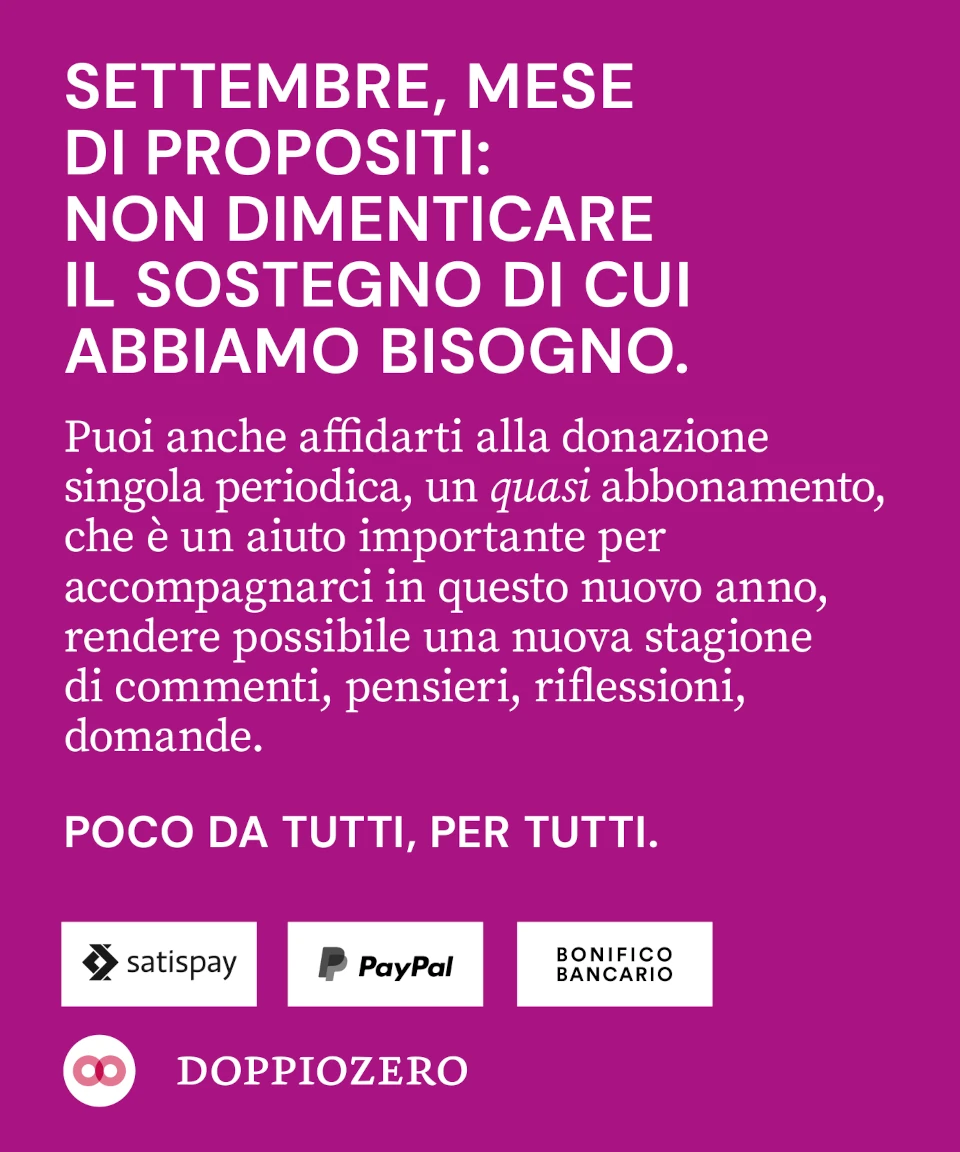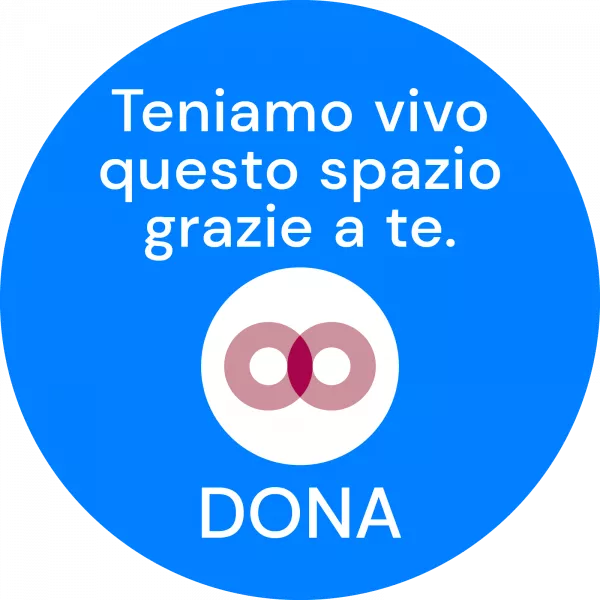Noam Chomsky o del pensiero critico
È celebre, anche se un po’ cinica, la frase di Max Planck secondo cui il progresso avanzerebbe un funerale alla volta. L’avanzamento sarà proporzionale all’importanza e al ruolo che un autore ha avuto in vita. In questo caso, ed è un complimento, la scomparsa di Noam Chomsky rappresenta un punto importante di svolta di molte cornici concettuali che hanno caratterizzato, ma anche ristretto, il panorama della ricerca e del pensiero del Novecento. La sua eredità migliore riguarda di più il suo stile che non sue teorie, per quanto famose. In particolare, Chomsky è un esempio di intellettuale che si è speso per difendere pubblicamente le sue tesi, per quanto spesso arrischiate. Come disse lui stesso, «Se non credi nella libertà di espressione per chi non la pensa come te, allora non ci credi affatto».
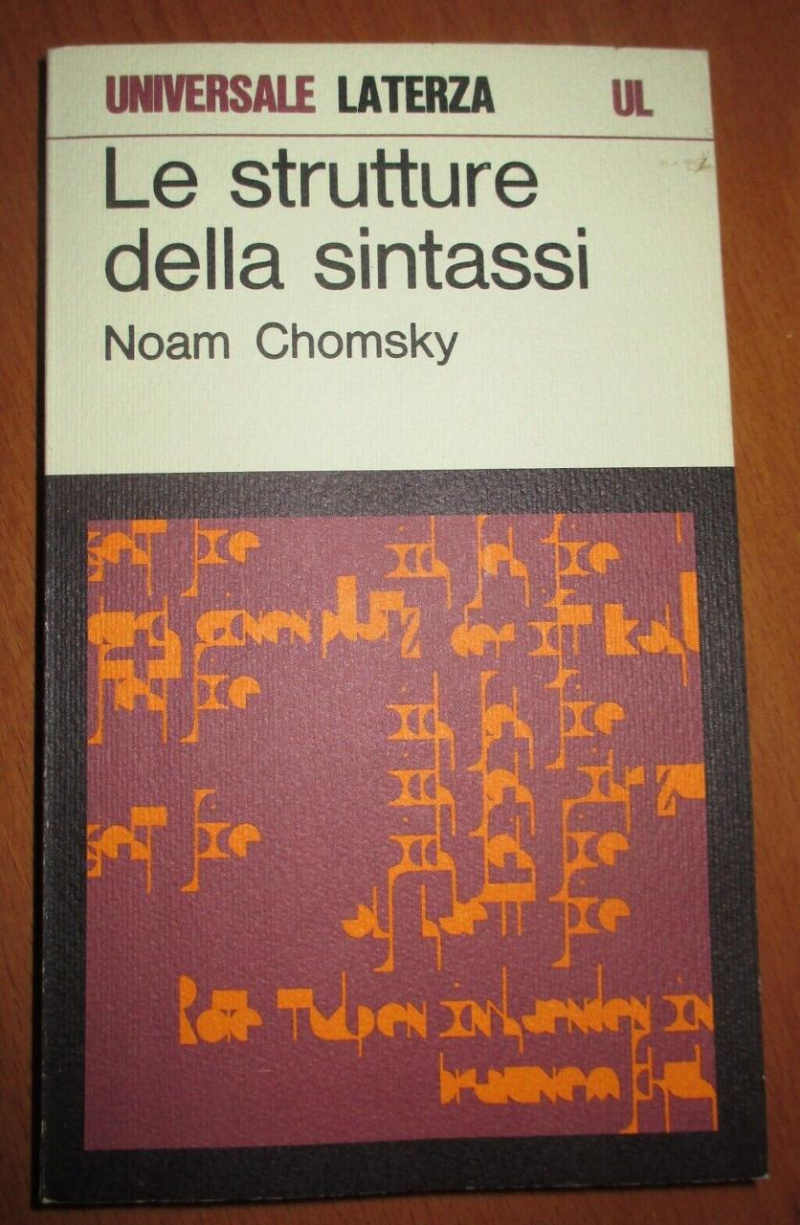
Il mio ricordo personale di Noam Chomsky risale al Settembre 2014 quando fummo, per caso, vicini di ufficio al nono piano dello Stata Center del MIT, spesso chiamato semplicemente Building 32; un edificio dalle forme bizzarre opera del celebre architetto Frank Gehry. Piccolo dettaglio, gli ultimi due piani di quell’edificio erano interamente dedicati al Department of Linguistic and Philosophy e cioè, implicitamente, a lui. Tenete conto che il suo ufficio era una specie di suite privata dotata di vari ambienti, il mio era una scrivania in comune con altri ricercatori … La cosa che mi colpì di più di questo amichevole anziano era la sua determinazione. Nonostante all’epoca avesse già 86 anni, alle 10 di ogni mattina, arrivava nel suo ufficio per uscirne solo in tarda serata una dedizione straordinaria che mi colpì profondamente. Durante i lunghi mesi dell’inverno bostoniano mi accolse diverse volte per condividere il pessimo tè della caffetteria del pian terreno e scambiare qualche opinione. Confesso che, per quanto riguarda il nostro comune tema di ricerca, ovvero la mente, nessuno dei due aveva alcun interesse a capire l’altro, ma non per questo non ammirai il suo carattere e la sua tempra intellettuale.
Noam Avram Chomsky era nato il 7 dicembre 1928 a Philadelphia da una famiglia di immigrati ebrei e aveva manifestato subito un interesse precoce per la politica e la filosofia. Studiò all’Università della Pennsylvania, dove conseguì il dottorato in linguistica per spostarsi poi al MIT di Boston, dove ottenne la cattedra di linguistica poco più di trentenne e rimase per tutta la vita. La sua vita universitaria è ovviamente impossibile da riassumere in qualsiasi articolo. Soltanto l’elenco dei suoi libri è di oltre cento titoli. La sua carriera ebbe un salto di qualità negli anni Cinquanta quando iniziò una rivoluzione nel campo della linguistica grazie a un’intuizione avuta quattro anni prima. Era ancora un giovane studente di linguistica in viaggio per l’Europa nel momento in cui, su una nave sgangherata nel mezzo di un burrascoso Atlantico e in preda al mal di mare, concepì la tesi eretica della grammatica generativa innata e universale: l’essere umano nascerebbe con una macchina linguistica che deve solo essere messa a punto. Se per anni in Europa il linguaggio era stato visto come una forma innata del pensiero, non lontano dalla logica e dalla matematica, in America il comportamentismo aveva cercato di ridurlo a meccanismo biologico che articola un comportamento per tentativi ed errori. In questo contesto, Chomsky spariglia le carte e propone che la grammatica universale esista, ma non come categoria a priori, bensì come motore biologico innato; un’ipotesi straordinaria che però non ha mai avuto effettiva conferma. L’ipotesi fa di Chomsky, per sua stessa ammissione, l’ultimo dei razionalisti e della sua grammatica universale la versione contemporaneo-cognitivo-linguistica dell’innatismo dei razionalisti del Sei-Settecento (un suo libro famoso del 1966, si intitola, non a caso, Linguistica cartesiana).
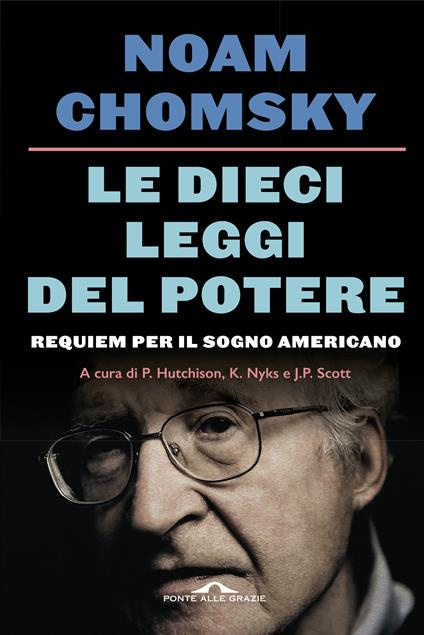
Le teorie di Chomsky acquistano grande notorietà anche perché rafforzano una visione della mente meno legata alla biologia e più astratta, due caratteristiche che trovano consenso nelle nascenti scienze cognitive e nei modelli computazionali della mente (l’inizio dell’Intelligenza Artificiale). Nell’anno fatidico 1957, è significativa l’uscita e lo scontro di due celebri volumi: da un parte Verbal Behavior di Skinner (uno dei massimi fondatori del comportamentismo) e dall’altra Syntactic structures di Chomsky. Non sono solo due testi di filosofia, ma due orizzonti diversi. Per Skinner la mente è tutt’uno con il comportamento e quindi qualcosa di fisico che si esprime nelle azioni, per Chomsky è l’articolarsi di strutture razionali che si incarnano nelle forme innate del linguaggio. Per il linguista Chomsky, il pensiero è grammatica, cioè forma, per lo psicologo Skinner, è comportamento/organismo, cioè materia. In larga misura, per motivi non completamente scientifico-concettuali, Chomsky esce culturalmente vincitore da quello scontro e diventa uno dei pilastri della rivoluzione cognitiva che, anche grazie al contemporaneo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale di prima generazione, del computazionalismo, della cibernetica, troverà terreno fertile nei campus americani.
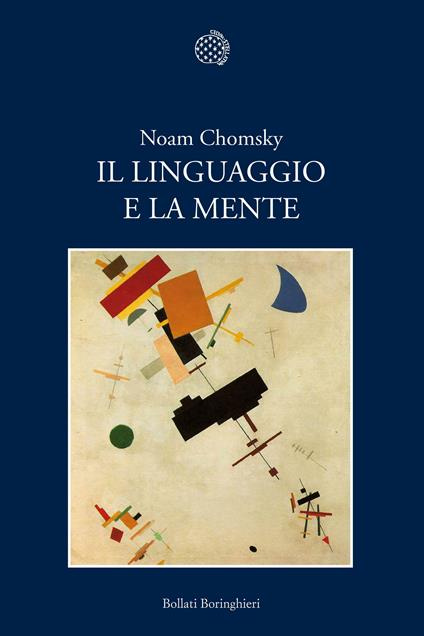
Come mi disse anni fa, a margine di un convegno, il premio Nobel Gerard Edelmann «se vuoi avere successo nella scienza, devi proporre una teoria che dia molto lavoro ai ricercatori». Da questo punto di vista, l’ipotesi di Chomsky è stata di enorme successo perché una quantità impressionante di ricerche sono state spese alla ricerca del motore innato del linguaggio. Da un punto di vista scientifico è invece lecito nutrire qualche dubbio. L’enorme programma di ricerca che produsse anche tanti risultati apprezzabili, possiamo dirlo a distanza di oltre mezzo secolo dal suo inizio, è stato probabilmente sovrastimato nella sua importanza; non solo per le critiche numerose giunte da chi, come per esempio Michael Tomasello, rivendica la natura sociale del linguaggio e il suo prodursi a partire dalla cooperazione sociale e dalla cognizione condivisa, ma proprio dal versante dei modelli computazionali che, negli ultimi anni, hanno dimostrato come il linguaggio possa essere generato senza grammatica. La comparsa dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni (o LLM, Large Language Model), ChatGPT è l’esempio noto a tutti, ha sconfessato di fatto l’ipotesi della grammatica universale. I punti cruciali della teoria di Chomsky sono la povertà dello stimolo (quanto piaceva a un razionalista?) e l’esistenza di un motore linguistico innato che richiedesse soltanto piccoli aggiustamenti per generare le lingue storiche. Gli LLM e le IA generative dimostrano il contrario: il loro motore statistico non ha niente di linguistico e non contiene alcuna grammatica universale, ma soltanto un sistema per estrarre miliardi di probabilità condizionali dal loro input. Eppure le LLM sono in grado di utilizzare il linguaggio umano senza alcuna grammatica universale. Non a caso, in questi ultimi anni, Chomsky non è stato tenero con le IA, da lui definite «pappagalli stocastici». Certo, Noam, un pappagallino sarà anche stupido, ma uno stormo di 1.5 milioni di miliardi di pappagalli è qualcosa di diverso!
Tuttavia Chomsky non è solo linguistica e teoria della mente, ma anche attività politica. Come diceva Heidegger, la filososofia è sintesi di polemos e logos e Chomsky incarnò, più di ogni altro, questa vocazione del pensiero critico sapendo, come pochissimi altri accademici, dare voce a posizioni politiche spesso scomode nel mondo americano. Chomsky si considerava un socialista anarchico e libertario ispirato (anche personalmente) dalla figura di Bertrand Russell di cui teneva, affettuosamente, una grande foto nel suo ufficio.

Celebre è il suo libro del 1969, I nuovi mandarini: i tecnocrati e la politica del potere in America nel quale Chomsky espresse una critica feroce alla politica estera degli Stati Uniti, specialmente riguardo alla guerra del Vietnam. Il libro contribuì a consolidare il movimento contro la guerra, fornendo argomenti e analisi che mettevano in discussione la legittimità e la moralità delle azioni militari americane, ma soprattutto ha criticato aspramente il ruolo degli intellettuali e dei tecnocrati nel supportare e giustificare le politiche imperialiste. Per Chomsky, l’intellettuale deve mettere in discussione l’esistente e c’è sempre una tensione tra l’egemonia di una cultura e il ruolo dell’intellettuale. Per lui, «il modo furbo di tenere buone le persone è limitare lo spazio delle opinioni accettabili, e lasciare che la discussione sia molto vivace all’interno di questo spazio». Se vi viene in mente l’attuale clima culturale, vi accorgerete dell’attualità di questo pensiero.
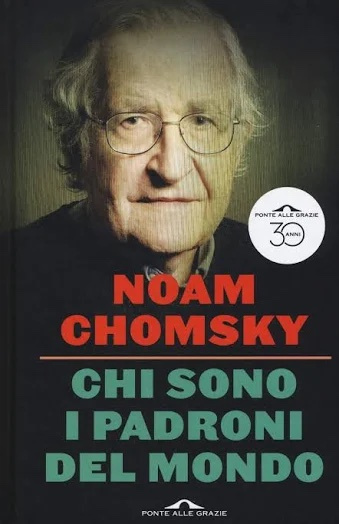
Mentre altri filosofi celebri – penso a W.O. Quine, Donald Davidson, Saul Kripke – non uscivano dal loro ambito specialistico Chomsky non ha mai smesso di essere una voce che esprimeva un punto di vista critico e che giudicava negativamente la dottrina neoliberista che caratterizza il clima politico americano. Ripetutamente denunciò l’influenza delle multinazionali e i mostri sacri delle istituzioni finanziarie globali, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Il suo modo di muoversi nella realtà era basato su una robusta fiducia nella capacità della ragione di leggere tra i fenomeni. Come ebbe a dire «L’ottimismo è una strategia per costruirsi un futuro migliore; se non credete che le cose possano andare meglio, non vi darete mai da fare per migliorarle».
Chomsky è sempre stato una rondine che vola in direzione contraria, senza incertezza nell’attaccare sia gli altri intellettuali americani che quelli europei. Non era uno che mandava a dire le cose e, pur avendo fatto giganteschi errori di valutazione (la sua difesa del regime sanguinario di Pol Pot rimane come una macchia indelebile sul suo percorso di attivista politico), sono celebri i suoi attacchi ad altri autori di primo livello. Addirittura, in un suo recente lavoro sull’evoluzione, Daniel Dennet dedicò un capitolo a «Chomsky contro Darwin». E così possiamo ricordare alcuni dei giudizi più netti che Chomsky non ebbe mai paura di esprimere: Jacques Lacan è un «ciarlatano che si atteggiava a favore delle telecamere nel modo tipico di molti intellettuali parigini», il lavoro di Jacques Derrida è «studio spaventoso, fondato su penosi fraintendimenti», Slavoj Žižek è un «esibizionista che usa termini fantasiosi che pretende di avere una teoria quando non ne ha alcuna», i presidenti americani sono «criminali di guerra».
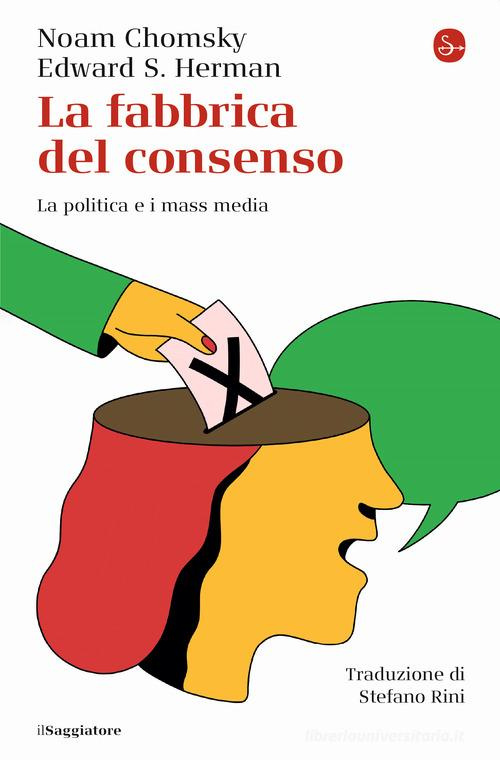
Chomsky è stato, lo devono riconoscere anche coloro che dissentivano dalle sue numerosi tesi, un gigante, nel bene e nel male. Come scrisse qualche anno fa The Guardian «Insieme a Marx, Shakespeare e la Bibbia, Chomsky è tra le dieci fonti più citate nella storia della cultura». Si può dissentire dalle sue idee, ma non si può non rimanere ammirati davanti a chi ha saputo dare voce alla riflessione e chiedersi, come mai, gran parte della filosofia odierna – sia analitica-anglosassone che continentale-europea – non sappia uscire da problemi scolastici che, per gli esseri umani, non hanno alcun valore. Noam Chomsky è stato una figura centrale del pensiero contemporaneo, un intellettuale che ha sfidato le convenzioni accademiche e politiche con coraggio e rigore. Purtroppo in molti casi il giudizio del gigante di Lubiana, Slavoj Žižek, non è stato lontano dalla realtà: «Non conosco un tizio che sia stato empiricamente in errore tanto spesso».
Tuttavia, in quest’epoca di intellettuali preoccupati di essere esclusi da finanziamenti e timorosi di mettere in gioco la propria reputazione, la volontà di difendere posizioni estreme non è da sottovalutare. Essere empiricamente in errore è una virtù rara oggi, soprattutto per un filosofo, e quindi un titolo di merito. L’iperspecialismo della produzione accademica è uno dei sintomi che segnalano i meccanismi che soffocano sul nascere ogni contestazione. Invece di dover discutere prese di posizione chiare, la ricerca universitaria produce tesi che sono o così specialistiche da non aver alcun riferimento concreto o così generali e sofisticate da non potersi tradurre in posizioni chiare; come disse una volta il fisico Wolfgang Paoli, «non sono nemmeno sbagliate». Sulla necessità di prendere posizione in modo diretto, anche sbagliando, Chomsky ha insistito molto, ed è forse il suo lascito più prezioso. Pur essendo vissuto in una condizione privilegiata tutta la vita – la sua “reggia” al MIT e la sua condizione di intellettuale intoccabile nel sistema americano – o, forse, grazie a questa condizione, Chomsky ha sempre criticato il rapporto tra accademia e potere al punto di dire che «il sistema accademico non è altro che un sofisticato filtro che scarta le menti troppo indipendenti che non sono capaci di sottomettersi al sistema». Insomma, troppo spesso il rapporto tra potere e cultura, tra politica e pensiero, è nascosto e strisciante e l’intellettuale deve rivelarlo prendendo posizioni chiare, magari sbagliate. Ma meglio cadere che strisciare. E Chomsky non ha mai strisciato.