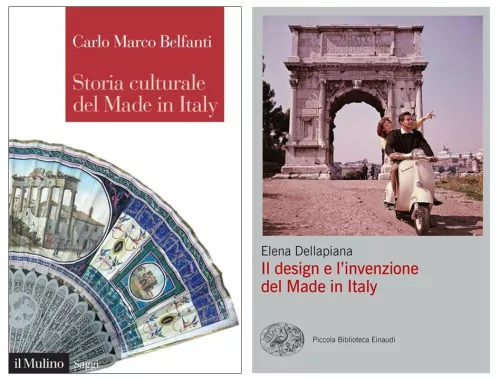La vera storia del Made in Italy
Quando si parla di Made in Italy non ci si riferisce soltanto al sigillo, al marchio o all’etichetta apposta sui prodotti nostrani per indicarne il luogo di provenienza, perché nell’universo mondo il termine Made in Italy significa molto, ma molto di più. Esso infatti è sinonimo di eleganza, di bellezza, di raffinatezza, di qualità esecutiva, di prestigio: in una parola, di eccellenza. Che si tratti di arte, di prodotti della moda, di quelli del design degli oggetti, o degli arredi, oppure del design delle automobili, dei motocicli o delle imbarcazioni, o che concerna un carattere tipografico, lo studio di un logo, la corporate identity di un brand, il packaging, i prodotti agroalimentari, o ancora la cucina (tradizionale o alta), tutti i beni made in Italy suscitano immancabilmente nell'immaginario collettivo un’ammirazione incondizionata innescando in automatico nel potenziale fruitore extra nazionale un desiderio di possesso, alimentatore, per nostra fortuna, di un fiorente mercato globale.
Da che è stato poi recentemente istituito addirittura un ministero ad esso dedicato (e precisamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy), appare più che mai opportuna una messa a punto del concetto stesso di Made in Italy, che ne contempli pure la storicizzazione. Ci soccorre in proposito una ricca letteratura, piuttosto articolata che spazia dalla filosofia alla sociologia, dalla storia all’economia, dall’arte al design, dalla moda alla cucina, eccetera, eccetera. In particolare, ci aiutano due libri usciti di recente:
Carlo Marco Belfanti, Storia culturale del Made in Italy, Il Mulino, 2019.
Volendo poi concentrare l’attenzione sulle Arti Applicate e quindi sul Design:
Elena Dellapiana, Il design e l’invenzione del Made in Italy, Einaudi, 2022.
Dal punto di vista storico, fin dal costituirsi del nostro stato nazionale e almeno fino al primo dopoguerra, i principali veicoli di diffusione del “gusto italiano” nel mondo sono state le rassegne espositive (Londra, 1851, 1862; Parigi 1878, 1889, 1900, 1902; Torino, 1902; Saint Louis 1903; Bruxelles e Buenos Aires, 1910; San Francisco 1910), a cui si deve aggiungere l’apporto del dibattito sul tema di un’identità italiana dei beni, quest’ultimo soprattutto ad uso interno alla nostra nazione, apparso, in modo a volte appassionato se pure non privo di conflittualità, sulle pagine di alcune riviste tra le quali Arte italiana decorativa e industriale di Camillo Boito (tra il 1890 e il 1911), Emporium (1895-1964 di Paolo Gaffuri e Arcangelo Ghisleri) e, ancor prima, più timidamente, sul Politecnico di Carlo Cattaneo, per rafforzarsi poi, e prender coraggio, a partire dagli anni venti del secolo breve, di cui si dirà, sulle riviste sempre più specificamente dedicate agli oggetti d’uso e all’arredo, quali, ad esempio, la Marangoniana La Casa Bella, 1928 (Casabella dal 1933), le pontiane Domus (1928) Aria d'Italia (1939, quest’ultima di Daria Guernati ma ispirata da Gio Ponti), Stile (1941-1947) e poi su quelle degli anni cinquanta e sessanta: Civiltà delle macchine di Leonardo Sinisgalli (1953-1979); Stile Industria di Alberto Rosselli (1954- 1963 e poi dal 1995-1997); La rivista dell'arredamento di Giovanni Gualtiero Görlich e Carlo De Carli (1954-1969, da questa data diventata Interni); Imago fondata da Raffaele Bassoli e Michele Provinciali (1960-1971); Casa Novità, di Piera Peroni (1961, dal sesto numero divenuta Abitare); Ottagono di Sergio Mazza e Giuliana Gramigna, (1966, ideata da otto brand storici del design italiano: Arflex, Artemide, Bernini, Boffi, Cassina, FLOS, ICF De Padova, Tecno) ed altre, tutte indistintamente fondamentali per la nascita e il successivo consolidarsi di quello che verrà universalmente riconosciuto come ‘Italian style’.

All’inizio si trattava proprio di definirla, questa benedetta identità nazionale dei prodotti italiani, incentivati dalle parole appassionate pronunciate da Boito in una famosa conferenza sulle Industrie Artistiche, tenutasi nel 1881:
“Bellezza e la grazia possono trovare, più o meno, il loro luogo adattato: nei navigli e nelle carrozze; nei finimenti da cavallo e nelle valigie da viaggio; nei tessuti … nei nastri … nelle scatole dei fiammiferi … La bellezza si caccia … anche in quei rumorosi ordigni di ferro e d’acciaio i quali servono a produrre moto.”
Ma l’eredità classica, tanto quella romana antica, così come quella rinascimentale (il concetto di Rinascimento, come ha riconosciuto Lucien Febvre, vede la luce proprio intorno a metà ottocento, ad opera di intellettuali e storici dell’arte come Jules Michelet, Jacob Burckhardt ed altri), facevano sentire il loro enorme peso culturale e la loro contagiosa influenza formale, causando non poche difficoltà al farsi strada di un linguaggio figurativo identitario italiano “assolutamente moderno”. A rendere ancor più ardua l’impresa concorse poi l'arretratezza del nostro sistema industriale, sopravanzato sempre dalla produzione artigianale, sorretta da una nostra innata predilezione (mai sopita) per il valore del ‘fatto a mano’, che, se da un lato contribuì a frenare lo sviluppo industriale, dall’altro finì per esaltare la straordinaria qualità dei nostri manufatti, rendendone precipua l’unicità nel panorama mondiale delle merci.
Il Made in Italy beneficia “dell’effetto Rinascimento, inteso come oltre al bello, il ben fatto: l’espressione bello e ben fatto indica, oltre all’estetica, la capacità di lavorare e nobilitare la materia innanzitutto in senso progettuale. Da questo punto il saper fare italico deve molto alle botteghe e alle corporazioni di arti e mestieri nate nell’Italia rinascimentale.” (Corbellini e Saviolo, La scommessa del Made in Italy, 2004).
Sebbene già a partire dal 1926 si trovino depositati presso varie Camere di Commercio molti marchi con la dicitura Made in Italy, come riconosce Belfanti “il processo di cambiamento del Made in … da mera indicazione del luogo di fabbricazione ad attestato di appartenenza a un paese identificato come depositario di un insieme di riferimenti culturali, estetici, produttivi” prende avvio a partire dagli anni ottanta del novecento. Prima di questa data era soltanto, soprattutto qui da noi, una encomiabile ricerca, come si è già detto, di un linguaggio ‘italiano’ del fare le cose, dei prodotti e dei manufatti, la ricerca di una nostra immagine identitaria, insomma, portata avanti da imprese pionieristiche e coraggiose a cui si deve il merito di aver scritto le prime pagine della storia del Made in Italy.
Tra di esse, alcune già a livello industriale, altre no, che hanno risposto all’appello patrio partecipando alle Esposizioni del secolo lungo e alle prime del secolo breve, si annoverano:
Per la ceramica: Carlo Ginori e Ginori Lisci (Doccia, Sesto Fiorentino): Giulio Richard (Milano), poi Richard Ginori dal 1896; le Cooperative di Faenza, Nove e Colonnata; la Manifattura Cacciapuoti (Napoli); la Manifattura Cantagalli e la Manifattura Chini (Toscana).
Per le ceramiche da edilizia: Appiani (Treviso).
Per il vetro, i veneziani: Pietro Bigalia, Dandolo, Salviati, Tommasi, Toso, Venini, Zanetti e la Compagnia di Venezia e Murano; Luigi Fontana (Milano).
Per i mobili: le aziende produttrici delle sedie Chiavarine, il mitico Carlo Bugatti e i grandi Eugenio Quarti (Milano) e Vittorio Valabrega (Torino).
Per i trattori e le prime automobili, la Fiat. E poi Barilla, Campari &C., Edison, Montecatini, Pirelli, G. Ricordi &C., ed altre ancora che sarebbe troppo lungo enumerare.

Il vero decollo dei manufatti italiani di Arte Applicata sul mercato internazionale, così come una fondamentale “messa a punto” del loro linguaggio formale in direzione moderna, avviene a partire dagli anni venti del novecento, soprattutto grazie alle Biennali di Arti Decorative monzesi (1923, 1925, 1927, 1930) che, divenute Triennali dalla loro IV edizione, dalla V, nel 1933, si trasferiranno a Milano, nel Palazzo dell’Arte appositamente costruito da Giovanni Muzio, vera culla del design Made in Italy, ancora oggi luogo di elaborazione e di studio della cultura italiana del progetto. Alle Biennali furono esposti “vetri, ceramiche, tessuti e mobili che esprimono le novità dei linguaggi formali, il gusto borghese Art Nouveau e i tentativi di serializzazione – in sintesi le questioni dibattute da un quarto di secolo sul rapporto arte – industria.” (Dellapiana)
A contribuire a questo risultato concorse anche il fiorire di scuole superiori del settore artistico, prima fra tutte l'Università delle Arti Decorative, fondata a Monza nelle scuderie della Villa Reale da Guido Marangoni (leggi qui su Doppiozero), della quale quest’anno si celebra il centenario della fondazione con una serie di iniziative.
Curatrice della Sezione Italiana all’Exposition Internazionale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes di Parigi del 1925, fu Margherita Sarfatti, attivamente presente anche alle Biennali monzesi, in prima linea nella promozione di “un’audacia di espressione pienamente moderna” nei prodotti nazionali delle arti decorative e ciò in contrasto con lo spazio che ospitava la rassegna francese. Quest'ultimo, infatti, firmato da Armando Brasini, che Pietro Maria Bardi avrebbe severamente condannato in un suo articolo, rammaricandosi della “penosa impressione suscitata dal Padiglione italiano”, altro non era se non un finto ‘mausoleo’ così ridicolmente eclettico, da sembrare la scenografia cinematografica in cartapesta di un filmetto di quart’ordine.
Certo il Brasini, con tutta la sua progettualità arrogante, incolta e piena di prosopopea, compiacente nei confronti dei dictat mussoliniani, a Parigi si trovò ad essere come “un vaso di terracotta costretto a viaggiare con molti vasi di ferro”, per dirla con il Manzoni, (anche se lui si reputava un vaso d’oro) visti i titani coi quali si raffrontava: da Auguste Perret (teatro) a Mallet-Stevens (Padiglione del Turismo, in calcestruzzo armato), da Mel’nikov (Padiglione sovietico, vero manifesto del Costruttivismo) a Le Corbusier (Padiglione de l’Esprit Nouveau, decalogo del Movimento Moderno).
Paolo Portoghesi definisce Armando Brasini “uno dei grandi intrusi nell’architettura del Novecento”, che si è per di più macchiato di insanabili crimini urbanistici, concorrendo al Piano Regolatore di Roma del 1931 che rase al suolo molta parte del centro storico per costruire la Via Imperiale e colpevole anche di aver spazzato via quasi tutto il Campo Marzio per fare posto al Foro Mussolini.
Malgrado gli ‘ini’ (Brasini e Mussolini), l’identità italiana dei prodotti, quando questi furono presentati a Parigi, era ormai nata, nel solco tracciato da Arrigo Boito con la sua ‘educazione al buon gusto’. Essa avrebbe raggiunta l’adolescenza negli anni trenta, per diventare adulta negli anni cinquanta, quando il design Made in Italy si sarebbe affermato nel mondo.

Sono convinta che uno dei motivi della sostanziale ‘virata’ del prodotto italiano dalle Arti Decorative al Design sia dovuta, insieme al farsi strada del processo industriale e alla presenza sul nostro territorio nazionale di imprenditori illuminati, al passaggio di testimone della creatività da quella degli artisti che lo avevano retto fin dall’ottocento, alla progettualità degli architetti, che lo deterranno, prima timidamente, poi, a partire dagli anni venti acquistata sicurezza, in modo egemone per tutto il secolo breve.
Alla voce di Boito si sostituirà quella di Giuseppe Pagano Pogatsching, ugualmente appassionata nell’insistere “sulla cifra nazionale del progetto italiano e sulla necessità di mantenere un forte legame con la tradizione artistica.” (Dellapiana)
Insieme alle Esposizioni, negli anni venti, un contributo alla diffusione del prodotto italiano lo diedero anche alcune iniziative commerciali di largo respiro, come quella della Società AMI (Arte Moderna Italiana) di Maria Monaci Gallenga che lo promosse nei Paesi Bassi, aprendo poi negozi, oltre che ad Amsterdam e a Bruxelles, anche a Londra, Montreux, New York, Boston, San Francisco, Portland, Chicago e Saint Louis. E ancora quella della mostra Italian Arts and Crafts, tenutasi a Londra nel 1924 in Oxford Street e poi, nello stesso anno, quella della fiera galleggiante che portò i prodotti italiani in America Latina, a bordo della nave regia Italia, antesignano esempio di turismo di massa, non già delle genti, bensì delle merci. Questa era stata “voluta da Giacomo Matteotti, insieme al primo presidente di Confindustria (ebreo) Gino Olivetti, portatore di una visione industriale e internazionale del prodotto italiano e fascista.” (Dellapiana)
Nonostante le aspettative, che contavano sul numero di connazionali emigrati in quella parte del mondo, il prodotto italiano, futuro Made in Italy, lì non ebbe successo, mentre continuò a vantare dei fans, sempre di più fidelizzati, nel Nord America e nel Nord Europa, grazie a grandi estimatori, quale ad esempio il multimiliardario barone Edmond de Rothschild, collezionista di oggetti di opere d’arte italiana del Rinascimento, e ad appassionati cultori dei nostri prodotti artistici nazionali.
E poi, negli anni cinquanta, arrivò Gio Ponti, che seppe unire la capacità creativa, quella di progettista di forme straordinarie, divenute presto best sellers del Made in Italy, a quella divulgativa, di educatore alla bellezza. Egli infatti oltre che per l’indubbia poesia delle sue creazioni, va ricordato anche per l’inesausto anelito didattico, animato da una urgenza divulgativa del bello che Agnoldomenico Pica definì ‘apostolato artistico’.
Il maestro milanese lo praticò tanto nelle aule universitarie quanto, e soprattutto, dalle pagine delle riviste da lui fondate, di cui si è detto, ed anche nelle mostre organizzate all'estero dalla sua Domus (Parigi, 1967; Zurigo, 1969; Rotterdam, 1970) per far conoscere lo stile italiano, così si chiamava quello che sarebbe poi stato denominato Made in Italy, al di fuori dei confini nazionali, e specialmente in varie edizioni del Salone del Mobile e nelle quattro di Eurodomus.
Il libro di Elena Dellapiana dà quindi puntuale riscontro di tutte le Esposizioni internazionali che dagli anni trenta fino ai nostri giorni, hanno visto la presenza del prodotto italiano, e censisce con metodo il dibattito sul tema dell’Italian Good Design, che ha tenuto banco sulle riviste, nei convegni, nei congressi e che ha visto il progressivo affermarsi del Made in Italy.
Di un analogo excursus nel campo della moda si occupa invece il volume di Carlo Maria Belfanti.
Si tratta in tutti e due i casi di un percorso lungo e articolato, non privo di colpi di scena, della cui scoperta non si vuole privare il lettore, per non togliergli il gusto della sorpresa.
Una cosa hanno in comune il Made in Italy del design e quello della moda, il Rinascimento nel DNA, entrambi, infatti, hanno a che fare con la bellezza e con l’eccellenza.
Grazie Brunelleschi, Leonardo, Michelangelo, Palladio, Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano.
Grazie.