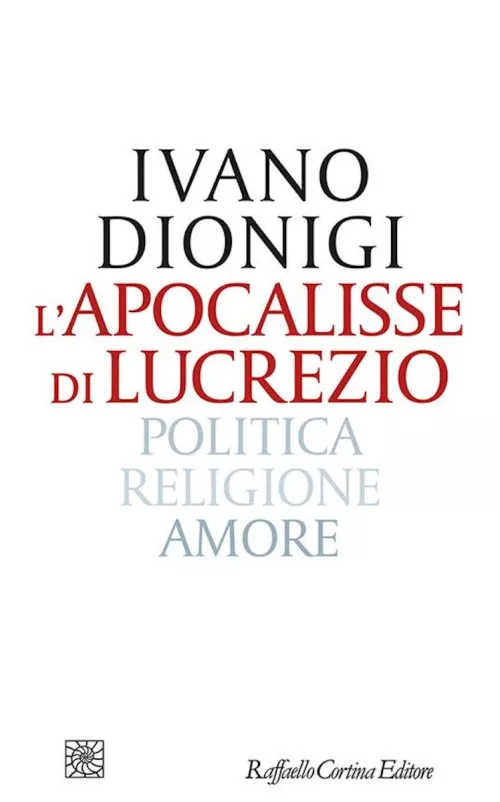Lucrezio apocalittico
I classici sono tra noi. Per questo sono classici. Le mode si succedono alle mode. Stili nascono e tramontano. Tendenze affermate svaniscono come non fossero mai state. Essi invece permangono. Lo sa bene Ivano Dionigi e lo dimostra nelle duecento dense e intense pagine di questo suo L'apocalisse di Lucrezio, Cortina, 2023.
Proprio in omaggio a questa conclamata perenne contemporaneità, dato che siamo ora nell'anno centenario di Italo Calvino, voglio partire dal capitolo due del libro: In principio era la grammatica, che ha oltretutto un evidente sapore inaugurale. Qui infatti si registra una singolare consonanza proprio tra Lucrezio e Calvino. Se per l'autore novecentesco la scrittura si presentava come “modello d'ogni processo di realtà” (Lezioni americane), già per il poeta antico il suo poema, De rerum natura, si configurava come esecuzione grammaticale del cosmo. In che senso? In questo: la realtà per Lucrezio, si sa, era fatta di atomi, un numero ristretto di elementi primordiali dalla cui incessante combinazione nasceva il tutto. Esattamente come dalle poche lettere dell'alfabeto, variamente combinate, si generavano testi di ogni tipo, compreso il poema di Lucrezio stesso. Esisteva un'autentica osmosi e convertibilità tra ordine fisico e ordine linguistico. Gli elementa vocis corrispondevano esattamente agli elementa mundi. Sovrapponibilità favorita anche dal fatto che in latino elementum, al pari del greco stoicheîon, possedeva i due significati: atomo e lettera.
Ancora più sorprendente è il fatto che i principi regolatori degli atomi sono cinque: incontri, movimenti, ordine, posizione, forme. Sorprendente anche perché queste cinque voci (concursus, motus, ordo, positura, figura) sono precisamente parole tecniche della grammatica e retorica latina, nonché di quella greca: sýnkrousis, kínesis, táxis, thésis, schêma. Siamo dunque in presenza di un'equipollenza totale tra struttura fisica e struttura verbale.
Anche per gli stoici Democrito e Leucippo, lo dice Aristotele, valeva lo stesso principio ed essi pure sottolineavano l'omologia: come con le stesse lettere dell'alfabeto si potevano comporre sia tragedie sia commedie, così un numero ristretto di atomi presiedeva alla generazione dei corpi più diversi. La grande differenza introdotta da Epicuro e testimoniata da Lucrezio sta in questo: esiste un fattore di libertà nel processo di aggregazione degli atomi, una lieve declinazione (exiguum clinamen), che si verifica in un punto e momento indeterminati ( nec regione loci certa nec tempore certo), ma che consente di superare il determinismo meccanicistico degli atomisti stoici e introduce un momento sottratto alle ferree leggi del fato. Anzi non solo lo introduce, ma lo inscrive proprio nella creazione stessa dei corpi. La libertas diviene elemento strutturale, ossia, usando la terminologia lucreziana, un coniunctum e non un eventum (qualità solo accidentale).
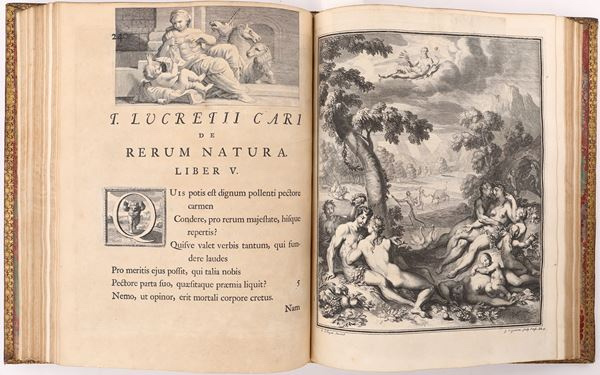
Lucrezio era sì un materialista. Ma non poteva tollerare che la necessità avesse il sopravvento sulla libertà.
Un altro materialista, ora non molto in auge ma pur sempre di un certo peso filosofico, Karl Marx, nella sua tesi di dottorato, considerava proprio la teoria del clinamen determinante nello stabilire la differenza tra la filosofia della natura di Epicuro e quella di Democrito.
Rimaniamo al clinamen. Anch'esso si pone nella linea di continuità tra fisica e lingua. Perché? Ma perché è omologo alla declinatio, ossia alla flessione del nome e del verbo che, secondo Varrone, è legge generale e principio generativo del lessico. Per Lucrezio tutto è generato dall'atomo e tutto è riconducibile all'atomo e, allo stesso modo, tutti i testi hanno parole diverse ma lettere uguali. Ne viene fuori un principio rivoluzionario di parificazione dei realia così come dei prodotti della retorica. Al modo che non c'è differenza, a rigore, tra una pietra, un filo d'erba, un vitello, una giovenca e un essere umano, che sono fatti tutti della stessa materia, non c'è nemmeno differenza tra la descrizione del pulviscolo atmosferico o della Venere generatrice di vita o di quella plebea e vagabonda o tra le parole che riferiscono il dolore del saggio e quelle che hanno per argomento il dolore di una giovenca che ha perduto il suo vitellino.
Niente di più lontano dalla concezione gerarchica sia della retorica tradizionale, ciceroniana per esempio, sia dall'antropocentrismo di marca stoica.
Lucrezio era un sovversivo. Un iconoclasta. La sua fu un'autentica apocalisse, ossia rivelazione. Meglio: un disvelamento. Per lui la verità è un'opera di sottrazione non di cumulo. La sua concezione della poesia non è legata alle bellurie di stile. Egli è contro l'allegoria, contro l'uso del nomen traslatum e per il nomen proprium. Contro le metafore fumose e per le cose chiamate con il loro nome autentico. Nel prologo del terzo libro enuncia chiaramente il suo programma: eripitur persona, manet res. Si toglie la maschera, appare il vero. L'antitesi maschera-realtà, come anche quella luce-tenebra (lux-tenebrae), sono portanti nel poema.
E cosa annuncia questo profeta? Questo seguace dell'eroismo intellettuale di Epicuro, che si affida, come il Maestro, non alle armi ma alle parole (dictis, non armis)?
Innanzitutto fa piazza pulita della religione. La religio che per lui viene dal verbo religare, “legare”. Se si fa beffe della religione mitologica dei poeti, quella detta fabulosa, se deride anche quella naturale, propria dei filosofi, frutto del timore ispirato dalla vista dei fenomeni naturali (primus in orbe deos fecit timor, Petronio), è però soprattutto contro la religione civile, pubblica, statale che si scaglia. Rompe il nodo strettissimo tra Potere e Religione, tipico della Roma repubblicana, e non solo. Una religione di stato, fitta di riti, prescrizioni, cerimonie, non solo inutili, ma criminali. Come esemplifica il sacrificio di Ifigenia, che il padre Agamennone voleva immolare, e per cosa? Per poter salpare alla volta di una guerra. Tantum religio potuit suadere malorum: “a così grandi mali ha potuto indurre la religione”. Verso che per Voltaire sarebbe durato quanto il mondo. Né tanto meno risparmia l'arte divinatoria, in quanto anch'essa fondata sul nulla. Anche Cicerone aveva scritto che due auguri, incontrandosi, non potevano fare a meno di ridere. Però il console nondimeno continuò a far parte del Collegio (degli Auguri, per l'appunto).
Si badi bene però: per Lucrezio come per Epicuro gli dei esistono. Solo che, proprio perché sono dei, se ne stanno tranquilli negli spazi cosmici (intermundia) e, chiusi nella loro divina imperturbabilità, non interferiscono con le vicende degli uomini. Si tratta di perfette rappresentazioni del Deus otiosus o, meglio, di Dii otiosi.
Per lui, comunque, la vera pietas non è quella di chi si fa vedere col capo velato o si accosta a tutti gli altari o vi si getta e vi si prostra, né quella di chi intreccia voti su voti. Per Lucrezio, ed è questo un elemento di novità anche rispetto al sostanzialmente devoto Epicuro, la vera pietas è di tipo intellettuale, è un atto della mente: guardare il tutto con mente tranquilla: sed mage pacata posse omnia mente tueri. È una definizione laica e razionalistica della pietas. Che si esercita tramite la “visione e scienza della natura” (naturae species ratioque, formula ricorrente nel poema). La sapientia è l'ars suprema.

Accanto alla demolizione della religio non poteva che esserci la demolizione dell'attività politica, che su quella si puntellava. Il politico è rappresentato da Sisifo: il personaggio mitologico rotola il suo sasso vanamente, esattamente come è vana la ricerca del consenso da parte del politico. Il potere è una chimera. Un inutile sforzo perpetuamente da ricominciare. Il vero imperium è quello di chi se ne sta in disparte, come Epicuro. Anzi, di chi ubbidisce quieto (parere quietum). Virgilio rovescerà polemicamente questa posizione. L'imperium, per quest'ultimo sarà infinito, sine fine. Per Lucrezio infiniti invece sono i mondi, come poi anche per Giordano Bruno.
Anche la paura della morte va combattuta. Non solo perché su di essa si regge la religione, e anche il potere politico in certa misura. Per Lucrezio, anticipando di millenni Elias Canetti, il tiranno erige le sue torri su fondamenta di morti. Cumuli di morti.
Ma la morte non esiste. Non solo perché, come per Epicuro, essa non è un'esperienza (se ci siamo noi, non c'è la morte, e viceversa). Ma anche perché non di morte si tratta, a rigore, bensì soltanto di dissoluzione o disaggregazione di atomi, che poi si riaggregheranno in altre formazioni. Secondo l'eterna vicenda di míxis e diállaxis (“composizione e scomposizione”) descritta già da Empedocle, ammirato da Lucrezio più come poeta che come filosofo. O, se si vuole, seguendo quel ritmo di perenne creazione e distruzione di cui, nel dialogo della Natura e dell'Islandese, discorse un altro poeta e filosofo, cioè Leopardi.
L'essere umano è invitato dalla Natura in persona, secondo Lucrezio, ad abbandonare sereno la vita, come un convitato sazio (conviva plenus) lascia il banchetto.
Quanto all'amore, l'altra perenne minaccia al nostro equilibrio e fonte di turbamento perpetuo, Lucrezio, da un lato pare esaltare il sesso (libido) e condannare la passione (cupido). Ma sembra poi contraddirsi irrimediabilmente usando per entrambi lo stesso aggettivo: dirus. Sì, non c'è solo, come ci si aspetterebbe la dira cupido, ma anche la spiazzante dira libido. Sia il sesso che l'amore vengono accomunati nella condanna, dato che “dira” significa “orribile”, “mostruosa”, “contronatura”.
Le pagine lucreziane del quarto libro, sugli amanti che si abbracciano disperatamente nella vana ricerca di un'impossibile fusione, hanno ricordato a Dionigi le pagine del Seminario. Libro XIX di Lacan, con il famoso aforisma in esse contenuto: “il rapporto sessuale non esiste”. Già nell'autore antico l'Altro rimaneva tale; del resto, sottolineava Lévinas, se si potesse possedere l'altro, esso non sarebbe l'altro.
D'altro canto, se non si sa accettare la legge dell'alterità, si finisce col rimanere nell'“inferno dell'uguale” (Byung-Chul Han).
E con ciò ho inteso anche fornire un minimo esempio della trama di auctoritates moderne e contemporanee che sostanziano le pagine di Dionigi.
In conclusione, cosa ha da dirci oggi questo poeta isolato, assoluto, scomparso per un millennio circa dalle scene culturali dell'Occidente? Questo onomaturgo che non ha nulla da invidiare a Dante, quanto a forza inventiva e sguardo d'aquila sulla realtà? Questo descrittore di innamorati e appestati (tutt'e due accomunati dall' anxius angor, “angoscia straziante”)?
Ha da proporci, secondo Ivano Dionigi, un messaggio incentrato sul valore e sul primato della conoscenza intellettuale e della ricerca del vero, perché “è il pensiero umanistico la struttura dura, l'hardware che fa girare i programmi dei saperi specifici. Tutto il resto è software”.