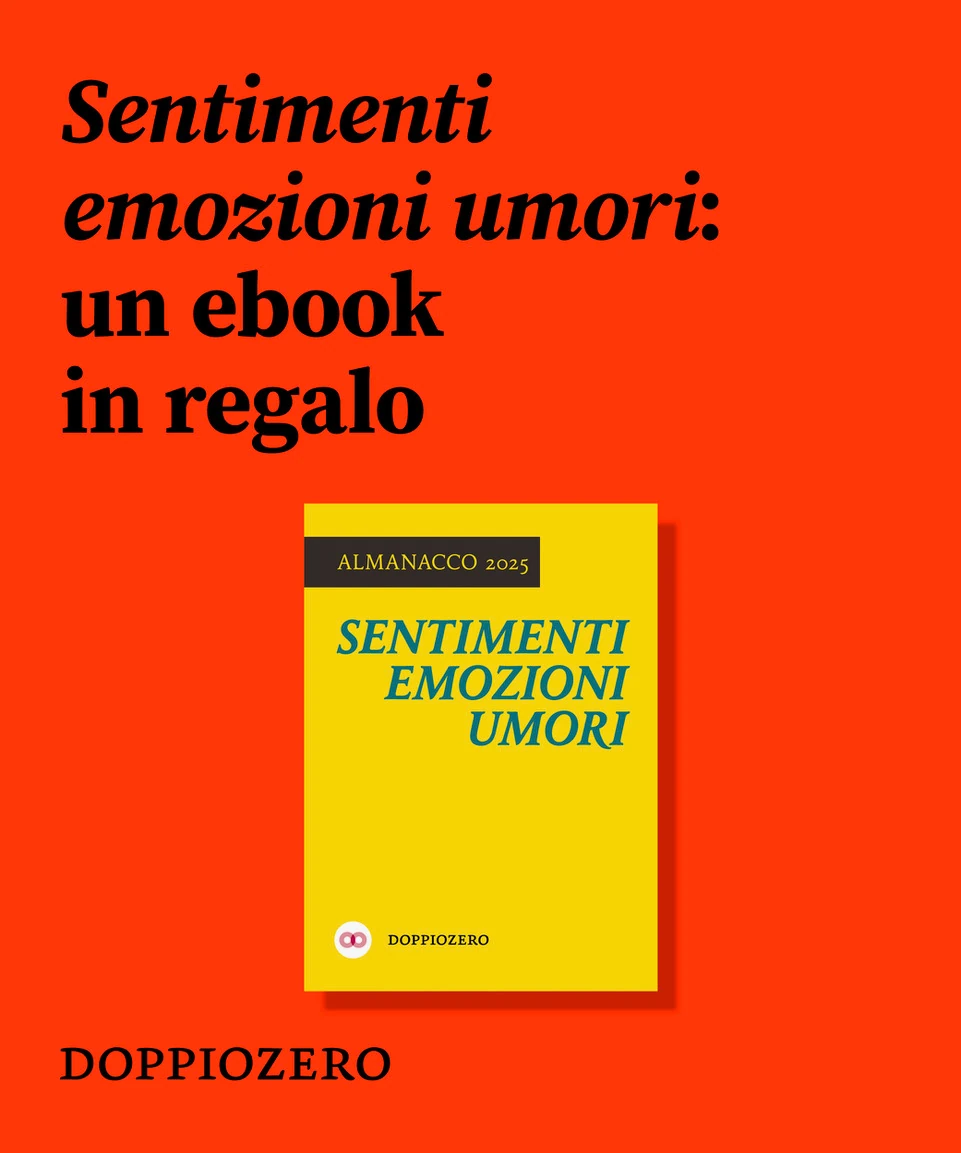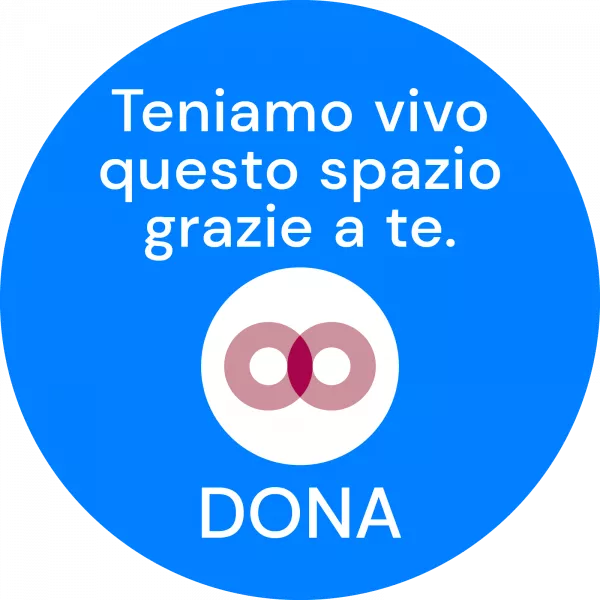Monaco 1938: la pace iniqua
L’Europa è sotto shock dopo Monaco. Nella città bavarese l’Era della Brutalità, segnata dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, si manifesta in tutta la sua scuotente potenza. Alfiere della nuova rivoluzione conservatrice, fondata sull’idea di democrazia plebiscitaria che conferisce potere assoluto ai leader eletti e sul tramonto della democrazia liberale, pensata come inutile forma di ostacolo a un’investitura che si vorrebbe legibus solutus, il trumpismo si manifesta con il volto di Giano della pax imperiale a spese dell’Ucraina e dell’attacco ideologico dell’hillbilly Vance alla decadente Europa. Quest’ultima accusata dal vice-presidente americano di essere vittima del politicamente corretto, del multiculturalismo, della mancata lotta all’immigrazione, di imbavagliare la libertà d’opinione dei cittadini ormai digitali e ignorare il loro consenso alle formazioni di estrema destra.
Una manifestazione di brutal power, quella esibita in Germania dalla “nuova” America, che sancisce la rottura culturale, oltre che politica, della storica alleanza tra le due sponde dell’Atlantico, e mette all’angolo l’Europa, incapace di pensarsi come qualcosa di diverso da un’area di libero scambio e spazio di diritti. Del resto, le parole di Trump sull’Europa “nata per fregarci” sono eloquenti. Nell’America di oggi, guidata dall’alleanza tra trumpismo protezionista e tecnodestra iperliberista, non vi è posto per quelle che sono considerati orpelli del passato. Così, si tratti di dazi, ordinatori di potenza prima ancora che strumenti commerciali, o di associare l’Unione alle trattative con la Russia, dopo il gravoso impegno a sostegno dell’Ucraina sollecitato da Biden, nessun trattamento di riguardo per Bruxelles: il 2025 è l’Anno Zero delle relazioni euro-americane.
A proposito di passato, il grande scossone avviene in un luogo tragico per l’ormai pur labile memoria europea, che evoca senso d’impotenza, drammatici errori e tristi presagi. Certo, la situazione storica, i protagonisti, le forze in campo, sono diverse da quelle che il 29 e 30 settembre 1938 partecipano – nel Führerbau costruito da Paul Ludwig Troost nello stile della nuova architettura di regime –, alla Conferenza che riunisce attorno al tavolo delle trattative Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna. La storia non si ripete ma, a volte i nomi, hanno una capacità evocativa più forte di ogni rigorosa ricostruzione.
Monaco 1938 è stato l’ultimo tentativo di scongiurare un conflitto su vasta scala in Europa legato alle crescenti rivendicazioni tedesche. Rivendicazioni, come quelle italiane di pochi anni prima nei confronti dell’Etiopia, che hanno come oggetto l’acquisizione di territori. Il format della discussione nella Königsplatz è quella della negoziazione tra potenze statuali, non quello della mai decollata Società delle Nazioni, programmaticamente delegittimata dalle potenze fasciste, fautrici del primato dello stato nazionale, e dalle contraddizioni interne della fragile antesignana ginevrina dell’Onu. In un ordinamento internazionale in cui a contare sono gli stati, abbattere ogni forma di multilateralismo è il palese intento degli autoritarismi rivoluzionari emersi dall’incandescente “secolo breve”, fervidi oppositori del wilsonismo democratico che ispira gli Stati Uniti. In quei delicati frangenti, però, l’America rooseveltiana – concentrata sulla lotta alla Grande Depressione e frenata da un partito repubblicano isolazionista –, non c’è. Occuperà la scena solo dopo il tracollo europeo seguito alla guerra.
Dopo l’annessione dell’Austria, nel 1938 la Germania esige i Sudeti, regione della Cecoslovacchia in cui la popolazione è in prevalenza germanofona. L’incontro in Baviera si chiude con l’accoglimento delle richieste di Hitler, ponendo le basi per il successivo smembramento del paese centro-europeo. In tal modo la guerra viene, momentaneamente, evitata: con grande soddisfazione, per diversi motivi, delle classi dirigenti e delle masse popolari dei quattro grandi paesi europei. Quelle tedesche esultano per l’ennesimo successo del Führer contro lo “spirito di Versailles”; quelle italiane inneggiano, poco guerrescamente, a Mussolini, osannato, durante il viaggio di ritorno in treno, da ali di folla che plaudono entusiasticamente al provvidenziale “salvatore della pace”; quelle britanniche e francesi sospirano per aver evitato un carnaio che, questa volta, non sarebbe rimasto circoscritto alle trincee della Marna e della Somme. Ma l’accordo si limita a comprare tempo – anche a costo di sacrificare sovranità nazionali e assetti territoriali internazionalmente riconosciuti –, non scongiura l’imminente resa dei conti.
In Francia esultano anche gli intellettuali. Dagli “occidentalisti” di destra di Thierry Maulnier, ostili alla guerra perché con essa potevano crollate i bastioni autoritari contro il comunismo, non ancora pronti a sostenere lo scontro decisivo con l’Urss, a quelli socialisti o pacifisti alla Emmanuel Berl, ostili perché già troppo sangue era stato versato in passato. Non sfugge, invece, ai più avveduti che l’intesa è solo una pausa nella marcia verso la deflagrazione totale.
Il 7 ottobre, a Parigi, viene pubblicata la Dichiarazione del Collegio di Sociologia sulla crisi internazionale, siglata da Georges Bataille, Roger Caillois e Michel Leiris, alla guida di quella particolare comunità elettiva di azione e ricerca che pone al centro della sua riflessione temi come il potere, il sacro, i miti (Il Collegio di Sociologia, a cura di D. Hollier, Bollati Boringhieri, 1991). Il documento è, materialmente opera di Caillois, che lo redige in consultazione con Bataille, autore nel 1933 di un saggio, La struttura psicologica del fascismo (Mimesis, 2010), che, visionariamente, mette in luce i tratti “religiosi” dei nuovi capi carismatici di estrema destra, ritenuti, contrariamente alle tesi dominanti in campo marxista, decisivi nel successo di un movimento capace di unificare ricchi e poveri, ceti medi e lavoratori travolti dal rapido mutamento sociale, così come di generare pulsioni profonde e suscitare miti viventi che danno forma a una potente identificazione collettiva.

La Dichiarazione esprime una posizione controcorrente: mentre le democrazie esultano per lo scampato pericolo, il Collegio osserva “con disincanto” la soluzione diplomatica che ha prodotto il mantenimento della pace al prezzo del via libera a Hitler nei Sudeti. Il documento denuncia le interpretazioni più diffuse, “facili e fragili”, sottolineando come, davanti a “l’esperienza capitale” della crisi, si siano manifestate reazioni psicologiche collettive suscitate dall'imminenza della guerra, che hanno rivelato uno "smarrimento immobile e muto", un abbandono all'avvenimento. Oltre che un atteggiamento “impaurito e consapevole della propria inferiorità" da parte di un popolo, come quello francese, che “si rifiuta di ammettere la guerra tra le possibilità della propria politica" di fronte a una nazione, la Germania, che sulla guerra fonda esplicitamente la sua. Atteggiamento, quello delle democrazie occidentali davanti alle minacce hitleriane, ritenuto intriso di "fariseismo e donchisciottismo platonico".
Il Collegio nega che, come sostengono media e leader politici, di fronte alla “prova” i francesi abbiano mostrato sangue freddo, dignità, risoluzione: ciò che si è visto è, invece, "costernazione, rassegnazione, paura". Le reazioni alla prospettiva della guerra – “i più disorientati credono di aver agito da eroi” – sono interpretate come "rilassamento" dei legami societari minati dall'individualismo borghese. Condizione, constata il Collegio, che produce uomini soli che, non avendo ragioni profonde per lottare, si mostrano “mansueti come pecore coscienti e rassegnati al macello". La Dichiarazione si conclude esortando quanti hanno compreso che l’unica via d’uscita dall’angoscia è “un legame vitale tra gli uomini” a riconoscere “l'assoluta menzogna delle attuali forme politiche e la necessità di ricostituire dalla base un modo di esistenza collettiva” che, trascendendo ogni limitazione geografica e sociale, consenta di “avere un po’ di dignità sotto la minaccia della morte”.
Critica dell'individualismo borghese, incapacità di reagire al livello dello scontro imposto dalle nuove potenze mitologiche, rifiuto di appartenenze non elettive come quelle alla nazione e del nazionalismo, nuove solidarietà transnazionali, segnano la dichiarazione del Collegio di Sociologia dopo Monaco, che insiste sul cedimento delle democrazie davanti a ordini politici che fondano il loro tratto caratteristico sull’uso della forza.
Mentre Caillois scrive materialmente il documento, e Bataille è accanto alla compagna Colette Peignot, ormai morente, Leiris è a Nimes per seguire la corrida del torero Rafaelillo. Un tempo sospeso, quello vissuto in Occitania dall’autore dello Specchio della tauromachia (Bollati Boringhieri, 1999), come quello del mondo che attende notizie da Monaco, attonito davanti alla prospettiva della guerra. In questi giorni di inizio autunno carichi di tensione, la sfida tra uomo e toro viene rinviata. Leiris è, umanamente, dilaniato tra il timore delle conseguenze per il fallimento del negoziato e la consapevolezza che, se anche si giungesse a un’intesa, sarebbe solo una questione di tempo e di sorte, per ora, toccata ad altri. Quando ancora ignora se, a causa dei drammatici eventi che si preannunciano in caso di insuccesso, potrà assistere al combattimento, scrive a Jean Paulhan: “Questa corrida è diventata qualcosa di essenziale e immenso come i piaceri del bambino che si chiede se gli verranno rifiutati […] Non è questione della corrida in quanto tale, sia chiaro! Ma di ciò che rappresenta la possibilità di esserci”. Con grande sollievo, ci sarà il 9 ottobre 1938, quando le porte dell’arena si riapriranno. La pace di Monaco consente a tutti – anche se non ai cecoslovacchi –, di riprendere a vivere la propria quotidianità. Per un po’ si può dimenticare. In attesa della guerra che, spazzando via ogni illusione sortita dalla Königsplatz, scoppierà il 1° settembre del 1939.
Monaco, 16 febbraio 2025. Il “franco” discorso del vice-presidente americano alla Conferenza sulla sicurezza rende evidente che il vecchio mondo non regge più. Logorato da dentro, con le sue irrisolte contraddizioni, e da fuori, con l’irruzione dei nuovi “barbari” venuti a distruggerlo e a spazzarlo via. Gli europei si sono a lungo cullati nell’idea che quell’ordine potesse durare, se non per sempre, per un tempo ancora lungo. Non hanno pensato, e voluto prepararsi, alla sfida. Li hanno indotti ragioni politiche ed economiche, e complessi equilibri, ma anche una sorta di incapacità di pensare il mondo come ambiente rischioso. Quale supponenza nel ritenere che il mercato, e la democrazia, avrebbe risolto e omologato tutto e sarebbe stato sempre possibile contare sulla garanzia di sicurezza americana! Così, con poche eccezioni, hanno rinunciato a pensare che fosse venuto il tempo di attrezzarsi per far fronte alla situazione espressa, nella sua dura pastorale bavarese, da quel Vance che, in futuro, forse potrebbe succedere a Trump.
Per evitare che il nuovo Nomos del XXI secolo sia deciso dai “tre imperi” (Stati Uniti, Russia e Cina, con i primi che puntano a tenere distante la seconda dalla terza) o, per proteggersi dal conflitto che prima o poi potrebbe contrapporre Washington e Pechino nel Pacifico – sguarnendo definitivamente dall’(ex) amico americano il Vecchio Continente, posto così davanti a un destino “russo” –, l’Europa doveva scegliere di abbandonare la sua illusoria comfort zone. Mettendo da parte gli egoismi nazionali che ne fanno un pletorico organismo interstatale e dando vita a quelle cooperazioni rafforzate che oggi consentirebbero di avere una politica estera, e una difesa, autonoma. Non l’ha fatto, ha sperato e atteso. Lasciando, vanamente, scorrere il tempo, fattore sempre decisivo in politica. Riuscirà ora l’Unione a imboccare quella strada o, preda di paralizzanti unanimismi e quinte colonne trumpiane, il suo sarà solo un vano agitarsi: un Falsche Bewegung, un falso movimento, in un labirinto divenuto sempre più oscuro e senza uscita?