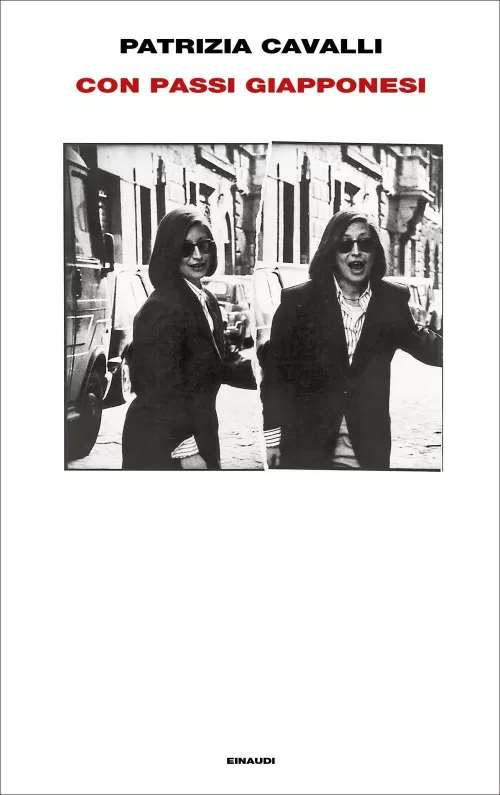Prosa e poesia / Patrizia Cavalli, con passi giapponesi
Nella letteratura italiana degli ultimi centocinquant’anni non sono molti gli scrittori che si sono dedicati con lo stesso impegno alla poesia e alla prosa, e che hanno ottenuto risultati egualmente significativi in entrambi i campi. Io non saprei citarne più di tre: d’Annunzio, Palazzeschi, Pasolini. Su questa via s’era mosso anche Rocco Scotellaro, ma la sua parabola è stata troppo breve (colgo l’occasione per ricordare la recente uscita negli Oscar Mondadori di Tutte le opere, a cura di Franco Vitelli, pp. XX-800, € 28). In compenso, non pochi poeti hanno pubblicato preziose raccolte di narrazioni e saggi (critica letteraria a parte), ciascuna a proprio modo, rivelatrici.
Abbiamo così avuto Il povero nella città di Ungaretti, Scorciatoie e raccontini di Saba, La farfalla di Dinard di Montale, Gli immediati dintorni di Sereni: opere che, senza intaccare il primato della produzione in versi dei rispettivi autori, rappresentano un indispensabile complemento per definire la loro fisionomia e il loro universo poetico. Potrei sbagliarmi, ma altrettanto non mi pare si possa dire per i narratori e i romanzieri, le cui incursioni nel territorio della poesia serbano un carattere più occasionale e accessorio; senza peraltro dimenticare eccezioni importanti, come Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante o Ad ora incerta di Primo Levi.
Voce poetica di alto e consacrato valore, Patrizia Cavalli pubblica ora, all’età di settant’anni, il suo primo libro in prosa. Con passi giapponesi è una raccolta di testi in prevalenza inediti; dei cinque già apparsi a stampa, il più antico, Arrivederci anzi addio, è uscito su «Paragone» nel 1975. Ampio, dunque, l’arco cronologico delle composizioni; e piuttosto vario il tenore dei diversi pezzi. Ricordi, racconti, ritratti, apologhi, riflessioni, descrizioni: come ha scritto Emanuele Trevi sul «Corriere», Con passi giapponesi è «un libro con molti centri, screziato, irregolare».
I testi raccolti sono brevi: i più lunghi sfiorano le venti pagine (senza mai raggiungerle), molti ne contano due o tre, altri, specie nella sezione intitolata Varietà, si limitano a poche righe. Eppure, l’effetto è meno di una silloge che di una rapsodia, suddivisa bensì in un numero (non canonico) di movimenti, dove l’orchestra lascia sovente spazio a interludi solistici, ma che fluisce con un’intima coerenza di atmosfere e armonie. Come definirla? Una risposta si trova nel denso risvolto di Alfonso Berardinelli, che ravvisa il nocciolo di queste «prose di poeta» nell’imperativo «Devo capire». Giustissimo. E l’impegno alla conoscenza si fonda essenzialmente su uno strumento: il linguaggio.
Che i poeti – i poeti veri – scrivano bene anche in prosa, non è una novità. Ma nel libro della Cavalli c’è qualcosa di più e di diverso. C’è una capacità di scoprire le risorse espressive insite nelle scelte lessicali, nei giri sintattici, nella prosodia, che rende alcune pagine assolutamente esemplari. Volete un motivo per studiare l’italiano? per innamorarvi della lingua italiana? Ecco l’attacco del brano eponimo, già apparso nell’antologia di Gianni Celati Narratori delle riserve (Feltrinelli 1992) con il titolo Ritratto.
Era sarda. Molti altri lo sono, ma lei se ne vergognava. Perché quel suo dialetto crudo non c’era modo di farlo mansueto. Le sibilanti feroci e le dentali a baionetta, le gutturali a tenaglia e le labiali a scoppio non sentivano ragioni, ma tutte impettite spesso si raddoppiavano pure; e poi le voragini improvvise di certe vocali. No, non c’era modo d’ingentilire quei fonemi armati, quella lingua guerrafondaia che mitragliava sillabe come mortaretti, tanto che veniva naturale chiedersi: “Se non è guerra, è Santa Rosalia o capodanno?”

Queste righe meriterebbero di essere commentate parola per parola: chi ha mai abbinato l’aggettivo armato al sostantivo fonema? Mi limiterò a un paio di riscontri. Innanzi tutto le dentali a baionetta. Parlando della sua visita all’Orto Botanico di Città del Messico, Emilio Cecchi ricorda le sculture che si incontrano «fra le baionette delle agavi e le ruote dentate dell’echinocactus»: ma l’analogia della Cavalli, dinamica e sinestetica, è più ardita, vien giù inattesa e affonda il colpo. In secondo luogo, il cambio di ritmo alla fine del secondo periodo, con la subitanea ellissi del verbo (e poi le voragini improvvise di certe vocali) che produce un effetto quasi di sincope. Non so cosa possa pensare di questa rappresentazione della pronuncia sarda, o meglio di una pronuncia sarda, chi è nato a Cagliari o a Sassari; un italofono continentale non può che esserne ammirato.
In altri casi, lo sforzo di cogliere con esattezza una postura psicologica dilata la sintassi a misure quasi proustiane, come in questo brano, costruito su un’analogia cesellata con un bulino da orafo:
La sua invidia non era operativa, cioè tale da farle compiere con volontà e premeditazione qualcosa di malvagio o criminoso, perché anche di questo lei si vergognava. Ma come quei sordi che per paura di parlare a voce troppo alta, incapaci di dosarne l’intensità, la riducono a un sussurro e così si illudono di nascondere il proprio difetto, ma anche esercitano un potere perverso che costringe chi ascolta a far la parte del sordo, ecco che lei, per timore che l’invidia la spingesse ad azioni troppo intense e temerarie, svelando così il suo forte dominio agli occhi altrui e suoi – cosa questa che temeva sopra ogni altra –, incapace di regolarne la dismisura, respingeva del tutto questo suo sentimento, opponendogli le caute virtù di una mitezza che, sdegnosa di ogni guerra, lasciava solo agli altri le intemperanze del carattere e gli azzardi dell’azione.
D’altro canto, la brama di comprendere non è astratta o gratuita. Se molte pagine sono dedicate a tratteggiare figure umane, conoscenze occasionali (Gattare) o presenze familiari, come la nonna (La strada nuova) o la madre (Ricordi di infanzia e di adolescenza), l’assetto complessivo di Con passi giapponesi è risolutamente lirico. La conoscenza perseguita consiste soprattutto nella conoscenza di sé, pietra angolare di ogni moralità e sapienza pratica: la quale a sua volta – come ha sottolineato Gino Ruozzi sul «Sole 24 Ore» – si lega indissolubilmente alla ricerca della felicità.
Non sono nata per essere ragionevole. Sono nata per amare, per essere felice, per odiare, per immaginare, per inventare, per capire e anche, di tanto in tanto per essere ragionevole, ma non devo essere ragionevole […] La ragione pretende la felicità. La ragionevolezza tende al possibile. La felicità non può essere catturata dal possibile.
L’attenzione della Cavalli si sofferma ora su aneddoti di vita vissuta, ora su situazioni ricorrenti o stati d’animo; ma la dimensione dominante (anche quando non palesemente scoperta) è sempre quello dell’auto-auscultazione, dell’interpretazione delle intime dinamiche dell’io. Che non riguardano solo la coscienza, ma investono anche il corpo: anzi, forse bisognerebbe dire che una cifra distintiva della Cavalli consiste proprio nell’annullamento del divario tra corporeità e pensiero, nel convergere – ora dolente ora gioioso, ora assertivo ora perplesso – di materia pensante e di mente incarnata. Infatti Con passi giapponesi parla spesso di amore, o meglio, di amori, senza mai fare nomi, amori e vagabondaggi; tanto che, per associazione, torna alla mente il titolo di un romanzo di Theodor Fontane, Irrungen, Wirrungen (letteralmente: «errori» e «complicazioni»), che anni fa Cesare De Marchi felicemente tradusse, forzando la semantica ma conservando la paronomasia originaria, Amori, errori (Mondadori, 1982). L’ultima pagina di Con passi giapponesi, forse la più simile a un petit poème en prose – un lunghissimo periodo ipotetico con una clausola che assomiglia al fiorire d’un bocciolo – è un davvero piccolo capolavoro.
D’altro canto, la tensione o la concentrazione non di rado si stemperano in notazioni più leggere, quasi vaganti; alcune improntate a una sottile vena satirica (come i brani sugli auricolari o sull’arbre magique), altre sorridenti e sentenziose, come questo elogio dei baristi capaci di anticipare le richieste dei clienti.
Prima o poi nella vita capiterà a molti di vedersi comparire davanti sul bancone quel che si vuole senza neanche aprire bocca. E con calma divina sorseggiare da quella tazza o da quel bicchiere la certezza fiabesca di esistere.
La vita è fatta di cose concrete. La poesia, anche. E la gloria delle parole sta nel riuscire a dare senso alla concretezza. Da questo punto di vista, Con passi giapponesi è un libro davvero istruttivo.