Teoria letteraria per robot
Tra le battute più famose del comico americano Sid Caesar, ce n’è una che dice: “Quello che ha inventato la ruota era un idiota. È quello che ha inventato le altre tre che era un genio”.
Quando all’orizzonte delle nostre grigie vite di scrittori del ventunesimo secolo è apparso ChatGPT, in base alle reazioni che abbiamo avuto ci siamo ben presto ripartiti in tre categorie: i sussiegosi, ossia coloro che si sono voltati dall’altra parte rituffandosi alla svelta nelle sudate carte, convinti che si trattasse nella peggiore delle ipotesi di un passatempo, nella migliore di un motore di ricerca un po’ ubriaco con cui scambiare quattro chiacchiere sorseggiando una birra solitaria al tramonto; i millenaristi – i vecchi apocalittici di cui parlava Eco – che hanno visto nella novità la minaccia suprema per l’umanità e spaventati a morte sono corsi a immergere i loro corpi nell’azoto liquido alla temperatura di –196°C, in attesa di essere resuscitati nel futuro; gli sciamani, quelli che hanno iniziato a interrogare il mezzo evocandone lo spirito superiore.
Personalmente, prima di farmi un’idea un po’ più precisa della cosa di cui stiamo parlando, credo di aver oscillato tra i sussiegosi e i millenaristi (senza però vagheggiamenti di crioconservazione). Solo di recente ho accarezzato l’idea di studiare un po’ più a fondo l’argomento, se non altro per mantenermi aggiornato, benché io sia spaventato, più che dal mezzo in sé, dalle grida degli sciamani. E posso dire che la mia posizione attuale rispetto a un tema così importante per il nostro presente è in parte espressa nella battuta di Sid Caesar.
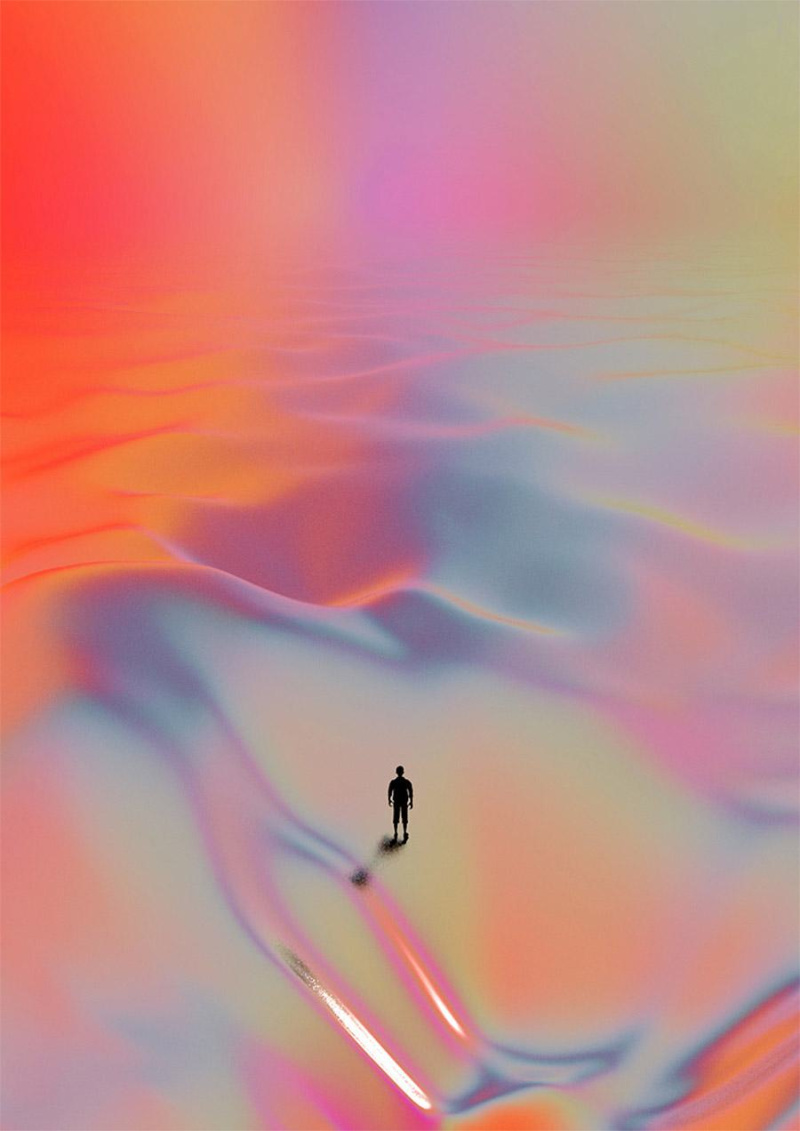
Dico “in parte”, perché in realtà non penso che chi ha inventato ChatGPT, ossia Sam Altman, sia un idiota. Tutt’altro. Penso però che il vero genio sta in chi perfeziona le singole intuizioni trovando loro dei reali e diffusi campi d’applicazione. E siccome se c’è qualcosa di cui sono profondamente convinto è che i sistemi d’intelligenza artificiale non sono una novità del ventunesimo secolo, ma ne sperimentiamo l’uso da tempo immemore (solo che ne siamo assuefatti al punto tale da averli inglobati nei confini di quella che consideriamo la nostra intelligenza naturale), credo che il dominio dell’uomo sulla macchina sia direttamente legato all’idea dell’utile. Per questa ragione, pur avendo lambito qualche volta in momenti di particolare debolezza emozionale le ragioni dei millenaristi, non temo che le macchine possano prendere il controllo su di noi.
Utile. Ecco, è questo l’aggettivo-muraglia che ci ha sempre impedito di soccombere al cospetto dei robot.
È stato perciò durante questa specie di corso di aggiornamento al presente che ho deciso di non lasciarmi sfuggire l’uscita di un volumetto edito da Bollati Boringhieri dal titolo Teoria letteraria per robot (trad. it. di Andrea Migliori), scritto da Dennis Yi Tenen, docente di letteratura inglese e comparata alla Columbia, nonché affiliato al Data Science Institute. Non si tratta di un manuale di ChatGPT a uso di scrittori e studiosi di letteratura, bensì di un intrigante viaggio nel passato attraverso cui ci viene svelata la natura dei rapporti tra l’homo fabulator e la macchina.
Ciò che da sempre l’uomo si aspetta dalle macchine è che esse gli migliorino la vita, semplificando il più possibile il suo lavoro e rendendolo più produttivo. Se questo vale per ogni tipo di lavoro, non si capisce perché non dovrebbe valere anche per il cosiddetto lavoro creativo. Ma si dirà che il lavoro creativo non ha confini certi come quello, per esempio, del calzolaio. Ciò che tenta di fare uno scrittore è decodificare il mondo, ossia cercare il filo di una matassa infinita. Per assolvere a un compito tanto improbo (ma la stessa irriducibilità della realtà è parte del compito a cui è chiamato lo scrittore, un compito che – va detto – è sempre destinato a risolversi in un fallimento più o meno elegante) egli è costretto a ricorrere a degli schemi semplificatori. La scrittura, la forma romanzo, è già di per sé una riduzione della realtà sensibile ed esperienziale, un paesaggio innevato racchiuso in una piccola sfera trasparente.
Gli schemi, appunto. Tenen ci dice che la riduzione delle molteplici nature dell’esistenza a schemi è da sempre l’orizzonte verso cui si rivolgono i pensatori. Cosicché gli strumenti di cui l’uomo si è servito nel corso dei secoli per decrittare la realtà hanno sempre svolto la funzione di schematizzare il mondo (un byte di otto bit è uno schema). Ma se il termine byte è stato coniato da Werner Buchholz nel 1956, molto più antichi sono altri esempi di schematizzazione della realtà. Come quello del matematico persiano Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī vissuto nel IX secolo, il cui difficilissimo nome sopravvive ancora nei nostri al-goritmi. O Raimondo Lullo, il monaco di Maiorca che nel XIII secolo, facendo ruotare dei cerchi concentrici siglati con delle lettere a cui erano collegati concetti filosofici, otteneva combinazioni capaci secondo lui di generare nuova conoscenza. O ancora l’I Ching, il Libro dei mutamenti della tradizione filosofica cinese. Per giungere alle Wunderkammer dei poeti barocchi tedeschi.
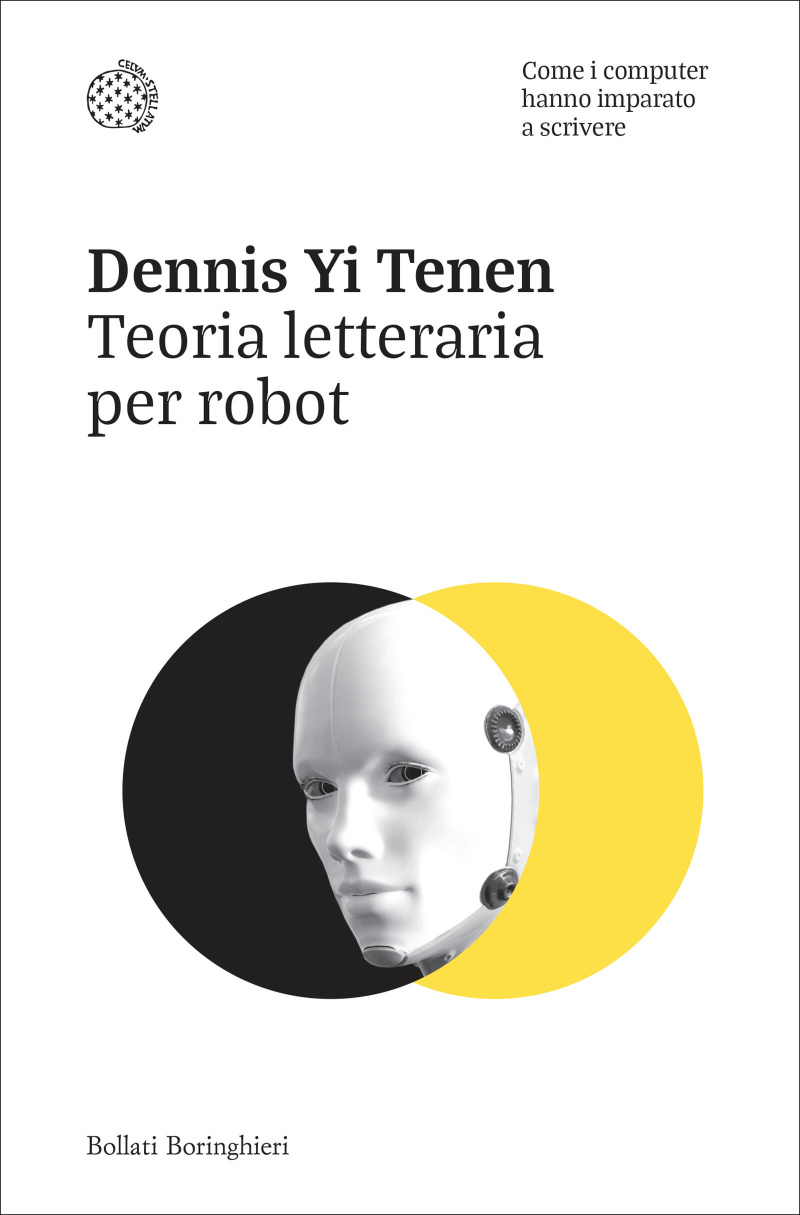
Considerando questi esempi, al di là dell’insospettabile passato comune che lega letteratura e informatica, salterà subito all’occhio un tratto: erano per lo più macchine da cui trarre dei responsi. Come in una sorta di grande autoillusione, l’uomo crea da sempre congegni capaci di compiere velocemente azioni combinatorie che siano in grado di attivare nella mente umana nuovi stimoli creativi. Rispetto all’intelligenza artificiale, l’uomo contemporaneo, dice Tenen, ha lo stesso atteggiamento di chi anticamente faceva girare le ruote per ottenere una profezia. Quando interroghiamo ChatGPT, o i suoi consimili, spesso ci lasciamo sedurre dalla combinazione. Gli esiti generati sono spesso così grotteschi da sembrarci artistici. “E se i colpi di genio di un meccanismo del genere si rivelassero privi di senso?”, si domanda Tenen. “Per controllare l’operato della macchina dovremmo essere più intelligenti di lei”.
Più che produrre arte, ciò che appare estremamente difficoltoso per la mente umana è maneggiare una certa mole di dati. È questo il compito principale che deleghiamo alla macchina. Essere più intelligenti di lei significa governare la meraviglia e la sorpresa che proviamo al cospetto di quelle inusitate combinazioni a cui siamo presto tentati di accordare una patente artistica. È un po’ come sobbalzare di fronte alla prova di astrattismo di un elefante pittore. Se allora anziché intelligenza artificiale (etimologicamente un composto di arte e fatto) cominciassimo a chiamarla intelligenza collettiva, forse – almeno a noi scrittori – farebbe meno paura.
In copertina, opera di Quentin Deronzier.







