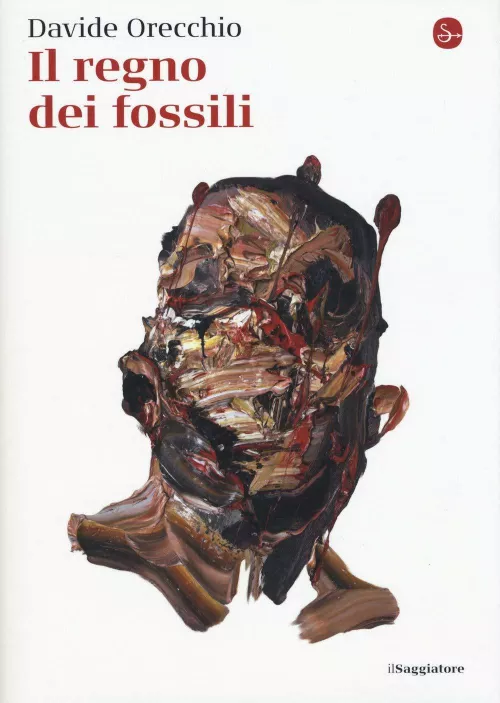Un viaggio nei libri di Davide Orecchio / Tra il documento e la grazia
Davide Orecchio, da sempre, lavora sulle biografie, sulla storia, sulla cronaca. Va negli archivi, entra nei documenti. L’autore romano prende la storia vera e la asseconda e la reinventa, l’azione della sua scrittura prende ciò che è avvenuto – in un tempo vicino o lontano o molto lontano – e lo porta davanti alla finestra, la luce serve ad aggiungere un elemento di finzione a una vita vera, miscelare la narrativa veloce al passo del saggio, il ritmo, a volte fiabesco, a volte poetico a quello documentale, composto da date, luoghi e fatti accaduti, fatti che sono nei libri (qualche volta) che abbiamo studiato, nei giornali (sempre più raramente) che andiamo leggendo. Alla base di tutto c’è però molto lavoro di ricerca, un lavoro serio da scienziato, da storico, a questi si aggiunge il lavoro dello scrittore, qui la cura per i fatti storici si fonde a quella per l’invenzione letteraria, generando romanzi e racconti che danno ai fatti accaduti un riverbero nuovo, aggiungendo l’elemento del punto di vista fantastico.
La scrittura di Davide Orecchio affascina, ma soprattutto persuade. A cominciare da Città Distrutte (edito prima da Gaffi, e ripubblicato nel 2018 da Il saggiatore), proseguendo con Stati di grazia (Il Saggiatore 2014), Mio padre la rivoluzione (minimum fax, 2017), fino al recentissimo Il regno dei fossili (Il Saggiatore 2019), nei suoi libri è presente la minuzia dell’archivista, la pazienza dello storico, lo sguardo curioso del giornalista, l’inventiva e la grazia e il ritmo dello scrittore.
«Il tempo non esiste se non per misurare. Al di fuori di noi c’è solo spazio. Maturare, crescere, cambiare: cosa c’entrano le lancette? Decomporsi e morire, non c’è calendario che lo spieghi.» (da Città distrutte)
Città distrutte partiva da sei biografie, sei storie che si frantumavano e si ricomponevano in una sospensione del tempo, un tempo ricreato da Orecchio nel quale dare conto degli accadimenti e inserire il tempo della narrazione. Tra le altre, la vita di Éster Terracina a Buenos Aires negli anni della dittatura, donna dal passo a cui quasi nessuno potrà ambire, la vedremo in carcere, torturata, preda e rifugio del suo torturatore, donna ribelle, capace con il solo fatto di esistere (e di riesistere) di generare una qualche speranza, una forma di salvezza. Più avanti Eschilo Licursi, un uomo di cui scopriremo le debolezze ma anche le capacità politiche, le sconfitte e le rinunce, staremo dento il fascismo, sentiremo la guerra, cii siederemo nei vagoni dove viaggia la solitudine, lavoreremo la terra con i contadini, esamineremo il socialismo per quello che è stato, per come non è riuscito a essere di più. Inseguendo il ritmo di queste biografie troveremo, ad esempio, un regista inconcludente e geniale, che non riesce a portare a termine il suo lavoro perché forse troppo è il peso che viene dalla terra d’origine, dalla sua personale storia familiare. Conosceremo Pietro Migliorisi, poeta, fascista, comunista, uomo tormentato e affascinante. E Betta Rauch con una vita di scrittura tra cose trovate e perdute, sul filo degli anni. Kauder con il suo sogno di lasciare libri che gli sopravvivano, accadrà o meno non importa, in mezzo si scrive, si vive. Sei biografie dentro un secolo, dentro il nostro passato, adeguate dal ritmo impressionante di Orecchio al tempo nostro, al nostro percepire l’evento; rese per quello che sono state, in equilibrio perfetto tra romanticismo e registro degli eventi.
«… dove iniziano ad affiorare gli scomparsi: gente sparita da mesi torna a farsi vedere e i testimoni assistono al ricomporsi delle fattezze.» (da Stati di Grazia)
Stati di grazia è un romanzo d’acqua e sale, di oceano, di terre attraversate e perdute. Un romanzo in cui l’autore pare essere toccato dalla grazia della scrittura, per come arrivano al lettore le parole, il loro suono, il contenuto. Quella grazia fa avanti e indietro come la marea che sale e scende, timida si ritrae, sfacciata irrompe sulla sabbia. Quell’acqua fa avanti e indietro tra la Sicilia e l’Argentina, tra Buenos Aires e Roma. Il romanzo racconta la storia di un uomo, di tante persone, della Sicilia degli anni cinquanta, dell’Argentina delle dittature. Un libro di abbandoni, di forti legami tra passato e futuro, di giri lunghissimi fatti dagli uomini per salvarsi, per perdersi o per ritrovarsi. La gente sparisce per provare a salvarsi altrove, qualcuno ci riesce, qualcuno non si riconosce, qualcuno non farà ritorno. Orecchio inventa un linguaggio in cui le parole suonano, dondolano, vanno e vengono, come fanno le persone. Dentro quel linguaggio dolce, rapidissimo, labirintico, quasi ipnotico, il fatto storico chiede il permesso di entrare dentro la fantasia. La memoria bussa alla casa dello scrittore, auspica di stare dentro un nuovo spazio. Davide Orecchio ha la premura di concedere al lettore un bivio, si arriva dalla strada in cui stanno i fatti, a sinistra si può proseguire col documento, a destra si può curvare nell’immaginazione. Le due strade si ricongiungeranno nel finale, o forse ancora più avanti, quando avremo modo di ripensare, di ritornare con la mente a una parola, a una frase.
«Questo è il mio treno ed è il treno della rivoluzione, io appartengo alla rivoluzione, il treno corre dove la rivoluzione è in pericolo, da sud a nord, da est a ovest, è come un continuo giro del mondo, io difendo la rivoluzione, con mia sorella abbiamo costruito tre bambole, due le abbiamo vestite di cotone e garza, la terza di canapa, la tata ha cucito i loro vestiti mentre nostra madre aiutava nostro padre nei campi, e insieme controllavano il lavoro dei contadini, ma ora non posso mostrarvi le bambole, c’è la rivoluzione. Sapete, io vengo da un regno di pecore e grano, Janovka è la mia patria di steppe senza limiti, mugicchi sconfinati, sono cresciuto con loro negli oceani d’erba della Russia del sud.»
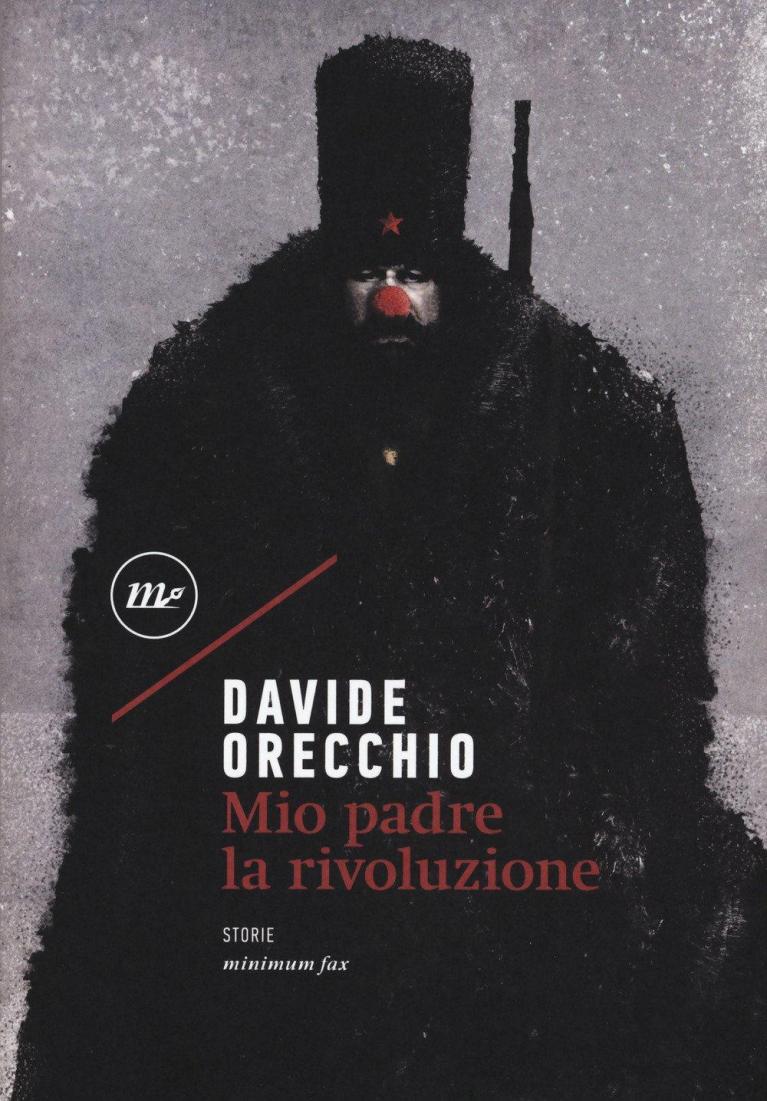
Mio padre la rivoluzione è composto da dodici racconti, la matrice è la rivoluzione, la madre è la sterminata terra sovietica, il padre è chi rielabora scrivendo. Per scrivere queste dodici storie, Orecchio ha di nuovo inseguito la documentazione, di nuovo ha fatto le scale delle biblioteche, i gradini dei treni dalla Russia alla Germania, di nuovo ha indagato e da quel punto, come abbiamo imparato, ha inventato. La frase qua in alto è nel primo racconto, da quel momento, da quella sintassi, siamo nelle mani dello scrittore, stiamo salendo sul treno della rivoluzione, che è storica, che è linguistica, che ci riporta al pensiero e ci rallegra come la prosa riuscita sa fare. Passiamo dalla prima persona alla terza, da un tempo verbale all’altro, il prima e dopo vanno sempre insieme, è il passo delle rivoluzioni. Troveremo un racconto fatto solo di citazioni, uno in cui parla Trockij. Trockij che è stato il treno, i binari, il ferroviere, che non dormiva mai, che andava ovunque, che parlava con tutti, che li tirava per la giacca. Lenin, naturalmente, bambino, ragazzino, giovane e adulto; e Stalin, e Hitler. Viaggeremo su un treno insieme a loro due, in un racconto che farà avanti e indietro tra Mosca e Berlino, in cui Orecchio saprà parlare del tedesco e dire del russo, e dirci le insidie della fascinazione, di come il potere si manifesti piano, a nostra insaputa, di come ci avvolga, ci incanti e molto tempo dopo ci distrugga.
Troveremo Togliatti, staremo con un giornalista siciliano, scopriremo libri inventati sopra manuali esistiti, Ci innamoreremo di nuovo, per sempre, di Gianni Rodari, che viaggia sul Volga, che lui (proprio lui) si pone il problema della fantasia. E con Rodari altri scrittori, poeti, molti bambini, racconti con diverse strutture, anche in forma di lettera. Bob Dylan, che si chiama Zimmer Man, e comincerà a suonare, perché la storia russa glielo domanderà, glielo sussurrerà. Mio padre la rivoluzione commuove laddove ci si era già commossi, dà speranza dove abbiamo già sperato, sopra vecchie speranze dei nostri padri, pone Orecchio al centro della narrativa italiana come uno degli scrittori più innovativi; capace di ricondurre il lettore in cose accadute come se fossero nuove. Leggendo per noi cose che non avremmo letto, mostrando immagini che non avremmo notato, mettendo la prosa – che è un fatto di vita – sopra le morti.
«Volere il bene è un fatto raro del mondo.» (da Il regno dei fossili)
Con Il regno dei fossili, uscito solo da qualche settimana, la scrittura di Orecchio fa un altro passo avanti. Il ritmo e il suono delle parole comandano, come nei libri precedenti, ma chi detta le regole è la fantasia. Con questo romanzo Orecchio compie un’operazione di composizione narrativa che lo mette a metà tra un poeta molto bravo, magari un russo, per capacità evocativa e uno scrittore come DeLillo, per capacità di costruire il futuro e immaginare retroattivamente la storia.
La storia sta alla finestra, guarda dentro la casa della fantasia, ogni tanto chiede il permesso di inserirsi nell’immaginario, e domanda: Posso essere raccontata? Puoi tu scrittore farlo per me? La lingua è più forte degli eventi, la sintassi domina i diari, le somiglianze non possono far altro che andare a braccetto con le differenze. La storia è quella del nostro paese, è quella di Giulio Andreotti, dei suoi preti, dei suoi diari, della sua intelligenza, del suo racconto di sé. È la nostra Repubblica, è il 1948, è il dopoguerra, è il Parlamento che comanda, che domina, è Giulio che tiene le fila e tiene un diario, e controlla e pensa e decide, e si commuove (dice), e soffre (sostiene) e osserva e pensa al paese (afferma). È il nostro paese negli anni di piombo, sono le Brigate rosse, gli omicidi, i rapimenti, è Aldo Moro, è il cosa facciamo (la Dc), cosa dovremmo fare (il parlamento), cosa non si farà (Andreotti, Cossiga e gli altri). È il memoriale di Aldo Moro conservato fino a un futuro lontano pronto a essere letto, questa volta sì, per l’eternità. È una ferita mai rimarginata, è una vendetta.
«[…] e Andreotti annuisce quando Moro diceva Non ho elementi ma sensazioni che m’inquietano molto; e Andreotti gli chiese Hai ancora il tuo zaino?, ed è colmo o deserto?» (da Il regno dei fossili)
Nella casa della fantasia c’è una bambina, Albina, poi ragazzina, poi donna e studiosa. Albina ha una casa, di fronte ci viene in vacanza Andreotti. Albina ha un incidente grave, a cui sopravvive, per parecchio sarà costretta a camminare, piegata in avanti. Si ingobbirà, il nonno le dirà che ha la gobba come il famoso vicino. Chi è Andreotti? Sarà la domanda, e poi diventerà le domande e sarà la vita di Albina. La ragazza cresce, ed è bella, e studia, e va a Roma, e sempre vivrà in questo parallelo con Andreotti, come se la gobba da bambina racchiudesse un destino comune, una sorte che ripropone Giulio e i suoi occhiali dentro la vita di Albina, negli incontri che capiteranno, in quelli che non avverranno.
Orecchio inserisce nel romanzo due chiavi. La prima è un triangolo amoroso che occupa la parte centrale del testo. Albina vive con un ragazzo che sta terminando gli studi, che vorrebbe concludere con una tesi su Giulio Andreotti, tesi che non riesce a ottenere, ogni professore pare rifiutarla, la domanda è perché? Perché del triangolo fa parte un docente di storia, per il quale Albina prova attrazione e schifo, dal quale fugge e poi ritorna. Da lui va a chiedere aiuto per la tesi del suo ragazzo, e lui in maniera scientifica e ossessiva farà in modo che non l’ottenga. La storia entra in questo rapporto a tre facendo capolino con gli inserti diaristici di Andreotti, che Orecchio chiama l’orfano, così come Abina è l’orfana putativa, così come l’amante più vecchio è definito il padre. Il diario segue gli eventi, li anticipa, li conduce, perché è il diario di Andreotti, un diario destinato al comando.
«La gente fa chiasso nelle case di quelli che muoiono, non vuole imparare la morte, ma nessuno di noi sa la sua età, tu non hai sette anni, la tua età e quanto ti resta da vivere; quindi impara a morire, impara il distacco da questa terra.» (da Il regno dei fossili)
La seconda chiave è il Progetto Clarke, ed ecco l’eco DeLilliano. Creazione (manco a dirlo) dagli americani che si pongono sopra Dio (il timore di Andreotti). Un progetto che garantisce la conservazione dei corpi dopo la morte, fino al giorno in cui la scienza non sarà in grado di tenere in vita gli organismi, perciò i muscoli, il sangue, i tessuti da un lato, ma la memoria, quello che sta nel tracciato tra mente e anima, dall’altro. Il cuore, la coscienza, il peccato in entrambi i lati. Andreotti aderisce, naturalmente, e iscrive Aldo Moro per perdonarsi il fatto di non averlo salvato, ma Andreotti non conosce il futuro, Aldo Moro, morto da prima forse può indirizzarlo. Il progetto da tenere nascosto ai comunisti, ma che è meglio che rimanga sconosciuto a Dio. Il Progetto Clarke sarà il territorio dove di nuovo Albina e l’orfano si ritroveranno. Ed ecco che i documenti sui quali Orecchio ha sempre lavorato vengono visti in una prospettiva futura. Ovvero: cosa accadrà? L’archivio starà nel futuro perché gestisce il passato, lo indirizza e lo perpetua. Albina e il memoriale di Aldo Moro hanno la stessa rilevanza, perché in un romanzo tutti gli elementi si tengono. In questa nuova impalcatura, Orecchio, mette insieme la vita e la morte e immagina un dopo morte; se il poeta Raboni affermava che i morti non se ne andavano perché restavano nella nostra memoria, Orecchio immagina un futuro dove solo alcuni morti, guarda caso quelli che hanno deciso la vita di tanti, possano garantirsi una durata, un ritorno.
«Aldo Moro disse Ora ti leggo il Memoriale, anzi te lo leggo per sempre […]» (da Il regno dei fossili)
Ciò che accomuna Il regno dei fossili ai libri precedenti di Orecchio è la tenuta. L’archivio e l’immaginazione hanno la stessa valenza, ma la prosa mobile di Orecchio, l’utilizzo sempre nuovo della sintassi, delle preposizioni, della punteggiatura, sposta di continuo i rapporti di forza tra memoria storica e ricerca letteraria, rendendo i suoi libri nuovi oggetti linguistici nei quali ritrovarsi, un po’ smarriti un po’ luminosi, salvati dalla parola scritta.