Per una grammatica dell'interiorità / Ascolto
Dare all’ascolto una configurazione sensibile, circostanziata per tempo e luogo, per me è riandare ad alcune voci e ad alcuni suoni dell’infanzia. Il risveglio, in certe albe di novembre, nel buio della stanza, avveniva per un canto che saliva dalla strada, un canto corale che presto si affievoliva allontanandosi e che lasciava, nel sopravvenuto dormiveglia, una dolcezza inattesa, insieme con l’immaginazione della prima luce che già frugava nelle strade: erano le donne che andavano su un carro a raccogliere le ulive, avevano voci leggere e come di rintocchi su vetri invisibili, cantavano per sentirsi insieme, strette, dinanzi alla fatica del giorno che stavano per affrontare (avrei saputo dopo a quali livelli di sfruttamento quello e altri lavori bracciantili fossero sottoposti).
Risento altri suoni. L’onda di una nenia, ad esempio, anch’essa di coro femminile, che mi giungeva in certi pomeriggi se mi avvicinavo in bicicletta verso le mura di una masseria: altre donne che nell’ombra di un portico, standosene in cerchio, infilavano le foglie di tabacco e cantavano con voci calde di meriggio, rispondendosi nelle stornellate o levandosi acute e spegnendosi nella malinconia di un amore privo di risposta. Poi c’era il grido mattutino, un grido rotondo, strascicato, tutto vocalico, degli ambulanti che invitavano a limare forbici e coltelli o a impagliare sedie o a riparare pentole e orcioli.
L’ascolto delle voci introduceva a una rappresentazione del mondo, del lavoro nel mondo, e di un sentire che cercava il canto per dirsi (si cantava molto nelle strade, nelle botteghe e nelle case dei paesi poveri, in quegli anni del dopoguerra).
Di lì a poco avrei appreso un’altra forma di ascolto: quella richiamata da voci che erano spente nella parola scritta e si rianimavano appena gli occhi componevano frasi scorrendo lungo la scrittura e aprendo nella mente paesaggi. Avevano uomini e donne quei paesaggi, e parole che prendevano un suono, un suono che insieme apparteneva a loro e stava dentro di te, modo d’essere della tua immaginazione.
Avrei anche appreso presto che c’erano voci decisive, voci che se ascoltate potevano dare alla propria vita una direzione o un’altra. Si trattava di sapersi mettere in ascolto perché stavano dentro di sé quelle voci: non sarebbe accaduto come a Saul sulla via di Damasco o ad Agostino nell’orto, una sera. Erano solo voci interiori, che si trattava di sapere ascoltare. A che cosa avrebbero chiamato quelle voci? A quale cammino e avventura della vita avrebbero invitato?
Mettersi in ascolto di sé e del testo, lungo gli anni, mi è poi apparso un compito unico, inseparabile. Il passaggio alla scrittura poteva avvenire solo da questa congiunzione.
L’ascolto. Quando ho incontrato e frequentato Edmond Jabès, e tradotto i suoi libri, ho sentito come l’ascolto fosse per lui origine e cuore della parola: l’esperienza del deserto lo aveva confermato in questo. Sulle sabbie del deserto si può sentire, diceva, «il silenzio vero, crudele e doloroso», un silenzio che «sembra rimproverare perfino al cuore di battere». Nel passaggio alla scrittura Jabès aveva dato al vocable, al «vocabolo», la sua radice propria, cioè il legame con la voce e con la vocazione, il movimento che lo porta dal silenzio verso la parola. Così scrivere era passare dall’ascolto di una voce alla parola che si apre a un altro ascolto, quello del lettore che diviene con il libro, con la sua voce.
L’origine della poesia pone l’ascolto come soglia da cui muove la parola e con la parola il ritmo stesso. C’è un prima della lingua: suono, canto, voce che l’immaginazione mitica ha raffigurato nelle Muse. Gli archetipi del discorso dell’ispirazione mostrano il poeta in stato d’ascolto: costui è «interprete degli dèi» – secondo quanto nello Ione di Platone possiamo leggere – perché sa ascoltare quel che non è ancora linguaggio, quel che precede la lingua degli uomini. La stessa manía, che è all’origine del dire poetico, non è che una particolare, eccentrica, tutta corporale ed ebbra capacità d’ascolto. Così il passaggio dal suono della voce animale – il grido della pernice per il poeta Alcmane – alla lingua che si compone nel verso richiede una disposizione all’ascolto: ascolto di quella natura che non ha lingua ma solo suoni, canti, fruscii. Qui ha radice la mímesis del poeta.
Il dettare delle teorie medievali implica anch’esso un ascolto. Si tratta di cogliere dentro di sé una voce che è come il suono dei sensi, un suono profondo, dolce, o talvolta tremante, o impetuoso: il suono di un ospite della propria interiorità chiamato «Amore».
L’origine del linguaggio umano muove da un ascolto. È Vico che nella seconda parte della Scienza nuova dedicata alla «sapienza poetica» segue il movimento che dall’ascolto – e dallo sguardo dei primi uomini verso il cielo – porta verso la lingua: dal suono della natura – il fulmine! – al turbamento dei sensi e alla risposta degli stessi sensi con il ritmo del corpo che mima la paura per il pericolo e la gioia per il suo superamento (nascita del «verso eroico» e del canto), fino alla parola che indica e significa. Un ascolto si fa lingua, tempo della lingua.
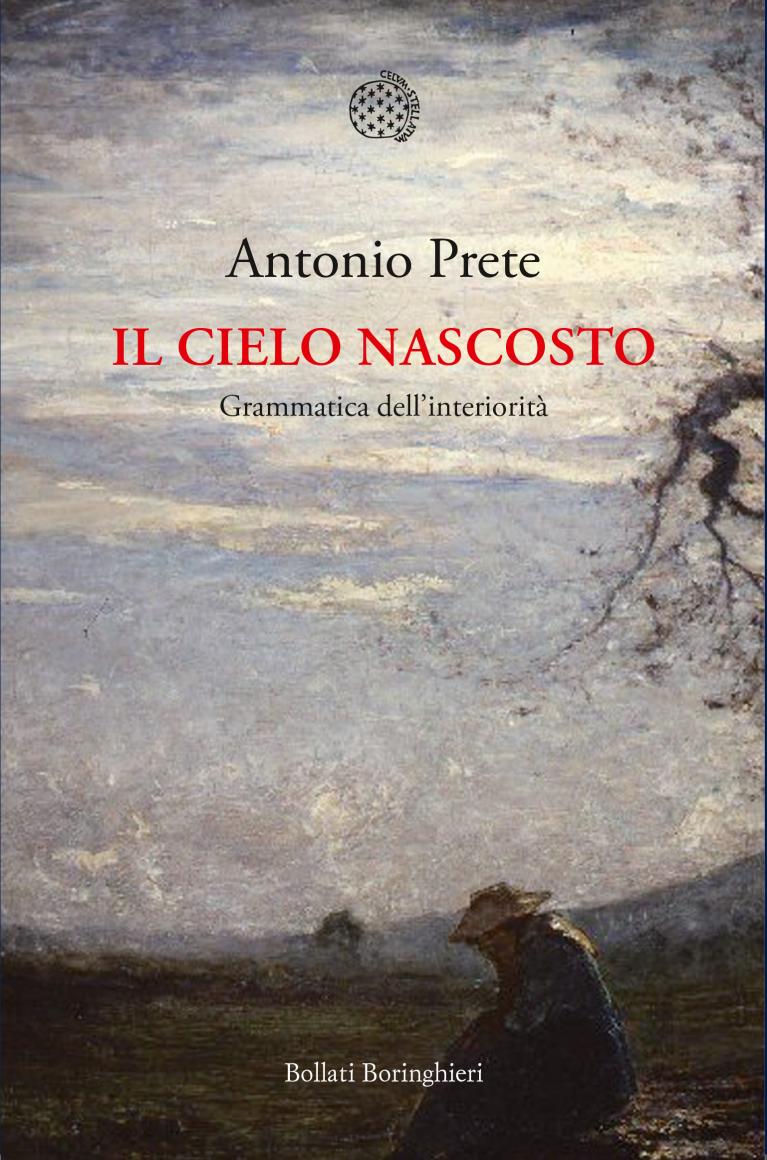
La meditazione dei romantici sulla nascita del verso riconosce come principio della poesia la disposizione all’ascolto: Keats dice d’avere avuto come lingua madre «il ruggito del leone» (the lion’s roaring) e «il grido delle tigre» (the tiger’s yell). Per Hölderlin l’educazione del poeta, l’educazione materna del poeta, ha come fonte i bisbigli del bosco. Lo stormire del vento nella siepe è per Leopardi il passaggio all’estrema, insostenibile, comparazione di quel che più non c’è («le morte stagioni») con la stagione «presente e viva», con il suo suono. Ascolto che porta al naufragio del pensiero dinanzi al tentativo di com-prendere l’infinito. Un naufragio che è naufragio della lingua poetica stessa, la quale non può dire l’infinito. Una dolcezza, tuttavia, sopravviene, tutta corporea, a trattenere i sensi dal loro perdersi nel vuoto dell’irrappresentabile, nell’abisso dell’indicibile: è quel «m’è dolce», che sta nel cuore dell’ultimo verso («E il naufragar m’è dolce in questo mare»). Dall’ascolto di quel che non è parola – il vento – alla percezione di una dolcezza che è oltre la parola, che è oltre ogni azzardo del dire.
Anche Baudelaire, che nel giovanile poème La voce aveva messo in scena l’ascolto di una voce come principio di una vocazione alla poesia, in Corrispondenze mostra il poeta in ascolto di quelle confuses paroles, sussurrate nel tempio della Natura, per la cui decifrazione occorre passare attraverso un altro ascolto, quello che si dispone a percepire il rispondersi di suoni colori profumi: appunto, le correspondances che trascorrono nel corpo vivente della natura.
Mi è accaduto spesso di riflettere su due narrazioni relative all’ascolto. Gli uccelli che si radunano sugli alberi e stanno in ascolto della parola di frate Francesco: interruzione del canto e del volo per l’ascolto di una voce umana che nel suo timbro, nei suoi toni, fa sentire l’appartenenza di ogni specie vivente alla madre terra, al suo ritmo, alla sua vita. In questa percezione c’è come un incantamento dei sensi, insieme al piacere della sosta nella quiete del visibile, dell’udibile. E ancora: un filosofo solitario, Amelio, che nell’operetta leopardiana Elogio degli uccelli si mette un mattino, in campagna, in ascolto del canto degli uccelli e prende a trasformare quell’ascolto in una scrittura che è certo un elogio ma anche una meditazione sui sensi dell’uomo e sui sensi degli uccelli: l’armonia del canto, la leggerezza del volo, la vivacità del movimento, la vista dall’alto, la letizia del trascorrere di luogo in luogo, disegnano un’alterità che all’uomo – ai suoi sensi intorpiditi e resi opachi e atrofici dall’incivilimento e dall’abitudine – appare come la linea azzurra dell’impossibile. Eppure proprio questo orizzonte può tenere viva nell’uomo una libertà del sentire, una leggerezza del pensiero, un azzardo dell’immaginazione. La bellezza e l’armonia di quel che è oltre la nostra finitudine ci appartiene, è anch’essa ritmo di quella nostra finitudine. L’ascolto del canto è respiro del nostro sentire.
Un’ultima notazione sull’ascolto. Roland Barthes, che ha ripercorso i passaggi essenziali di una «voce» ascolto – dalla decifrazione di indizi e segni sonori all’ascoltare come verbo «evangelico per eccellenza», dall’ascolto della «confessione» nella tradizione cristiana all’«ascolto psicoanalitico» come si definisce in Freud e in Lacan – ha un passaggio che attiene al tema dell’interiorità, osservato nel suo aspetto religioso:
L’ascolto è anche un sondare. Non appena la religione s’interiorizza, con l’ascolto si sonda l’intimità, il segreto del cuore: la colpa, il peccato. Una storia ed una fenomenologia dell’interiorità (che forse non esiste ancora) dovrebbe affiancarsi ad una storia e ad una fenomenologia dell’ascolto in quanto proprio all’interno della civiltà della Colpa (la civiltà giudeo-cristiana, diversa dalla civiltà della Onta) l’interiorità si è costantemente sviluppata. I primi cristiani ascoltano soltanto delle voci esterne, quelle dei demoni o degli angeli; solo poco a poco l’oggetto dell’ascolto s’interiorizza al punto di diventare pura coscienza.
Qui l'intervista ad Antonio Prete.
Da Il cielo nascosto. Per una grammatica dell'interiorità, Bollati Boringhieri 2016. ©2016 Bollati Boringhieri editore, Torino.







