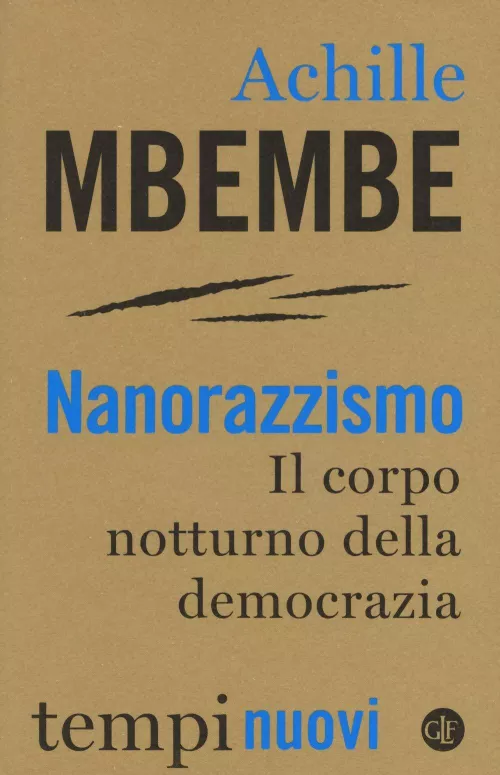Muri / Brecce nel mondo murato
Qualche esempio. Per avvicinare un’immagine che potrebbe risultare fumosa.
“Brecce nel mondo murato”, questa è l’immagine. Viene da lontano, da pensieri arrischiati (Kafka, Hannah Arendt), ma entra nei nostri giorni impalpabili, parla di questa “Età dei muri”, del desiderio di scavalcarli, dell’impeto di abbatterli, o semplicemente di aprire, nella loro superficie compatta, fessure, spiragli, bocche d’aria, o uno stretto pertugio da cui si possa vedere un pezzo di cielo.
Non è un’idea, e neppure un concetto. È il movimento di un gesto, l’imponderabile insurrezione della nostra libertà.
Qualche esempio, allora.
Il primo, che mi porto appresso da tempo come una stella d’orientamento, è il suono esile di un fischio. Cosa da poco un fischio, eppure può tenerci in vita.
Una giovane donna, internata nel lager di Birkenau, “landa desolata, dove le ombre dei morti sono schiere, dove i vivi sono morti”, elabora una sua personale strategia di sopravvivenza (lo racconta Giuliana Tedeschi in C’è un punto della terra. Una donna nel lager di Birkenau, Giuntina, 1988). Alla morte quotidianamente incombente, resiste in un modo davvero semplice, che, ai miei occhi è parso stupefacente: fischia interi brani di Mozart, un Mozart dimesso, in un’esecuzione inevitabilmente sommaria. Quel leggero cuneo d’aria tra labbra appena schiuse, celato sotto la cappa della prigionia, diventa per lei il tracciato di un’evasione, una crepa nel muro, che sfugge ai carcerieri, solco o scalfittura quasi insignificante, capace però di forzare i confini di Birkenau. Taglia filo spinato, scavalca reti di recinzione, si sporge fuori dallo spazio del lager, mostrando in lontananza il mondo a cui Giuliana è stata strappata. Quando il suo fischio smuove l’aria del campo sibila la speranza. È un suono sottile, ma tenace. Vita che resiste.
Un secondo esempio, restando su Mozart, ma in una cornice assai diversa. Non Birkenau, ma Algeri. Più di dieci anni dopo. E non il soffio sommesso di un fischio, ma un’intera orchestra impegnata nell’esecuzione del “Don Giovanni”. È il febbraio del 1956, la guerra di liberazione algerina incendia il paese, l’avventura coloniale francese sta deflagrando, pochi mesi dopo “la battaglia di Algeri”. Un teatro della città programma il Don Giovanni. L’iniziativa desta scalpore. Ci si chiede:
“Ma come! Mozart in mezzo alla storia più folle e pressante? Mozart di fronte all’Algeria piena di odio e alla Francia che rassegna le dimissioni?”. Risponde Albert Camus in un articolo sul settimanale “L’Express” del 2 febbraio:
“Quando il mondo si ripiega su se stesso, quando le strutture della civiltà vacillano, è bene tornare su ciò che nella Storia non si piega”.
Per Camus non è affatto scandaloso portare sulla scena il Don Giovanni nell’Algeri insanguinata del ’56, al contrario: gli appare necessario. La sua musica è “sorgente perpetua di gioia fresca, di libertà che insegna … e ancora oggi ispira al contempo la nostra resistenza e la nostra speranza… La nostra vita e i nostri lutti vi trovano allo stesso modo giustificazione”.
Mozart fa breccia nel “mondo murato” dell’odio e della guerra. Certo non lo abbatte, forse soltanto lo graffia. Niente di più. Ma spezza, provvisoriamente, l’assedio della violenza. È respiro; finalmente entra un po' d’aria dentro polmoni soffocati.

L’ultimo esempio sta appena a lato della nostra immagine. Nessuna “breccia nel mondo murato”. Occorrerebbe una forza che il “sospettato” Charlie Chaplin, “piccolo pover’uomo”, non ha. È lui il protagonista del nostro ultimo esempio.
Il “sospettato”, secondo l’espressione di Hannah Arendt, il paria, l’escluso, il marginale, può soltanto eludere, con effervescente astuzia, i custodi del potere. Ruota vorticosamente il suo bastoncino, come se si disponesse a infilzare, con la sola arma dell’ironia, la corazza, o il muro, della loro arroganza. Il “sospettato” si muove leggero come una farfalla; il rappresentante della Legge è pesante e goffo. Ma il “sospettato” non è in grado di fronteggiare i guardiani del muro. Verso di loro si atteggia, dice Hanna Arendt, “come ci si ripara da un acquazzone in buchi, rifugi e fessure che si trovano tanto più facilmente quanto più ci si fa piccoli”.
Celarsi fa parte della “ribellione dei piccoli”. Il caratteristico passo ondeggiante del “piccolo” Charlot, che ha suscitato l’ilarità del mondo intero, il fare incerto, perplesso e circospetto, è dovuto al fatto che sembra sempre sul punto di darsela a gambe. Sempre di passaggio, sempre sulla strada. Costantemente all’erta.
Non una breccia nel muro dunque, ma “buchi, rifugi, e fessure”. La risata provocata da Charlot contiene, di fatto, una lezione di disincantato, e amaro, realismo. La sua storia non ha epilogo: il “sospettato” è destinato a restare tale, il poliziotto non può che inseguirlo indefinitamente. Stasi assoluta, nonostante i convulsi movimenti degli attori sulla scena. È come se si muovessero restando fermi, agitandosi attorno alla porta della Legge, aperta, ma invalicabile, come si legge in un racconto di Kafka.
Il muro sembra insormontabile. L’astuzia del piccolo Charlot per aggirarlo non basta più. La sua stella è destinata a declinare, osserva Hannah Arendt; sul finire degli anni trenta, fa irruzione una nuova favola, quella di Superman. Con lui, le masse urbane, sfiancate dal decennio della “grande depressione”, prosciugati i loro sogni, possono volare, e immaginare di tenere in scacco il male.
Vorrei aggiungere un’altra figura sollecitata da una piccola esperienza fatta in questi ultimi giorni: le “sardine” a Piazza San Giovanni, a Roma, sabato 14 dicembre. Una bella “breccia nel mondo murato”. La piazza, e cioè lo spazio aperto, come solo punto programmatico (lo ha dichiarato Santori, il loro coordinatore). Basta esserci, e dire di esserci. C’erano i giovani, i bambini, le mezze età, e i vecchi, e anche qualche carrozzella. E molte donne. Tutti abbastanza incuriositi dagli altri. Molti fantasiosi cartelli fatti in casa, e poche parole, male amplificate, almeno nel punto in cui mi trovavo. Poche parole, come può accadere a chi viene da un lungo inerte silenzio, e si accontenta di guardare, e di tornare a sfiorare gli altri. Una sorta di “grado zero” della politica, ma l’ingrediente essenziale.
A San Giovanni non c’era un centro che catalizzasse l’attenzione, non c’era il protagonismo del palco, tutto scorreva in basso, come una libera corrente senza vincoli o strettoie.
Dico tranquillamente che mi è piaciuto, come mi è piaciuto ricordare il fischio di Giuliana a Birkenau, o il suono gaio di Mozart nella cupa Algeri del ’56, o le astuzie del piccolo Charlot. E mi piacerebbe parlare ancora di muri e di brecce, di piani e di sogni d’evasione, e cioè del nostro respiro.
Ricordo che sulla piazza di “Doppiozero” (30 gennaio 2019) Enrico Manera ha portato una bellissima riflessione, che è anche un punto di prospettiva su tutti, o quasi tutti, i muri che oggi ci opprimono e ci separano. Poi, non si può non ricordarlo, c’è il libro di Carlo Greppi, L’età dei muri (Feltrinelli, 2019), un’ancora, che attorno ai muri raccoglie e legge molte sequenze significative della nostra storia (Manera gli dedica una prolungata attenzione). L’emblema del muro si sviluppa lungo tutto l’arco della nostra storia.
Riporto infine un auspicio, poco più che un fischio, o un sibilo di speranza: quello di Achille Mbembe (Nanorazzismo. Il corpo notturno della democrazia, Laterza 2019). “Avremo davvero bisogno di una lingua che perfori, punga e scavi come un trapano … che costantemente roda il reale. La sua funzione non sarà solo quella di far saltare le sue serrature, ma anche di salvare la vita dal disastro che incombe … la lingua e la scrittura dovranno proiettarsi costantemente verso l’infinito dell’esterno, sollevarsi per allentare la morsa che minaccia di soffocare la persona soggiogata e il suo corpo”.